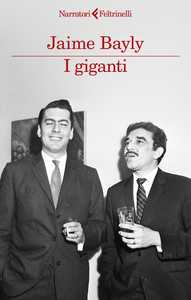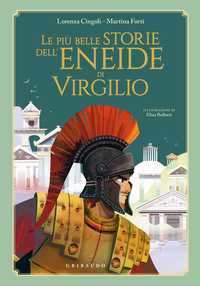Umberto Galimberti: Il confine della vita davanti alla legge
29 Aprile 2002
Giudici della Prima Corte d’appello di Milano hanno assolto l’uomo che nel giugno del 98 staccò la spina alla macchina che teneva in vita la moglie, da tempo in coma irreversibile. In primo grado l’uomo era stato condannato a sei anni, in secondo grado il sostituto procuratore della Repubblica di anni ne aveva chiesti nove, ma si era anche augurato che all’imputato fosse concessa in futuro la grazia. La Corte d'appello, infine, ha mandato assolto l'imputato perché «il fatto non sussiste» in quanto ha considerato «morta» la donna in coma irreversibile. Da questo percorso giudiziario, che ho voluto qui riportare per sommi capi, emerge la grande incertezza che attanaglia tutti noi di fronte al problema dell’eutanasia che l’Olanda, primo paese in Europa, giusto un mese fa ha legalizzato, sollevando l’ennesimo e animato dibattito fra favorevoli e contrari. Perché tanta incertezza e tante discussioni intorno alla morte assistita, chiesta, invocata, e talvolta, come in questo caso, accordata, quando il paziente è vivo solo per le leggi biologiche dell’organismo, in quella notte buia della coscienza che non attende più nessuna alba? Perché è incerto il nostro concetto di «vita», che oscilla paurosamente tra la vita anonima dell’organismo e quella personalizzata dell’individuo che, nelle residue possibilità biologiche del suo corpo, non riconosce e non lascia riconoscere alcuna immagine di sé. Sulla prima posizione è attestata la Chiesa cattolica e la convinzione di molti credenti che, partendo dal concetto che la vita è un dono di Dio, ne chiedono il rispetto fino all’ultimo respiro. Nella mia profonda incertezza e incapacità a prendere posizione su questo tema, devo dire che l’argomento della Chiesa cattolica è troppo generico fino ai limiti dell’insignificanza, quando non addirittura decisamente materialistico. Che cos’è, infatti, la vita? La semplice animazione della materia, come pare di poter dire per certe esistenze tenute appunto «in vita» dalla strumentazione tecnologica? O il rispetto dell’individuo, della sua coscienza, della sua deliberazione che proprio il cristianesimo, e non altri, ha eretto a valore indiscusso, trasmettendo questo riconoscimento alla cultura laica che lo ha assunto a principio della sua organizzazione sociale? Il problema dell’eutanasia non mette in gioco il valore della «vita» che prolifera ovunque, ma il valore dell’«individuo»: sia dell’individuo che, in certe condizioni può non ritenersi più degno di sé, e può quindi sentirsi in diritto di decidere di por fine a un’esistenza in cui più non si riconosce, sia dell’individuo che, come in questo caso, invece della persona amata con cui ha condiviso la vita, si trova davanti un puro processo biologico che, grazie all’assistenza tecnica, procede nella sua anonima irreversibilità. A questo punto sorge la domanda: perché la morte fatica così tanto a entrare nel circuito dell’amicizia, dell’amore e acquistare così un volto sereno? Perché bisogna morire solo per cause organiche sotto l’unica giurisdizione della scienza medica? La morte è un evento che riguarda solo il mio organismo oppure riguarda la mia vita, che non è fatta solo di organi fisici, ma soprattutto di vissuti, di amori, di amicizie, di stili, di rispetto di sé? L’organismo, certo, è la condizione della vita, ma la vita non si risolve nel buon funzionamento dei miei organi. E quando gli organi non funzionano, per morire bisogna attendere solo il loro collasso? O si può anche chiedere a chi legifera di rivisitare la nozione di morte connettendola strettamente alla nozione di vita che, come ognuno percepisce, è una nozione decisamente più alta, più ricca, più mia, di quanto non sia la nozione di organismo noto solo alla competenza medica. Il problema dell’eutanasia è tutto qui. La morte mi riguarda o riguarda solo il mio organismo. Questo pensiero che accompagna la vita di tutti noi, che limita la nostra progettualità, che ci fa compiere certe scelte a una certa età e non a un’età più avanzata, questo pensiero della fine dei nostri giorni che coinvolge aspettative e speranze, progetti e rimpianti, affetti e stili di vita è una faccenda da affidare alle sorti della materia di cui siamo fatti, o è una faccenda su cui anche noi possiamo intervenire, proprio perché coinvolge quel che siamo e non solo quello di cui siamo fatti? Quando ci emanciperemo da questo grossolano materialismo che, cadenzando la vita sulle sorti della materia, ci espropria da quel che la vita ha significato per noi, dello stile che le abbiamo dato, dell’impronta che le abbiamo conferito, per consegnarci irrimediabilmente a quell’evento non nostro che è la morte organica? Perché bisogna morire da soli? Perché la morte non può essere condivisa con chi si è condivisa la vita? Non è forse nell’aver allontanato troppo la morte dalla vita, non è forse nell’averla considerata un fatto estraneo che sopraggiunge a nostra insaputa e soprattutto senza la nostra partecipazione, la ragione profonda per cui noi temiamo così tanto la morte? Essa è terribile come tutto ciò che è estraneo, anzi come il massimamente estraneo. E in questa estraneità che inesorabilmente ci raggiunge si nasconde il suo volto terrificante. Alla luce di queste riflessioni possiamo pensare che l’uomo - il quale, suppongo con estrema lacerazione, ha staccato la spina alla macchina che manteneva il decorso biologico del corpo della sua compagna di vita - abbia potuto fare il suo gesto perché uno scenario di compassione e di amore allontanasse lo scenario angosciante dell’estraneità che accompagna sempre la morte quando a cadenzarla è l’irreversibile malattia dell’organismo. Con queste considerazioni non voglio spezzare lance a favore dell’eutanasia; semplicemente vorrei che la morte perdesse quel suo tratto di estraneità che inevitabilmente possiede quando è affidata alle sorti biologiche dell’organismo e diventasse qualcosa di familiare con la vita, qualcosa che non chiude come un evento estraneo amori e amicizie, ma si fa accompagnare dagli amori e dalle amicizie per cui e con cui si è vissuto. Questa è la morte «umana» che va assolutamente distinta dalla morte «biologica» che al limite non ci riguarda. Ma proprio qui, quando il problema sembra, se non risolto, almeno meglio impostato, deve raccogliersi la nostra attenzione e concentrarsi su questa domanda: esiste un individuo capace di scegliere in piena coscienza prescindendo dalla società in cui si trova a vivere? A mio parere assolutamente no. E se la società in cui ci troviamo a vivere più non conosce il dolore e le parole necessarie per raggiungerlo, perché conosce solo medici, farmaci, ricoveri, e dopo queste cose più niente? Se il dolore strozza l’anima e il corpo, perché nella nostra società è segregato e rimosso, in quella morsa che racchiude la sofferenza in una solitudine che diventa atroce perché incomunicabile, perché non si conoscono più le parole e gli affetti capaci di profanare le mura che la nostra cultura ha eretto, spesse, affinché il dolore non appaia come evento della nostra quotidianità, come si può pretendere che un individuo consapevole di vivere in questa società, scelga «liberamente» di morire o si senta legittimato a staccare la spina? A questo punto le nostre riflessioni devono spostarsi: dal problema dell’eutanasia al problema dei margini d’esistenza che la nostra società contempla come margini «dignitosi», e considerare se quei margini nella nostra società non si sono troppo ristretti come effetto della rimozione metodica del dolore. Se questo, come io credo, è il vero problema, allora anche le parole della chiesa cattolica possono essere riascoltate. Non come parole a difesa di un troppo generico concetto di «vita», ma come parole che chiedono di non sopprimere con troppa leggerezza l’esperienza del dolore, perché su questa strada disimpariamo a trattarlo, e quando si presenta non disponiamo di altro linguaggio che la radicalità di un gesto. E questo anche quando non si è in coma irreversibile, ma solamente sotto l’incubo di un orizzonte che, per la nostra forza di sopportazione, s’è fatto troppo buio.
Umberto Galimberti
Umberto Galimberti, nato a Monza nel 1942, è stato dal 1976 professore incaricato di Antropologia Culturale e dal 1983 professore associato di Filosofia della Storia. Dal 1999 è professore ordinario …