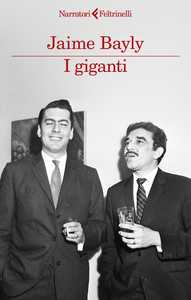Francesco La Licata: Larresto del capo della mafia
10 Gennaio 2003
Alle otto del mattino la circonvallazione era il solito
inferno di clacson e lamiere. Il complesso residenziale di ville unifamiliari
(via Bernini lato quartiere Uditore) un'oasi nella bolgia distante qualche
centinaio di metri. Il cancello elettronico azionato a distanza si aprì, quando
erano appena trascorse le otto del mattino, e consegnò il muso della piccola
Citroën "CX" color canna di fucile. Il ronzio della cinepresa che
entrava in azione ruppe il silenzio all'interno del furgone mimetizzato dei
carabinieri, posteggiato sul marciapiedi opposto. Il "film" riprendeva
i due uomini dentro la Citroën: sembravano tranquilli padri di famiglia in
procinto di iniziare la loro giornata di lavoro. E invece no, visto che solo a
vederli gli occupanti del furgone piombarono in un stato di grande
fibrillazione. C'era un ufficiale, lo chiamavano capitano Ultimo, c'erano altri
"specialisti" e c'era un uomo esile catapultato dal Piemonte in
Sicilia, dopo essersi praticamente consegnato ai carabinieri per sfuggire alle
attenzione dei mafiosi ed ex amici del suo paese: San Giuseppe Jato. Baldassarre
Di Maggio, il suo nome, ma tutti lo chiamavano Balduccio. Era stato il capo di
quella cosca arroccata sulle pietraie che furono il regno del bandito Salvatore
Giuliano.
Ma che ci faceva, Balduccio, dentro il furgone pieno di carabinieri? Aveva appena compiuto il salto del fosso e collaborava. Lì, in via Bernini, guardava, guardava tutti quelli che passavano a piedi e in auto, sperando nel colpo di fortuna di imbattersi in un uomo che solo lui sapeva com'era fatto. Un uomo che viveva in clandestinità da quasi trent'anni, il capo di Cosa nostra, quel Salvatore Riina di cui esisteva qualche foto sbiadita ed una vasta aneddotica riferita da pentiti del calibro di Masino Buscetta, Nino Calderone, Francesco Marino Mannoia, Salvatore Contorno e tanti altri. La Citroën si avvicina e Balduccio strabuzza gli occhi, balbetta per l'emozione: "E' lui". Ma chi quello che guida? "No, l'altro. Quello accanto, vi dico che quell'altro è Totò Riina. Presto fate qualcosa".
Ultimo deve decidere in un attimo: qualche ordine secco via radio, poi sale su un'auto civetta con due ragazzi tosti e piomba sulla Citroën mentre il conducente, Salvatore Biondino braccio destro e "tutore" della latitanza di Riina, si appresta ad imboccare la rotonda che dà sull'assessorato all'Agricoltura della Regione siciliana. Il motore "imballato" della "civetta" copre le grida dei carabinieri che aprono contemporaneamente gli sportelli dell'utilitaria e immobilizzano don Totò mettendogli una coperta sulla testa. In pochi secondi Riina e il suo scudiero si ritrovano sul sedile posteriore della "civetta" che sgomma verso il centro.
I militari rimasti sulla rotonda devono faticare per rassicurare la folla testimone del blitz: "Tranquilli, siamo carabinieri, non c'è stato nessun sequestro di persona". E quando Ultimo si manifesta al boss dicendogli che lo sta portando in galera, don Totò - pallido come la carta - tira persino un sospiro di sollievo per essere ancora vivo. Era il 15 gennaio di dieci anni fa e, mentre Giancarlo Caselli affrontava il suo primo giorno di procuratore a Palermo, sulla "rotonda del Motel Agip" - insieme con una latitanza lunga e inconfessabilmente facile - si concludeva la storia criminale di Salvatore Riina, detto "Totò 'u curtu" per la bassa statura. Una storia densa, come tutte le vicende di uomini che - seppure nel male - lasciano il segno. Di don Totò si è detto tutto e il contrario, ancora molto si potrà dire in futuro, ma certamente non è personaggio facilmente liquidabile come banale e insignificante. Anche se, immediatamente dopo la cattura, quel faccione di contadino frastornato, ripreso sotto il ritratto del generale Dalla Chiesa, con le mani intrecciate tra le gambe e l'espressione smarrita fece dire a molti: "Uno così non può essere il capo della mafia". E invece era proprio il padrino. Un capo con tutte le carte in regola per lasciare traccia nella storia nera della Sicilia, come fu per Giuliano e per i misteri che gli ruotarono attorno, misteri ancor oggi inesplicati. Con Riina prende corpo il mito di Corleone, il piccolo centro dell'entroterra palermitano balzato all'attenzione dei media e dell'opinione pubblica internazionale. Sì, è vero, c'era stato Luciano Liggio con la sua prosopopea da padreterno, ma la sua figura era rimasta nell'ambito del folclore da esportazione mediatica. No, don Totò si rivelerà un'altra cosa: poco apparire e molta sostanza. Anche dopo la cattura, quando si troverà ad affrontare il "suo" popolo, il popolo di Cosa nostra, che gli contesterà l'errore di valutazione della strategia - quella dello stragismo mafioso - e di "linea politica". Diceva Buscetta - impietoso con Riina nei confronti processuali, fino a ridicolizzarlo come provinciale imbranato che vorrebbe "ruggire" ma riesce solo a "squittire" - che la forza dei "corleonesi" era la capacità di restare sommersi e di affiorare solo quando era il momento di colpire. Un'altra indiscutibile "qualità", il pentito la individuava nell'abilità con cui Riina, ma anche Provenzano (stessa scuola), riuscivano ad imbastire "tragedie". Che, tradotto dal mafiese, vuol dire saper mettere uno contro l'altro i propri nemici insinuando il germe del sospetto. E in effetti "'u curtu" è stato un genio della clandestinità e della "tragedia". Basterebbe ricordare che si è sposato in latitanza ma senza rinunciare alla cerimonia religiosa celebrata addirittura da tre preti, il più "importante" dei quali era don Agostino Coppola, successivamente arrestato per mafia. Ha generato quattro figli, due maschi e due femmine, sempre in clandestinità ma alla clinica Noto, una delle migliori di Palermo. Ha vissuto tre decenni da latitante, ma vivendo come un ricco borghese. Quando sposò Ninetta Bagarella, sorella di Leoluca, andò a vivere nella zona residenziale di San Lorenzo, a Palermo, cambiando casa prima dell'arrivo dei carabinieri che trovarono solo la pergamena della "partecipazione" alle nozze e le bomboniere coi confetti destinate agli invitati che non avevano potuto presenziare al "rinfresco". Ha vissuto e ha fatto vivere i propri cari senza una vera identità, ma non si può dire si sia fatto mancare nulla. I figli a scuola, la moglie in casa. La sera tutti a tavola e poi sul divano davanti alla tv. Un buon padre di famiglia? Sarà, ma non depone a favore di questa tesi il percorso dei due figli maschi: Giovanni e Salvuccio entrambi giovanissimi ed entrambi in carcere, il primo addirittura condannato all'ergastolo. Ma ai processi, don Totò vestirà i panni del contadino buono ("sono un quinta elementare", "ho vissuto vendendo formaggi"), mentre una folla di giornalisti, operatori, fotografi, reporter americani e giapponesi si riverserà sulle stradine di Corleone, fino al 1993 cittadina conosciuta solo per via del cognome di don Vito, il padrino di Mario Puzo. La mafia al tempo di Riina rappresenta una svolta epocale. Il trionfo di Corleone segna il tramonto della mafia palermitana, la fine della centralità della capitale. Una disfatta militare e "politica" certificata dall'impressionante carneficina: mille morti tra uccisi e scomparsi. Si afferma il metodo della "vasca con l'acido", la terribile fine riservata a chi finiva nelle mani di aguzzini che "interrogavano", strangolavano e poi si liberavano dei cadaveri dissolvendoli nell'acido. Per la prima volta, ed è questa la vera svolta del cosiddetto periodo corleonese, Cosa nostra esce dal ruolo angusto e subalterno di "ammortizzatore sociale" tra territorio e potere per cercare l'azzardo del "gioco grande". Il delirio di Totò 'u curtu sta tutto nell'illusione di poter tentare di condizionare governi e Stato, di fare politica in prima persona. Ci fu un momento in cui Riina si convinse (o qualcuno glielo fece credere) di poter tenere sotto ricatto l'Italia, seminando stragi e terrore per provocare una sterzata legislativa in direzione di scelte favorevoli a Cosa nostra. Una legislazione che attenuasse l'irreparabile danno provocato da Giovanni Falcone col suo maxiprocesso che archiviava l'intero gruppo dirigente della mafia in una gabbia chiusa da una ventina di ergastoli definitivi. Nel 1993 Giovanni Falcone non c'era più, ma il calcolo di don Totò si sarebbe rivelato egualmente sbagliato. Il "grande azzardo" aveva generato, per reazione, la grande antimafia: una inusitata reazione popolare accompagnata da un impegno dello Stato senza precedenti. Una strada accidentata, difficile ma complessivamente vincente. Almeno fino a un certo punto. Certo, ancora non tutta conosciuta e con qualche contraccolpo negativo, come accade in tutte le guerre che, in quanto tali, non sempre possono risultare chirurgicamente precise. Ancora oggi, per esempio, si continua a parlare del mistero del covo di Riina: la vicenda della mancata perquisizione nella casa di via Bernini. Sono passati dieci anni e proprio ieri cominciavano a sfilare in istruttoria i primi testimoni di una vicenda che il Gip, Vincenzina Massa, non ha voluto archiviare senza prima aver tentato l'ultimo approfondimento. Perciò dovranno esser sentiti anche i carabinieri che allora operarono: il generale Mario Mori, oggi direttore del Sisde, il capitano Ultimo, oggi tenente colonnello al Nas e tanti altri. Tutto per capire perché non fu perquisita la casa di via Bernini, se si trattò - come hanno sempre sostenuto i carabinieri - di un errore di valutazione (una "cappellata") condiviso dalla Procura di Palermo che attese diciotto giorni prima di pretendere l'irruzione. A sentire qualche pentito, il ritardo nella perquisizione permise a Bagarella e soci di "ripulire" il covo. Tesi suggestiva, ma contrastata da quanti controbattono che Riina non aveva nulla da "ripulire" perché nessun dirigente di Cosa nostra ha mai tenuto un archivio o "cose scritte". Una storia, quella del covo, che si appresta a rimanere - proprio a causa dell'assenza di una parola definitiva - nel novero dei misteri siciliani, non si sa mai quanto autentici o quanto frutto della sicula vocazione alla dietrologia. Certo, a guardare le macerie delle stragi palermitane e di quelle del '93 si viene assaliti dal dubbio che tutto ciò possa essere stata opera di quel "pacioccone" fotografato (Anni Settanta) a piazza San Marco mentre dà da mangiare ai colombi. Poi, però, riaffiorano le parole di tanti pentiti che consegnano l'immagine di un sanguinario irriducibile anche di fronte all'eventualità di poter provocare la morte di bambini innocenti ("Pazienza" - dirà in una riunione operativa per pianificare un'autobomba a Trapani - muoiono tanti bimbi a Sarajevo"). E riaffiorano le sentenze di Firenze sugli attentati del '93, con Riina, Bagarella e Brusca che "spingono" con le bombe per cambiare il corso dei processi e del carcere duro e Provenzano che cerca la mediazione e la strada incruenta. Ecco, se si dovesse definire la "segreteria Riina", si dovrebbe concludere che è stata unica nel suo genere. I dieci anni trascorsi dalla cattura, i pentiti, i processi e le indagini ci consegnano un personaggio atipico per la mafia. Una sorta di "dittatore" che, fatto insolito per Cosa nostra, ha cercato di imporsi sulla politica, addirittura pensando di condizionarne le scelte. Anche quelle economiche, se è vero che - per la prima volta nella storia della mafia - Cosa nostra pretese un posto a sedere (dove ovviamente si presentavano facce pulite) nel "tavolino" degli appalti pubblici, con una tangente "fissa" destinata ai "bravi ragazzi". Ed è stato proprio questo personaggio così diverso, forse, a finire per alimentare una controparte molto più vivace ed efficiente del passato. Un fatto è certo, la fine dell'era di Totò Riina ha coinciso - nella sponda dell'antimafia - con un certo ritorno alla routine fatta di inciuci e mediazioni continui, dove più che i fatti contano le dietrologie, i sospetti e i cattivi pensieri. Con Riina era tutto più chiaro.
Ma che ci faceva, Balduccio, dentro il furgone pieno di carabinieri? Aveva appena compiuto il salto del fosso e collaborava. Lì, in via Bernini, guardava, guardava tutti quelli che passavano a piedi e in auto, sperando nel colpo di fortuna di imbattersi in un uomo che solo lui sapeva com'era fatto. Un uomo che viveva in clandestinità da quasi trent'anni, il capo di Cosa nostra, quel Salvatore Riina di cui esisteva qualche foto sbiadita ed una vasta aneddotica riferita da pentiti del calibro di Masino Buscetta, Nino Calderone, Francesco Marino Mannoia, Salvatore Contorno e tanti altri. La Citroën si avvicina e Balduccio strabuzza gli occhi, balbetta per l'emozione: "E' lui". Ma chi quello che guida? "No, l'altro. Quello accanto, vi dico che quell'altro è Totò Riina. Presto fate qualcosa".
Ultimo deve decidere in un attimo: qualche ordine secco via radio, poi sale su un'auto civetta con due ragazzi tosti e piomba sulla Citroën mentre il conducente, Salvatore Biondino braccio destro e "tutore" della latitanza di Riina, si appresta ad imboccare la rotonda che dà sull'assessorato all'Agricoltura della Regione siciliana. Il motore "imballato" della "civetta" copre le grida dei carabinieri che aprono contemporaneamente gli sportelli dell'utilitaria e immobilizzano don Totò mettendogli una coperta sulla testa. In pochi secondi Riina e il suo scudiero si ritrovano sul sedile posteriore della "civetta" che sgomma verso il centro.
I militari rimasti sulla rotonda devono faticare per rassicurare la folla testimone del blitz: "Tranquilli, siamo carabinieri, non c'è stato nessun sequestro di persona". E quando Ultimo si manifesta al boss dicendogli che lo sta portando in galera, don Totò - pallido come la carta - tira persino un sospiro di sollievo per essere ancora vivo. Era il 15 gennaio di dieci anni fa e, mentre Giancarlo Caselli affrontava il suo primo giorno di procuratore a Palermo, sulla "rotonda del Motel Agip" - insieme con una latitanza lunga e inconfessabilmente facile - si concludeva la storia criminale di Salvatore Riina, detto "Totò 'u curtu" per la bassa statura. Una storia densa, come tutte le vicende di uomini che - seppure nel male - lasciano il segno. Di don Totò si è detto tutto e il contrario, ancora molto si potrà dire in futuro, ma certamente non è personaggio facilmente liquidabile come banale e insignificante. Anche se, immediatamente dopo la cattura, quel faccione di contadino frastornato, ripreso sotto il ritratto del generale Dalla Chiesa, con le mani intrecciate tra le gambe e l'espressione smarrita fece dire a molti: "Uno così non può essere il capo della mafia". E invece era proprio il padrino. Un capo con tutte le carte in regola per lasciare traccia nella storia nera della Sicilia, come fu per Giuliano e per i misteri che gli ruotarono attorno, misteri ancor oggi inesplicati. Con Riina prende corpo il mito di Corleone, il piccolo centro dell'entroterra palermitano balzato all'attenzione dei media e dell'opinione pubblica internazionale. Sì, è vero, c'era stato Luciano Liggio con la sua prosopopea da padreterno, ma la sua figura era rimasta nell'ambito del folclore da esportazione mediatica. No, don Totò si rivelerà un'altra cosa: poco apparire e molta sostanza. Anche dopo la cattura, quando si troverà ad affrontare il "suo" popolo, il popolo di Cosa nostra, che gli contesterà l'errore di valutazione della strategia - quella dello stragismo mafioso - e di "linea politica". Diceva Buscetta - impietoso con Riina nei confronti processuali, fino a ridicolizzarlo come provinciale imbranato che vorrebbe "ruggire" ma riesce solo a "squittire" - che la forza dei "corleonesi" era la capacità di restare sommersi e di affiorare solo quando era il momento di colpire. Un'altra indiscutibile "qualità", il pentito la individuava nell'abilità con cui Riina, ma anche Provenzano (stessa scuola), riuscivano ad imbastire "tragedie". Che, tradotto dal mafiese, vuol dire saper mettere uno contro l'altro i propri nemici insinuando il germe del sospetto. E in effetti "'u curtu" è stato un genio della clandestinità e della "tragedia". Basterebbe ricordare che si è sposato in latitanza ma senza rinunciare alla cerimonia religiosa celebrata addirittura da tre preti, il più "importante" dei quali era don Agostino Coppola, successivamente arrestato per mafia. Ha generato quattro figli, due maschi e due femmine, sempre in clandestinità ma alla clinica Noto, una delle migliori di Palermo. Ha vissuto tre decenni da latitante, ma vivendo come un ricco borghese. Quando sposò Ninetta Bagarella, sorella di Leoluca, andò a vivere nella zona residenziale di San Lorenzo, a Palermo, cambiando casa prima dell'arrivo dei carabinieri che trovarono solo la pergamena della "partecipazione" alle nozze e le bomboniere coi confetti destinate agli invitati che non avevano potuto presenziare al "rinfresco". Ha vissuto e ha fatto vivere i propri cari senza una vera identità, ma non si può dire si sia fatto mancare nulla. I figli a scuola, la moglie in casa. La sera tutti a tavola e poi sul divano davanti alla tv. Un buon padre di famiglia? Sarà, ma non depone a favore di questa tesi il percorso dei due figli maschi: Giovanni e Salvuccio entrambi giovanissimi ed entrambi in carcere, il primo addirittura condannato all'ergastolo. Ma ai processi, don Totò vestirà i panni del contadino buono ("sono un quinta elementare", "ho vissuto vendendo formaggi"), mentre una folla di giornalisti, operatori, fotografi, reporter americani e giapponesi si riverserà sulle stradine di Corleone, fino al 1993 cittadina conosciuta solo per via del cognome di don Vito, il padrino di Mario Puzo. La mafia al tempo di Riina rappresenta una svolta epocale. Il trionfo di Corleone segna il tramonto della mafia palermitana, la fine della centralità della capitale. Una disfatta militare e "politica" certificata dall'impressionante carneficina: mille morti tra uccisi e scomparsi. Si afferma il metodo della "vasca con l'acido", la terribile fine riservata a chi finiva nelle mani di aguzzini che "interrogavano", strangolavano e poi si liberavano dei cadaveri dissolvendoli nell'acido. Per la prima volta, ed è questa la vera svolta del cosiddetto periodo corleonese, Cosa nostra esce dal ruolo angusto e subalterno di "ammortizzatore sociale" tra territorio e potere per cercare l'azzardo del "gioco grande". Il delirio di Totò 'u curtu sta tutto nell'illusione di poter tentare di condizionare governi e Stato, di fare politica in prima persona. Ci fu un momento in cui Riina si convinse (o qualcuno glielo fece credere) di poter tenere sotto ricatto l'Italia, seminando stragi e terrore per provocare una sterzata legislativa in direzione di scelte favorevoli a Cosa nostra. Una legislazione che attenuasse l'irreparabile danno provocato da Giovanni Falcone col suo maxiprocesso che archiviava l'intero gruppo dirigente della mafia in una gabbia chiusa da una ventina di ergastoli definitivi. Nel 1993 Giovanni Falcone non c'era più, ma il calcolo di don Totò si sarebbe rivelato egualmente sbagliato. Il "grande azzardo" aveva generato, per reazione, la grande antimafia: una inusitata reazione popolare accompagnata da un impegno dello Stato senza precedenti. Una strada accidentata, difficile ma complessivamente vincente. Almeno fino a un certo punto. Certo, ancora non tutta conosciuta e con qualche contraccolpo negativo, come accade in tutte le guerre che, in quanto tali, non sempre possono risultare chirurgicamente precise. Ancora oggi, per esempio, si continua a parlare del mistero del covo di Riina: la vicenda della mancata perquisizione nella casa di via Bernini. Sono passati dieci anni e proprio ieri cominciavano a sfilare in istruttoria i primi testimoni di una vicenda che il Gip, Vincenzina Massa, non ha voluto archiviare senza prima aver tentato l'ultimo approfondimento. Perciò dovranno esser sentiti anche i carabinieri che allora operarono: il generale Mario Mori, oggi direttore del Sisde, il capitano Ultimo, oggi tenente colonnello al Nas e tanti altri. Tutto per capire perché non fu perquisita la casa di via Bernini, se si trattò - come hanno sempre sostenuto i carabinieri - di un errore di valutazione (una "cappellata") condiviso dalla Procura di Palermo che attese diciotto giorni prima di pretendere l'irruzione. A sentire qualche pentito, il ritardo nella perquisizione permise a Bagarella e soci di "ripulire" il covo. Tesi suggestiva, ma contrastata da quanti controbattono che Riina non aveva nulla da "ripulire" perché nessun dirigente di Cosa nostra ha mai tenuto un archivio o "cose scritte". Una storia, quella del covo, che si appresta a rimanere - proprio a causa dell'assenza di una parola definitiva - nel novero dei misteri siciliani, non si sa mai quanto autentici o quanto frutto della sicula vocazione alla dietrologia. Certo, a guardare le macerie delle stragi palermitane e di quelle del '93 si viene assaliti dal dubbio che tutto ciò possa essere stata opera di quel "pacioccone" fotografato (Anni Settanta) a piazza San Marco mentre dà da mangiare ai colombi. Poi, però, riaffiorano le parole di tanti pentiti che consegnano l'immagine di un sanguinario irriducibile anche di fronte all'eventualità di poter provocare la morte di bambini innocenti ("Pazienza" - dirà in una riunione operativa per pianificare un'autobomba a Trapani - muoiono tanti bimbi a Sarajevo"). E riaffiorano le sentenze di Firenze sugli attentati del '93, con Riina, Bagarella e Brusca che "spingono" con le bombe per cambiare il corso dei processi e del carcere duro e Provenzano che cerca la mediazione e la strada incruenta. Ecco, se si dovesse definire la "segreteria Riina", si dovrebbe concludere che è stata unica nel suo genere. I dieci anni trascorsi dalla cattura, i pentiti, i processi e le indagini ci consegnano un personaggio atipico per la mafia. Una sorta di "dittatore" che, fatto insolito per Cosa nostra, ha cercato di imporsi sulla politica, addirittura pensando di condizionarne le scelte. Anche quelle economiche, se è vero che - per la prima volta nella storia della mafia - Cosa nostra pretese un posto a sedere (dove ovviamente si presentavano facce pulite) nel "tavolino" degli appalti pubblici, con una tangente "fissa" destinata ai "bravi ragazzi". Ed è stato proprio questo personaggio così diverso, forse, a finire per alimentare una controparte molto più vivace ed efficiente del passato. Un fatto è certo, la fine dell'era di Totò Riina ha coinciso - nella sponda dell'antimafia - con un certo ritorno alla routine fatta di inciuci e mediazioni continui, dove più che i fatti contano le dietrologie, i sospetti e i cattivi pensieri. Con Riina era tutto più chiaro.
Francesco La Licata
Francesco La Licata ha cominciato nel 1970 lavorando in cronaca per ‟L’Ora di Palermo” e poi occupandosi delle più importanti vicende siciliane: la scomparsa di Mauro De Mauro, l’assassinio del …