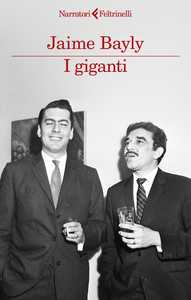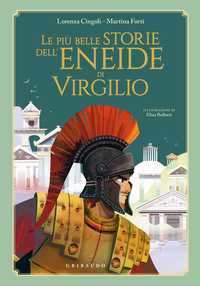Paolo Rumiz: Migranti made in Italy
27 Agosto 2003
BIELLA - Per arrivare dal "Genulin" venendo dal Monte Rosa, devi fare un periplo infinito, discendere la Valle Anzasca, l’Ossola, il Lago Maggiore, tornare nella pianura devastata dalla sete, passare il Sesia secco e immobile come un treno in uno scalo merci, puntare su Biella tenendo sempre sulla destra la grande montagna di neve. Non puoi liberartene, ti segue sempre, ti sovrasta come una surreale, gigantesca meringa; stella polare, fatamorgana, cardine e destino di questi paesi del Piemonte, ieri miserabili, oggi ricchissimi. Eugenio Gianadda, detto Genulin, anni 92, il patriarca di Curino, mi apre la porta. Sembra un po' Gandhi, un po' Luigi Einaudi. Mi offre albicocche del suo giardino e acqua fresca del pozzo, tagliata col vermouth. Parla con voce stridula e chiara. Curino, 600 abitanti e 26 chiese, ex feudo pontificio perso sulle colline fra Biella e la Valsesia, terra ricca di minerali e ossa di dinosauri, quasi non lo trovi sulla carta. Succede, forse, perché il paese vero è altrove. Curino non è i suoi seicento abitanti. é, assai di più, le tremila anime della diaspora, sparse tra Francia, Svizzera, Stati Uniti, Sudafrica, Argentina. E quei tremila, come i salmoni, quando sentono nostalgia delle origini, si passano la voce. Ricchi o poveri, anche alla quarta generazione, dicono: «Vai dal Genulin». Vai dall’Eugenio, che sa tutto della tua storia. Così l’Eugenio è diventato, per forza e per passione, lo snodo e l’archivio di una strepitosa memoria, quella dell’emigrazione alpina. Alla sua età sa tutto, ricorda tutto, annota tutto. Una vita dedicata alla sua gente. Si partiva a metà febbraio, racconta, quando nei quattordici mulini del paese non c’era più niente da beccare e il recastegna, un uccello piccolo come una noce, urlava la sua fame. Faceva «Ciui, ciui, ciui», ma gli uomini traducevano «fa la valis, fa la valis, fa la valis». Sapevano che era tempo di fare le valigie e andare Oltralpe, a cercar pane. Se ne andavano a piedi, con due fette di polenta e un uovo nel sacco, fino in Val d’Aosta, dove si dividevano tra i due passi del San Bernardo. Gli uni verso la Svizzera e la Francia del Nord, gli altri verso Marsiglia e il Midi. Alcuni erano così magri che gli osti li rifocillavano per pietà, in cambio di una lavata di piatti. Ma molti non tornavano. Oggi sono vent’anni che dal Piemonte non si emigra, nessuno va a piedi, i mulini hanno chiuso, il recastegna è scomparso. Ma la memoria è rimasta, testarda e corsara. Non sta nei grandi libri ma negli appunti di uomini come l’Eugenio. «E’ da lui che devi andare se vuoi capire l’emigrazione» mi aveva detto Gustavo Burat prima della mia partenza per questa avventura alpina. Burat, un biellese matto per le Alpi; uno che - se la moglie non gli avesse fatto cambiare idea - avrebbe chiamato i figli Narcanello e Frigidolfo, come i torrenti che formano l’Oglio a Pontedilegno, eremo estivo del Bossi Umberto. L’Eugenio non è un uomo, è una biblioteca vivente. Scandisce le parole con lentezza e semplicità, vuol essere certo di essere capito. Spiega: ci chiamavano «maccheroni» e «spaghetti» quando scendevamo in Svizzera. Maccheroni e spaghetti anche se eravamo del Nord e mangiavamo solo polenta e patate. Oggi quelli di Curino, e i Gianadda in special modo, sono diventati ricchi. Piero è un magnate del Vallese, re dei supermarket a Crans Montana. Leonardo è il padrone di Martigny, ha creato la più grande fondazione svizzera per le belle arti, ha ricevuto da Chirac la Legion d’Onore e poi la Spada di protettore delle arti. Suo padre, racconta lui stesso, se n’era andato oltre le Alpi per non sentir piangere la mamma, disperata «per non poter pagarsi il sale della minestra». Non smetteresti mai di ascoltarlo. Narra del nonno Giovanni, che sopravvive alla tempesta sul Gran San Bernardo. Un miracolo. La neve lo prende a metà dicembre, sulla strada del ritorno. é il 1862, lui e l’amico Giuseppe Beltrame continuano lo stesso, vogliono essere a casa per Natale. Ma la notte arriva e i cani lo trovano solo al mattino. La sua pelle è cianotica, senza sensibilità. Si attacca alla bottiglia di brandy, ma il San Bernardo lo morde al terzo sorso. I frati lo portano all’Ospizio, lo ficcano nudo in una vasca di acqua fredda. Lui urla, ma non dal dolore. Ha paura che spariscano i napoleoni cuciti nelle braghe. Apprende che l’amico è morto, nel delirio continua a gridare: «Les pantalons, les pantalons». «Gente di Curin testa grossa e cervel fin». Erano dei furboni, spiega, da queste parti. Per sopravvivere alle pretese dei Fieschi, il feudatario di nomina pontificia, avevano creato una piccola lobby di autodifesa, sempre attiva in Vaticano. E quando un giorno il messo papale, venuto a riscuotere le decime, domandò ai capifamiglia se volevano venire a Roma «a bajocchi cistare», quelli dissero di sì ed acquisirono il diritto di uscire dal «pagus», il villaggio. Emersero i più intelligenti, che fecero fortuna. Divennero banchieri, nobili, grandi proprietari. Nomi noti nella capitale. Scaretti, Gabella, Borgnana. Altri tornarono in Piemonte, per comprare terra buona, nelle risaie. Poi, racconta, venne l’unione al Piemonte e all’Italia, e la strada di Roma si chiuse. Allora non restarono che le Alpi. I curinesi si inventarono altri mestieri, muratori, gessatori, calzolai, «picprei» (quelli che picchettavano la pietra attorno alle finestre), e presero gli alti sentieri. Sulle spalle, sotto il sacco, tenevano il «cadrigatt», una seggiola pieghevole dove poggiare le chiappe e sonnecchiare nei momenti di esaurimento. «Cani randagi» li chiamavano, ma fecero fortuna. Uno ospitò a Ginevra il Duce ancora socialista prima della Grande Guerra, un altro aprì la strada dell’emigrazione italiana in Sudafrica, altri divennero albergatori a New York, altri ancora capitani d’industria in Francia. Sorride: «Non è meravigliosa la nostra storia?».
Paolo Rumiz
Paolo Rumiz, triestino, è scrittore e viaggiatore. Con Feltrinelli ha pubblicato La secessione leggera (2001), Tre uomini in bicicletta (con Francesco Altan; 2002), È Oriente (2003), La leggenda dei monti …