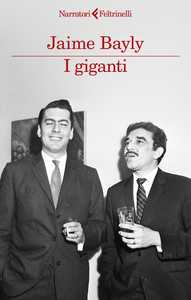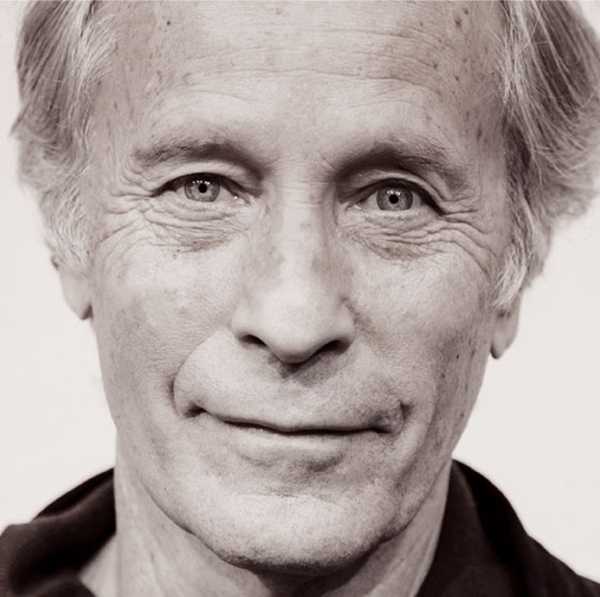Richard Ford: Che cosa chiede l'Europa all'America di Kerry
28 Luglio 2004
Tutti i miei amici nel Regno Unito e in Irlanda mi hanno fatto la stessa domanda (oppure la domanda opposta, il che dovrebbe dirvi qualcosa circa l'approccio dei nostri partner globali alle presidenziali americane che si profilano all'orizzonte): "Secondo te davvero potrebbe vincere Kerry?", mi ha chiesto una metà di loro mentre ero in visita la settimana scorsa. "Secondo te davvero potrebbe vincere Bush?" chiedevano parecchi altri. Non ho molti amici di simpatie repubblicane all'estero - che io sappia. Concludo quindi da questi interrogativi e dallo sgomento espresso in parallelo che un gran numero di europei dell'estremo ovest, anglofoni, interessati all'America, si preoccupano per le nostre elezioni, le vedono nebulose, temono che il presidente Bush sia rieletto, provano disorientamento e apprensione circa ciò che "l'America potrebbe fare" dopo nel resto del mondo e in generale vedono l'America come un colosso che può barcollare qua e là producendo spesso effetti tanto positivi quanto negativi - temono che tutto questo volga al peggio, in direzione di un imperialismo di fatto, di iniziative diplomatiche sempre più confuse, contraddittorie e ingannevoli, verso un rovinoso non allineamento ambientale, e in direzione di un incremento (non decremento) del terrorismo globale che mette in pericolo particolarmente l'Europa. Un'altra città, su un altro colle. è una doccia fredda, ovviamente, non avere una risposta pronta agli interrogativi dei miei amici - non che io sia tenuto a sapere chi sarà il vincitore di una serrata competizione elettorale lontana ancora quattro mesi.
Ma rinfranca sapere che con l'approssimarsi delle convention dei partiti Usa, una sorta di circo di second'ordine che entra a passo pesante in città, gli europei hanno l'impressione di dover affrontare le conseguenze radicali di ciò che "noi" facciamo, sentono (a ragione) di non avere grandi possibilità di controllo, tuttavia dimostrano di afferrare le "nostre problematiche" con maggior perspicacia di gran parte dei miei connazionali. Nell'America in cui vivo io fondamentalmente non si parla di questi argomenti con persone con cui ci si potrebbe trovare in disaccordo, tanto siamo divisi e repressi circa la dubbia condotta morale della nostra nazione e la sua leadership ipocrita. Permane, qui, la sensazione che nessuno presti orecchio a cose che non ha già sentito, e che l'elezione, un tempo immaginata come sacramento civico unificante, porterà ancora una volta ad un punto morto in un paese in cui solo un terzo di noi vota e a decidere la competizione è un gruppo limitato di "indecisi" ancor più confusi, che apparentemente fanno la loro scelta nello spazio di una sigaretta fumata in fretta nel parcheggio davanti al seggio. Questa elezione non dà l'idea di un sacramento civico unificante, o tanto meno di un'elezione normale, benché le poste in gioco siano altissime. "Beh, non lo so", è stata la mia risposta agli amici europei sul tema dell'elezione e di chi vincerà. Gran parte dell'attivismo politico che si vede oggi serve solo a lavorare l'avversario ai fianchi, è una fase di collaudo delle tematiche in cui si identificano le vulnerabilità dei candidati prima che prenda il via la vera e propria strategia, il mercato dei voti, nei giorni di fuoco successivi alla convention, quei due mesi e mezzo in cui viene dato campo libero a chi la spara più grossa in cui davvero si possono vincere o perdere le elezioni, come probabilmente avverrà. In quel periodo sicuramente i repubblicani tenteranno di anestetizzare ulteriormente quel 12-20 per cento di non politicamente impegnati (gli indecisi) avvelenandoli di affermazioni ferocemente inesatte, altamente provocatorie, circa il candidato democratico, affermazioni che si augurano continuino ad aleggiare intorno a lui come un odore sulfureo, abbastanza a lungo da soffocare i consensi prima che la verità trapeli. I democratici, da parte loro, si accingono alla lunga corsa per far decollare il Senatore (alla maniera dell'Iowa), individuare qualche tema su cui i repubblicani non abbiano già tergiversato fino a farlo cadere nel dimenticatoio, cogliere al volo qualunque "gaffe di Bush" possa loro giungere in eredità, sperando che i calunniatori repubblicani non abbiano immaginato qualche nuovo modo di coprire il candidato democratico di inturgidita infamia (la mossa da tempo favorita dello scandalo a sfondo sessuale). In realtà i democratici sono costretti a portare il fardello peculiare e forse incommensurabile di dover vincere, perché il presidente in carica non è benvoluto, neppure i repubblicani lo stimano, la gran parte degli americani, come gran parte degli europei ha la sensazione che le cose stiano andando male e la volta scorsa un maggior numero di elettori ha votato democratico di quanti abbiano votato repubblicano - anche prima che Bush desse dimostrazione delle sue particolari capacità di leader. (E dopo aver rubato l'elezione). In altre parole sta a loro perdere questa elezione, il che non è mai piacevole per i democratici e in effetti li rende quanto mai inclini a innervosirsi. L'attuale preludio alle convention dei partiti, in altri termini il momento in cui i ballon d'essai tornano a terra e inizia la costruzione del carro del vincitore, questa fase, spiego ai miei amici, è elettoralmente statica per noi qui in attesa di votare o di non votare. I pomposi funerali di Reagan ci hanno distratto. I ‟Lakers” e i ‟Flames” hanno entrambi perso. Le puntate dei Soprano sono finite. In più le grandi scelte sono praticamente fatte. Resta solo il premio Simpatia da conferire al candidato democratico alla vice presidenza e l'improbabile voltafaccia per cui Bush decida che Cheney è di peso e gli orchestri un altro "attacco cardiaco". Tuttavia c'è anche un'atmosfera sinistra nella vita americana quest'estate. Siamo impegnati a proseguire una feroce guerriglia in Iraq e in Afghanistan, stiamo riscrivendo importanti definizioni lessicali di espressioni quali "sovranità", "mantenere la rotta", "istituzioni democratiche", stiamo tentando sfacciatamente di tirare in ballo l'Onu per sistemare il nostro gran pasticcio, continuiamo a costringere con prepotenza l'Europa a credere che "è necessario" condividere il nostro modo di pensare su un maggior numero di questioni. E nel frattempo stiamo reclamizzando il carattere "resti tra noi - tutto nella norma" del nostro ciclo elettorale nazionale. (Bush in golf cart, Kerry, beh, Kerry là fuori da qualche parte). Gli americani sono assai abili ed esperti a fare in modo che il più possibile di ciò che avviene all'interno dei nostri confini sembri "normale". Ricordate come eravamo sollevati quando la borsa riaprì il lunedì successivo all'11 settembre ("Perbacco, almeno questa funziona ancora"). Il nostro duplice motto è "affari e normalità". Ecco perché è difficile che ci allarmiamo, perché così pochi di noi vanno alle urne (siamo troppo occupati ad essere occupati) e perché abbiamo reagito in modo così estremo, personale ed egoistico agli attacchi al World Trade Center: "Non vogliamo un'altra grana così, che il nostro governo debba svegliarsi e impicciarsi delle nostre vite private". A noi piace essere lasciati in pace, dovete solo capire questo.
La maggior parte dei miei conoscenti europei capisce questo, ovviamente, tutto il resto di ciò che ho detto e anche molto di più - probabilmente più di quanto capiamo noi nel nostro ottenebrato torpore estivo. Quello che capiscono non li rende fiduciosi. Né sicuri. Né affatto a proprio agio. "Che cosa farete se Bush verrà rieletto?" è ovviamente il sottinteso privato a qualunque interrogativo, apparentemente disinteressato, circa le nostre presidenziali, un interrogarsi alla ricerca di una analogia di sentimenti con un americano, un qualche gesto che riconosca che siamo sulla stessa barca e che qualcosa è possibile. "Certo", è la mia risposta "siamo assolutamente sulla stessa barca, che qualcuno qui lo ammetta o trovi un modo di comportarsi "attivo" (secondo l'infelice espressione in voga)". Non ho molto più che un'analogia di sentimenti da offrire. E i sentimenti che ho sono viziati, ovviamente, dal fatto che mi trovo qui, che non ho intenzione di andar via, e che è il mio paese ad avere un approccio così negativo con i grandi dilemmi morali della nostra nuova era. Inoltre sono "immischiato con i progressisti", quelli che hanno bisogno che Bush faccia peggio in modo che la nostra parte possa vincere e, ovviamente, far meglio. è una sensazione strana essere un americano in questo preciso momento, non fatevi abbindolare. Repubblicani e democratici indistintamente, nessuno si trova oggi a suo agio nella propria pelle. E la maggior parte di noi, su entrambi i fronti, ama il nostro paese e pensa che abbia speranza. Alla fine si deve trarre incoraggiamento dove si riesce a trovarlo o a inventarlo. E io ne prendo la mia piccola dose proprio da questa debole, turbinosa sensazione di disagio che noi tutti avvertiamo qui - con l'intima profonda convinzione che non andremo avanti così, che dobbiamo far meglio invece che peggio, e che sotto il rullo di tamburi della campagna elettorale c'è un cuore che batte onesto, forte e regolare. È l'anno delle presidenziali. C'è una possibilità.
Traduzione di Emilia Benghi.
Ma rinfranca sapere che con l'approssimarsi delle convention dei partiti Usa, una sorta di circo di second'ordine che entra a passo pesante in città, gli europei hanno l'impressione di dover affrontare le conseguenze radicali di ciò che "noi" facciamo, sentono (a ragione) di non avere grandi possibilità di controllo, tuttavia dimostrano di afferrare le "nostre problematiche" con maggior perspicacia di gran parte dei miei connazionali. Nell'America in cui vivo io fondamentalmente non si parla di questi argomenti con persone con cui ci si potrebbe trovare in disaccordo, tanto siamo divisi e repressi circa la dubbia condotta morale della nostra nazione e la sua leadership ipocrita. Permane, qui, la sensazione che nessuno presti orecchio a cose che non ha già sentito, e che l'elezione, un tempo immaginata come sacramento civico unificante, porterà ancora una volta ad un punto morto in un paese in cui solo un terzo di noi vota e a decidere la competizione è un gruppo limitato di "indecisi" ancor più confusi, che apparentemente fanno la loro scelta nello spazio di una sigaretta fumata in fretta nel parcheggio davanti al seggio. Questa elezione non dà l'idea di un sacramento civico unificante, o tanto meno di un'elezione normale, benché le poste in gioco siano altissime. "Beh, non lo so", è stata la mia risposta agli amici europei sul tema dell'elezione e di chi vincerà. Gran parte dell'attivismo politico che si vede oggi serve solo a lavorare l'avversario ai fianchi, è una fase di collaudo delle tematiche in cui si identificano le vulnerabilità dei candidati prima che prenda il via la vera e propria strategia, il mercato dei voti, nei giorni di fuoco successivi alla convention, quei due mesi e mezzo in cui viene dato campo libero a chi la spara più grossa in cui davvero si possono vincere o perdere le elezioni, come probabilmente avverrà. In quel periodo sicuramente i repubblicani tenteranno di anestetizzare ulteriormente quel 12-20 per cento di non politicamente impegnati (gli indecisi) avvelenandoli di affermazioni ferocemente inesatte, altamente provocatorie, circa il candidato democratico, affermazioni che si augurano continuino ad aleggiare intorno a lui come un odore sulfureo, abbastanza a lungo da soffocare i consensi prima che la verità trapeli. I democratici, da parte loro, si accingono alla lunga corsa per far decollare il Senatore (alla maniera dell'Iowa), individuare qualche tema su cui i repubblicani non abbiano già tergiversato fino a farlo cadere nel dimenticatoio, cogliere al volo qualunque "gaffe di Bush" possa loro giungere in eredità, sperando che i calunniatori repubblicani non abbiano immaginato qualche nuovo modo di coprire il candidato democratico di inturgidita infamia (la mossa da tempo favorita dello scandalo a sfondo sessuale). In realtà i democratici sono costretti a portare il fardello peculiare e forse incommensurabile di dover vincere, perché il presidente in carica non è benvoluto, neppure i repubblicani lo stimano, la gran parte degli americani, come gran parte degli europei ha la sensazione che le cose stiano andando male e la volta scorsa un maggior numero di elettori ha votato democratico di quanti abbiano votato repubblicano - anche prima che Bush desse dimostrazione delle sue particolari capacità di leader. (E dopo aver rubato l'elezione). In altre parole sta a loro perdere questa elezione, il che non è mai piacevole per i democratici e in effetti li rende quanto mai inclini a innervosirsi. L'attuale preludio alle convention dei partiti, in altri termini il momento in cui i ballon d'essai tornano a terra e inizia la costruzione del carro del vincitore, questa fase, spiego ai miei amici, è elettoralmente statica per noi qui in attesa di votare o di non votare. I pomposi funerali di Reagan ci hanno distratto. I ‟Lakers” e i ‟Flames” hanno entrambi perso. Le puntate dei Soprano sono finite. In più le grandi scelte sono praticamente fatte. Resta solo il premio Simpatia da conferire al candidato democratico alla vice presidenza e l'improbabile voltafaccia per cui Bush decida che Cheney è di peso e gli orchestri un altro "attacco cardiaco". Tuttavia c'è anche un'atmosfera sinistra nella vita americana quest'estate. Siamo impegnati a proseguire una feroce guerriglia in Iraq e in Afghanistan, stiamo riscrivendo importanti definizioni lessicali di espressioni quali "sovranità", "mantenere la rotta", "istituzioni democratiche", stiamo tentando sfacciatamente di tirare in ballo l'Onu per sistemare il nostro gran pasticcio, continuiamo a costringere con prepotenza l'Europa a credere che "è necessario" condividere il nostro modo di pensare su un maggior numero di questioni. E nel frattempo stiamo reclamizzando il carattere "resti tra noi - tutto nella norma" del nostro ciclo elettorale nazionale. (Bush in golf cart, Kerry, beh, Kerry là fuori da qualche parte). Gli americani sono assai abili ed esperti a fare in modo che il più possibile di ciò che avviene all'interno dei nostri confini sembri "normale". Ricordate come eravamo sollevati quando la borsa riaprì il lunedì successivo all'11 settembre ("Perbacco, almeno questa funziona ancora"). Il nostro duplice motto è "affari e normalità". Ecco perché è difficile che ci allarmiamo, perché così pochi di noi vanno alle urne (siamo troppo occupati ad essere occupati) e perché abbiamo reagito in modo così estremo, personale ed egoistico agli attacchi al World Trade Center: "Non vogliamo un'altra grana così, che il nostro governo debba svegliarsi e impicciarsi delle nostre vite private". A noi piace essere lasciati in pace, dovete solo capire questo.
La maggior parte dei miei conoscenti europei capisce questo, ovviamente, tutto il resto di ciò che ho detto e anche molto di più - probabilmente più di quanto capiamo noi nel nostro ottenebrato torpore estivo. Quello che capiscono non li rende fiduciosi. Né sicuri. Né affatto a proprio agio. "Che cosa farete se Bush verrà rieletto?" è ovviamente il sottinteso privato a qualunque interrogativo, apparentemente disinteressato, circa le nostre presidenziali, un interrogarsi alla ricerca di una analogia di sentimenti con un americano, un qualche gesto che riconosca che siamo sulla stessa barca e che qualcosa è possibile. "Certo", è la mia risposta "siamo assolutamente sulla stessa barca, che qualcuno qui lo ammetta o trovi un modo di comportarsi "attivo" (secondo l'infelice espressione in voga)". Non ho molto più che un'analogia di sentimenti da offrire. E i sentimenti che ho sono viziati, ovviamente, dal fatto che mi trovo qui, che non ho intenzione di andar via, e che è il mio paese ad avere un approccio così negativo con i grandi dilemmi morali della nostra nuova era. Inoltre sono "immischiato con i progressisti", quelli che hanno bisogno che Bush faccia peggio in modo che la nostra parte possa vincere e, ovviamente, far meglio. è una sensazione strana essere un americano in questo preciso momento, non fatevi abbindolare. Repubblicani e democratici indistintamente, nessuno si trova oggi a suo agio nella propria pelle. E la maggior parte di noi, su entrambi i fronti, ama il nostro paese e pensa che abbia speranza. Alla fine si deve trarre incoraggiamento dove si riesce a trovarlo o a inventarlo. E io ne prendo la mia piccola dose proprio da questa debole, turbinosa sensazione di disagio che noi tutti avvertiamo qui - con l'intima profonda convinzione che non andremo avanti così, che dobbiamo far meglio invece che peggio, e che sotto il rullo di tamburi della campagna elettorale c'è un cuore che batte onesto, forte e regolare. È l'anno delle presidenziali. C'è una possibilità.
Traduzione di Emilia Benghi.
Richard Ford
Richard Ford, nato nel 1944 a Jackson (Mississippi), è considerato uno dei più grandi scrittori americani contemporanei. Con Il giorno dell’Indipendenza (1995; Feltrinelli, 1996) ha vinto i due premi più prestigiosi …