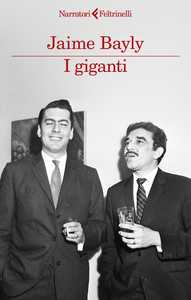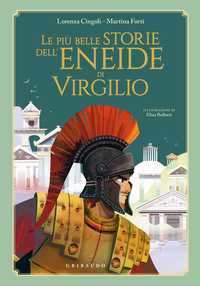Paolo Rumiz: La rotta per Lepanto. Il labirinto chiamato Dalmazia
10 Settembre 2004
Ruggisce il mare davanti a Sestrica, l'isola delle Due Sorelle. È l'ora viola, passiamo a vele piene e Leone spiegato sotto il faro acceso, alto su un roccione, che segna il magnifico inizio delle Incoronate. L'Adriatico non è solo una via d' acqua; è anche una via lattea. Le sue torri luminose punteggiano la notte ogni 25 miglia. Ma la costellazione più affascinante non parte da Venezia. Comincia a Trieste, prosegue in Istria con Punta Salvore, e poi via giù, con San Giovanni in Pelago, Porer davanti a Capo Promontore, Sànsego, e avanti ancora, fino in Montenegro, oltre le Bocche di Cattaro. Sono i fari dell'Austria-Ungheria. Roba solida, fine Ottocento, con gli appartamenti dei custodi in pietra squadrata alla base della torre. In Europa, solo i francesi ne costruirono con altrettanto dispendio di mezzi. Ma mentre sui fari atlantici abbiamo una documentazione sconfinata, su quelli adriatici non abbiamo niente. Appena qualche carta all'ex ammiragliato di Vienna. Pochi li conoscono, pochissimi vi sono entrati. E ora la navigazione satellitare, che non ha bisogno di punti luce, vorrebbe spegnerli. Estinguere una leggenda che comincia ad Alessandra d' Egitto e finisce a Gibilterra.
Attracco nella baietta di Vrulje, lato Sud dell'isola maggiore. Ceniamo nell'unica locanda, tra magnolie e olivastri nel vento. Un fuoco acceso, un birrino a bordo, una notte piena di stelle. Nel silenzio, spuntano rumori minimali. Pesci sottobordo, il volo radente di un cormorano, lo sfrigolìo della strumentazione elettronica, il colpo di tosse in una barca francese ancorata cento metri più in là. A mezzanotte belano le capre; è un'ora strana, ma qui non ci sono alberi, e le bestie hanno dormicchiato tutto il giorno in qualche anfratto all'ombra. Solo di notte escono a pascolare. Vedo il caprone, l'occhio ardente come un tizzone, che scende a bere acqua di mare. L'unica disponibile. Sulla superficie liquida i suoni si propagano veloci, generano immagini, fantasie, paure. Bojan, il bravo marinaio di capitan Erni, ci ride su, dice che in una notte così si possono sentire i denti di cane mordere la chiglia. E i denti di cane, per chi non lo sa, sono microrganismi color ruggine che si attaccano ai galleggianti. Accanto a noi si àncora una barca di pescatori, la masnada beve vino, canta per tenersi sveglia prima della battuta in mare. Da questa parti c'è stata una sola guerra vera, quella per il pesce. Guerra tra pescatori pellegrini e stanziali, fra isola di Murter e Isola Lunga, tra Sebenico e Primosten. Qui, dicono, l'acqua è così ricca di vita che i sardoni saltano da soli nella rete.
L'anima dalmatica è tutta in questa baie. Il Comandante, che le conosce bene, pesca aneddoti nella sua lunga memoria. Dalmazia è una rete di pallanuoto buttata in acqua e un villaggio intero che gioca. È una barca soletta nel novilunio, un ragazzo a poppa che percuote l'acqua con una pignatta per spingere i pesci nella rete. Dalmazia è arrivare in un porticciolo, attraccare con la prua verso terra e sentire le rimostranze dei locali. Si sa, il buon velista non ormeggia con la poppa al largo, deve sempre essere pronto a partire. Ma talvolta capita di non avere tempo per la manovra; parcheggi al contrario e speri che nessuno ti noti. Sbagli, in Dalmazia ti notano tutti. Vengono a dirti: "No se pol". Tu nicchi, chiedi se dai fastidio. "No - ti rispondono - no xe per el fastidio. Xe per la marineria". Fu Tito a far scoprire questo paradiso agli italiani. Ci portò Gianni Agnelli in crociera. L'uomo della Fiat non vide il comunismo; vide solo una nuova Costa Smeralda. Dalmazia è un puerto escondido che la sera diventa viola, poi rosso spento, con una fisarmonica che miagola canzoni strappalacrime. A prima vista sembra Formentera, Monemvassia, Beirut, Amalfi, Tolone, Algeri. Un posto qualsiasi del Mediterraneo. Invece no. È una combinazione irripetibile di Venezia, slavità, Grecia, pirateria e ordine austriaco. Solo Dalmazia. *** Le Incoronate ti ubriacano, ti fanno dimenticare tutto. Anche Venezia. Eppure i suoi segni non ti abbandonano mai, anche in questo mare deserto senza porti, monumenti, cattedrali. Sono le bitte di pietra bianca, disseminate ovunque, anche in mezzo al nulla, per garantire gli attracchi. Il simbolo di una presenza discreta, che convisse con i costumi altrui e non volle convertire nessuno. Il marchio di fabbrica di un impero che guerreggiò ma anche commerciò col Turco. Una rete mercantile cui interessavano solo gli approdi. Un mondo dove orgoglio di bandiera e profitto, scrive Jan Morris, erano la stessa cosa. "Dove sono le merci là è casa nostra", dissero nel '400 i marinai di una galea intrappolata fra Turchi e Bizantini che se le davano di santa ragione. Dissero: moriremo su questa nave, perché è appunto "casa nostra". "Venezia fu l'unico impero capace di sovranità senza bisogno di territorio"; ricordo le parole della ricercatrice greca Anastasia Stouraiti alla mia partenza dalla Laguna. Le navi in viaggio per il Levante non dovevano fare soste in porti altrui. Tutto era rigidamente centralizzato, cronometrato. Far tardi significava sballare il mercato delle spezie a Rialto.
La barca è invasa dall'odor di rosmarino, l'alba verso Spalato è un incendio arancione violento, quasi africano. Più a Nord, la terraferma è ancora immersa in una foschia color vinaccia. Si riparte verso Sudest, ci seguono tre delfini. L'arcipelago improvvisa giochi di vento. Aria calda piena di salvia plana sulla barca appena ti avvicini alla terra. Se costeggi un'isola lunga, il "Maistro" rinforza in corrispondenza di ogni avallamento, poi rallenta sotto ogni altura. Verso le nove comincia il "Borin". È un gioco di bonacce e turbolenze, correnti, variazioni di fondale e di profumi. Corbezzoli, lentischi, mirti, olivastri, rosmarino. Isole burlone. Come i dalmati, popolo irriverente, eccentrico, sensuale e mangiapreti. Quando gli austriaci vennero qui a rifare le carte dell'Adriatico, vollero sapere dai pescatori i nomi di ogni scoglio. E i locali, di fronte a tanta pignoleria, si divertirono a scodellare nomi scurrili inventati. Prdusa Vela e Mala, grande e piccola scorreggia. Bubina Guzica, il culo della nonna. Kurba Mala e Vela, piccola e gran puttana. Bludni Rt, promontorio della libidine. Mrduja, merda, o giù di lì.
Capitan Erni, indomito, pilota la sua barca fuori dalle isole calve. Ha ottant'anni, cinque in più di Sebastiano Venier nel giorno di Lepanto. Tale Ferrante Caracciolo, che vide in azione l'ammiraglio, così scrive. "Conoscendosi decrepito, stava armato di una corazza all'antica, in pianelle, con una balestra in mano et in capelli combattendo coraggiosamente". Era un duro, Venier. Capace, come vedremo, di mandare "in mona" il comandante supremo della flotta, Don Giovanni d'Austria. Capitan Ernesto, invece, è una pasta d'uomo. Gli va bene tutto. Canticchia al timone verso Zirije, con rotta su Traù. Ernesto riflette che per tanti, oggi, Venezia è solo feste e carnevale, mentre poche città diedero al mondo tanti uomini di coraggio. La morte in battaglia era cosa normale, succedeva spesso che il capitano di una nave circondata si facesse saltare in aria pur di affondare le navi del nemico. I nobili di San Marco, cui veniva affidato il comando delle galee, combattevano come belve. A Lepanto morirono in tanti. Agostino Barbarigo, Vincenzo Querini, Giovanni Loredan, Teodoro Balbi, Benedetto Soranzo, Marino Contarini. Un fiume di sangue blu.
Attracco nella baietta di Vrulje, lato Sud dell'isola maggiore. Ceniamo nell'unica locanda, tra magnolie e olivastri nel vento. Un fuoco acceso, un birrino a bordo, una notte piena di stelle. Nel silenzio, spuntano rumori minimali. Pesci sottobordo, il volo radente di un cormorano, lo sfrigolìo della strumentazione elettronica, il colpo di tosse in una barca francese ancorata cento metri più in là. A mezzanotte belano le capre; è un'ora strana, ma qui non ci sono alberi, e le bestie hanno dormicchiato tutto il giorno in qualche anfratto all'ombra. Solo di notte escono a pascolare. Vedo il caprone, l'occhio ardente come un tizzone, che scende a bere acqua di mare. L'unica disponibile. Sulla superficie liquida i suoni si propagano veloci, generano immagini, fantasie, paure. Bojan, il bravo marinaio di capitan Erni, ci ride su, dice che in una notte così si possono sentire i denti di cane mordere la chiglia. E i denti di cane, per chi non lo sa, sono microrganismi color ruggine che si attaccano ai galleggianti. Accanto a noi si àncora una barca di pescatori, la masnada beve vino, canta per tenersi sveglia prima della battuta in mare. Da questa parti c'è stata una sola guerra vera, quella per il pesce. Guerra tra pescatori pellegrini e stanziali, fra isola di Murter e Isola Lunga, tra Sebenico e Primosten. Qui, dicono, l'acqua è così ricca di vita che i sardoni saltano da soli nella rete.
L'anima dalmatica è tutta in questa baie. Il Comandante, che le conosce bene, pesca aneddoti nella sua lunga memoria. Dalmazia è una rete di pallanuoto buttata in acqua e un villaggio intero che gioca. È una barca soletta nel novilunio, un ragazzo a poppa che percuote l'acqua con una pignatta per spingere i pesci nella rete. Dalmazia è arrivare in un porticciolo, attraccare con la prua verso terra e sentire le rimostranze dei locali. Si sa, il buon velista non ormeggia con la poppa al largo, deve sempre essere pronto a partire. Ma talvolta capita di non avere tempo per la manovra; parcheggi al contrario e speri che nessuno ti noti. Sbagli, in Dalmazia ti notano tutti. Vengono a dirti: "No se pol". Tu nicchi, chiedi se dai fastidio. "No - ti rispondono - no xe per el fastidio. Xe per la marineria". Fu Tito a far scoprire questo paradiso agli italiani. Ci portò Gianni Agnelli in crociera. L'uomo della Fiat non vide il comunismo; vide solo una nuova Costa Smeralda. Dalmazia è un puerto escondido che la sera diventa viola, poi rosso spento, con una fisarmonica che miagola canzoni strappalacrime. A prima vista sembra Formentera, Monemvassia, Beirut, Amalfi, Tolone, Algeri. Un posto qualsiasi del Mediterraneo. Invece no. È una combinazione irripetibile di Venezia, slavità, Grecia, pirateria e ordine austriaco. Solo Dalmazia. *** Le Incoronate ti ubriacano, ti fanno dimenticare tutto. Anche Venezia. Eppure i suoi segni non ti abbandonano mai, anche in questo mare deserto senza porti, monumenti, cattedrali. Sono le bitte di pietra bianca, disseminate ovunque, anche in mezzo al nulla, per garantire gli attracchi. Il simbolo di una presenza discreta, che convisse con i costumi altrui e non volle convertire nessuno. Il marchio di fabbrica di un impero che guerreggiò ma anche commerciò col Turco. Una rete mercantile cui interessavano solo gli approdi. Un mondo dove orgoglio di bandiera e profitto, scrive Jan Morris, erano la stessa cosa. "Dove sono le merci là è casa nostra", dissero nel '400 i marinai di una galea intrappolata fra Turchi e Bizantini che se le davano di santa ragione. Dissero: moriremo su questa nave, perché è appunto "casa nostra". "Venezia fu l'unico impero capace di sovranità senza bisogno di territorio"; ricordo le parole della ricercatrice greca Anastasia Stouraiti alla mia partenza dalla Laguna. Le navi in viaggio per il Levante non dovevano fare soste in porti altrui. Tutto era rigidamente centralizzato, cronometrato. Far tardi significava sballare il mercato delle spezie a Rialto.
La barca è invasa dall'odor di rosmarino, l'alba verso Spalato è un incendio arancione violento, quasi africano. Più a Nord, la terraferma è ancora immersa in una foschia color vinaccia. Si riparte verso Sudest, ci seguono tre delfini. L'arcipelago improvvisa giochi di vento. Aria calda piena di salvia plana sulla barca appena ti avvicini alla terra. Se costeggi un'isola lunga, il "Maistro" rinforza in corrispondenza di ogni avallamento, poi rallenta sotto ogni altura. Verso le nove comincia il "Borin". È un gioco di bonacce e turbolenze, correnti, variazioni di fondale e di profumi. Corbezzoli, lentischi, mirti, olivastri, rosmarino. Isole burlone. Come i dalmati, popolo irriverente, eccentrico, sensuale e mangiapreti. Quando gli austriaci vennero qui a rifare le carte dell'Adriatico, vollero sapere dai pescatori i nomi di ogni scoglio. E i locali, di fronte a tanta pignoleria, si divertirono a scodellare nomi scurrili inventati. Prdusa Vela e Mala, grande e piccola scorreggia. Bubina Guzica, il culo della nonna. Kurba Mala e Vela, piccola e gran puttana. Bludni Rt, promontorio della libidine. Mrduja, merda, o giù di lì.
Capitan Erni, indomito, pilota la sua barca fuori dalle isole calve. Ha ottant'anni, cinque in più di Sebastiano Venier nel giorno di Lepanto. Tale Ferrante Caracciolo, che vide in azione l'ammiraglio, così scrive. "Conoscendosi decrepito, stava armato di una corazza all'antica, in pianelle, con una balestra in mano et in capelli combattendo coraggiosamente". Era un duro, Venier. Capace, come vedremo, di mandare "in mona" il comandante supremo della flotta, Don Giovanni d'Austria. Capitan Ernesto, invece, è una pasta d'uomo. Gli va bene tutto. Canticchia al timone verso Zirije, con rotta su Traù. Ernesto riflette che per tanti, oggi, Venezia è solo feste e carnevale, mentre poche città diedero al mondo tanti uomini di coraggio. La morte in battaglia era cosa normale, succedeva spesso che il capitano di una nave circondata si facesse saltare in aria pur di affondare le navi del nemico. I nobili di San Marco, cui veniva affidato il comando delle galee, combattevano come belve. A Lepanto morirono in tanti. Agostino Barbarigo, Vincenzo Querini, Giovanni Loredan, Teodoro Balbi, Benedetto Soranzo, Marino Contarini. Un fiume di sangue blu.
Paolo Rumiz
Paolo Rumiz, triestino, è scrittore e viaggiatore. Con Feltrinelli ha pubblicato La secessione leggera (2001), Tre uomini in bicicletta (con Francesco Altan; 2002), È Oriente (2003), La leggenda dei monti …