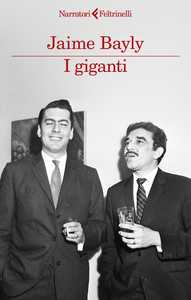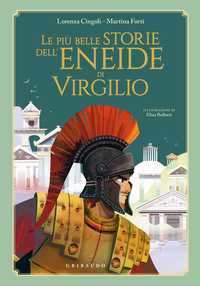Paolo Rumiz: La rotta per Lepanto. Aria d'oriente cruenta e dolce
24 Settembre 2004
Succede di notte, in mare aperto, a Sud di Valona. La barca ha un brivido, arriva uno strattone al boma e alla barra, le vele piene di maestrale si svuotano, si gonfiano al contrario. Non è solo un cambio di vento, è molto di più. Una trasfigurazione. Le stelle improvvisamente ardono, la temperatura aumenta di dieci gradi, il mare diventa "bastardo", la barca sbanda come un'ubriaca, l'aria diventa di montagna, ma rovente, secca come il Foehn. Cambia anche l'odore. Finisce il salso e la puzza di alghe. Comincia l'aria desertica dell'Oriente. La stessa degli altopiani afghani o del Turkestan cinese. Dieci fusi orari di mondo pastorale ci piombano addosso nella notte. Fiutiamo praterie ustionate dal sole, gelsomini e immondizie, erba bruciata, polvere e pelle di montone, ginepro, forse sangue. Un odore dolce e cruento; l'Oriente è tutto in questa coabitazione di dolcezza e violenza. È come la lentezza del guerriero afghano che prega al tramonto, una calma piatta che nasconde uragani. O l'anima grande dei russi che convive con l'orrore dei loro regimi. La gentilezza cinese che si sposa a raffinate crudeltà. Cominciano le visioni. Nel buio una donna in piedi sull'acqua urla e si sbraccia, avvolta in una tunica nera. Invece è un gavitello da pesca, con sopra un'asta e una bandiera stracciata che si agita nel vento. Sento che andiamo alla battaglia, al luogo del massacro, ma anche alle nostre sorgenti vitali. Torniamo come salmoni a Levante, il marchio d'origine dei popoli, dei monoteismi, delle civiltà. Tutto viene da lì, anche la parola Europa. Accadde a Bagdad, migliaia di anni fa, quando qualcuno guardò a a Occidente e disse: "Erebu", Terra del tramonto.
Nelle galere era difficile dormire in notti simili. Nel gran camerone, racconta alla fine del '400 il frate Felix Faber, nascevano "litigi e confusioni", chi alzava polvere scuotendo il giaciglio, chi attacca rissa col vicino che gli aveva occupato un po' di posto, e chi addirittura "sguainava la spada". Altri tiravano "l'orinale per spegnere una luce" che infastidiva, altri parlavano ad alta voce. E come se non bastasse, talvolta in coperta v'erano "muli e cavalli che scalpitavano". Spesso, insomma, non si chiudeva occhio. Figurarsi le notti sulle galere da guerra nel 1571, in quell'inizio d'autunno segnato dal maltempo, durante il viaggio verso la collisione con la flotta ottomana padrona dei Mari d'Oriente. L'ansia per il mito della sua invincibilità, le notizie tremende in arrivo da Cipro assediata, gli orrori favoleggiati del "Turcho crudelissimo". Forse non c'era tempo per litigare in quel terribile conto alla rovescia. Forse la notte sui banchi dei rematori, affranti di fatica, c'era solo silenzio.
A babordo l'ombra di un promontorio enorme, nero come la pece. Segna come il Purgatorio il pezzo più tempestoso di Otranto. Kara Burunit si chiama, non so cosa voglia dire, ma Burunit fa pensare a burrone. E "Kara" in turco vuol dire "nero". Come Karadzic, Karadjordjevic, i cognomi dei serbi usciti dal dominio ottomano. Kara come Karakorum, il secondo pilastro del cielo dopo l'Himalaia, la catena di ottomila metri che separa Cina e Pakistan. Dopo l'odore, un altro segno della continuità carovaniera che arriva fin nel centro dell'Asia. Piero e Alex vanno a ridurre le vele, spariscono verso il fiocco, la notte li inghiotte, il cielo stellato ondeggia lento sopra la crocietta d'albero. Il bompresso affonda in una spruzzaglia fosforica, poi esce e schizza in alto verso le stelle del Sud. Sottocoperta le voci della barca - il fasciame è sottoposto a sollecitazioni durissime - diventano animalesche, violente, sembrano un branco di bisonti in fuga. E poi frane, brividi, trascinar di catene. La reticella a forma di amaca che chiude frutta e verdura oscilla paurosamente accanto alle cuccette. I bambini continuano a dormire come anestetizzati dal beccheggio.
Alle quattro del mattino capitan Piero dorme a poppa rannicchiato nel sacco a pelo. Il sub-comandante Alex tiene la barra, per tenerlo sveglio gli racconto il dispiegamento delle flotte nei giorni precedenti allo scontro. La Santa Lega si raduna a Messina, dove arrivano spagnoli, papalini, piemontesi, genovesi. I veneziani vorrebbero restare a proteggere Corfù, ma il capo della coalizione, don Giovanni d'Austria, ordina loro di confluire nel luogo convenuto. È giovane, fanatico, narcisista; vuole tutti a Messina per la grande benedizione apostolica. Sebastiano Venier protesta, Venezia non ha simpatia per i bollori fondamentalisti del rampollo ispanico, soprattutto non ama muoversi a comando solo perché il Papa lo vuole. E poi conosce il Turco, ne prevede le mosse. E difatti, appena si muove per Messina, la flotta ottomana devasta Corfù, prima di ritirarsi a Lepanto per svernare. Il tempo volge al brutto, il Sultano crede che i cristiani non attaccheranno nell'imminenza della cattiva stagione. Parecchi ufficiali e giannizzeri prendono congedo, come se la campagna fosse terminata.
Dopo una notte così non sei più lo stesso, le tue idee sul tempo e la distanza cambiano. Quattro nodi sono un'andatura esasperante per un uomo del terzo millennio. Ma lentamente questa lentezza ti possiede. Ti invade un immenso, taciturno e incomunicabile rispetto della natura. Non sei più nessuno come individuo. Sei solo una delle anime che a milioni sono passate di qui. Pensi alle vite perdute, emigranti, pellegrini, illegali, soldati, contrabbandieri. Allora capisci le leggende di mare sulle voci, le ombre e i morti che ritornano. Il Comandante filosofeggia, spiega che nel mondo antico non contavano le distanze ma i giorni di cammino, dunque la velocità a cavallo o in barca. Cita Aristotele, dice che il tempo è "il numero del movimento", si lancia nell'affermazione che la barca "ripristina il nesso naturale fra il tempo e lo spazio". Descrive il settecentesco Trattato di geografia di Vincenzo Coronelli, il più grande cartografo veneziano, il suo fantastico Isolario che mostra le coste non come sono oggettivamente ma come le vede chi naviga. Non conta quanto è grande un promontorio, ma quanto è inconfondibile, dunque capace di dirti "dove sei".
Com'è buia l'Albania. Non una luce, niente di niente per trenta infinite miglia percorse controvento. La terra è nera, ecco perché Kara Burunit si dice così. Ti salva il cielo. Stelle a milioni, il timoniere viaggia naso per aria, l'orologiaio dell'universo gli dice la strada fra le costellazioni. Verso terra l'unica cosa luminosa sono gli incendi. In Albania i pastori bruciano tutto per fare pascoli; senti l'odore dell'erba bruciata a decine di miglia. Ardevano e ardono ancora mille fuochi attorno al Mediterraneo, sulla nostra rotta d'Oriente. Quelli di maggio sui monti dal Friuli alla Macedonia per celebrare la fertilità nel nome di San Giorgio o di San Floriano. I fuochi delle torri di guardia arabe e veneziane, costellazioni ardenti dall'Eubea a Cipro, da Malamocco ad Algeri. E poi, in tempo di novilunio, i roghi di piante resinose sulle barche da pesce azzurro, le "luminiere", falò naviganti antenati delle "lampare", accesi per catturar sgombri negli arcipelaghi della Dalmazia. Di notte arde anche l'immaginazione, ti porta ancora più lontano, in fondo al Mar Nero, oltre Trebisonda, sul Caucaso, verso i roghi divini di Zoroastro, i pozzi petroliferi sul Mar Caspio, le "pietre ardenti" - in persiano "Nafta" - sull'altopiano iranico. E le raffinerie del Golfo, i bivacchi dei nomadi ai confini dell'Afghanistan, i fuochi dei camionisti sulle rive dell'Indo, tra i monti dove finì la corsa di Alessandro il Grande.
Nelle galere era difficile dormire in notti simili. Nel gran camerone, racconta alla fine del '400 il frate Felix Faber, nascevano "litigi e confusioni", chi alzava polvere scuotendo il giaciglio, chi attacca rissa col vicino che gli aveva occupato un po' di posto, e chi addirittura "sguainava la spada". Altri tiravano "l'orinale per spegnere una luce" che infastidiva, altri parlavano ad alta voce. E come se non bastasse, talvolta in coperta v'erano "muli e cavalli che scalpitavano". Spesso, insomma, non si chiudeva occhio. Figurarsi le notti sulle galere da guerra nel 1571, in quell'inizio d'autunno segnato dal maltempo, durante il viaggio verso la collisione con la flotta ottomana padrona dei Mari d'Oriente. L'ansia per il mito della sua invincibilità, le notizie tremende in arrivo da Cipro assediata, gli orrori favoleggiati del "Turcho crudelissimo". Forse non c'era tempo per litigare in quel terribile conto alla rovescia. Forse la notte sui banchi dei rematori, affranti di fatica, c'era solo silenzio.
A babordo l'ombra di un promontorio enorme, nero come la pece. Segna come il Purgatorio il pezzo più tempestoso di Otranto. Kara Burunit si chiama, non so cosa voglia dire, ma Burunit fa pensare a burrone. E "Kara" in turco vuol dire "nero". Come Karadzic, Karadjordjevic, i cognomi dei serbi usciti dal dominio ottomano. Kara come Karakorum, il secondo pilastro del cielo dopo l'Himalaia, la catena di ottomila metri che separa Cina e Pakistan. Dopo l'odore, un altro segno della continuità carovaniera che arriva fin nel centro dell'Asia. Piero e Alex vanno a ridurre le vele, spariscono verso il fiocco, la notte li inghiotte, il cielo stellato ondeggia lento sopra la crocietta d'albero. Il bompresso affonda in una spruzzaglia fosforica, poi esce e schizza in alto verso le stelle del Sud. Sottocoperta le voci della barca - il fasciame è sottoposto a sollecitazioni durissime - diventano animalesche, violente, sembrano un branco di bisonti in fuga. E poi frane, brividi, trascinar di catene. La reticella a forma di amaca che chiude frutta e verdura oscilla paurosamente accanto alle cuccette. I bambini continuano a dormire come anestetizzati dal beccheggio.
Alle quattro del mattino capitan Piero dorme a poppa rannicchiato nel sacco a pelo. Il sub-comandante Alex tiene la barra, per tenerlo sveglio gli racconto il dispiegamento delle flotte nei giorni precedenti allo scontro. La Santa Lega si raduna a Messina, dove arrivano spagnoli, papalini, piemontesi, genovesi. I veneziani vorrebbero restare a proteggere Corfù, ma il capo della coalizione, don Giovanni d'Austria, ordina loro di confluire nel luogo convenuto. È giovane, fanatico, narcisista; vuole tutti a Messina per la grande benedizione apostolica. Sebastiano Venier protesta, Venezia non ha simpatia per i bollori fondamentalisti del rampollo ispanico, soprattutto non ama muoversi a comando solo perché il Papa lo vuole. E poi conosce il Turco, ne prevede le mosse. E difatti, appena si muove per Messina, la flotta ottomana devasta Corfù, prima di ritirarsi a Lepanto per svernare. Il tempo volge al brutto, il Sultano crede che i cristiani non attaccheranno nell'imminenza della cattiva stagione. Parecchi ufficiali e giannizzeri prendono congedo, come se la campagna fosse terminata.
Dopo una notte così non sei più lo stesso, le tue idee sul tempo e la distanza cambiano. Quattro nodi sono un'andatura esasperante per un uomo del terzo millennio. Ma lentamente questa lentezza ti possiede. Ti invade un immenso, taciturno e incomunicabile rispetto della natura. Non sei più nessuno come individuo. Sei solo una delle anime che a milioni sono passate di qui. Pensi alle vite perdute, emigranti, pellegrini, illegali, soldati, contrabbandieri. Allora capisci le leggende di mare sulle voci, le ombre e i morti che ritornano. Il Comandante filosofeggia, spiega che nel mondo antico non contavano le distanze ma i giorni di cammino, dunque la velocità a cavallo o in barca. Cita Aristotele, dice che il tempo è "il numero del movimento", si lancia nell'affermazione che la barca "ripristina il nesso naturale fra il tempo e lo spazio". Descrive il settecentesco Trattato di geografia di Vincenzo Coronelli, il più grande cartografo veneziano, il suo fantastico Isolario che mostra le coste non come sono oggettivamente ma come le vede chi naviga. Non conta quanto è grande un promontorio, ma quanto è inconfondibile, dunque capace di dirti "dove sei".
Com'è buia l'Albania. Non una luce, niente di niente per trenta infinite miglia percorse controvento. La terra è nera, ecco perché Kara Burunit si dice così. Ti salva il cielo. Stelle a milioni, il timoniere viaggia naso per aria, l'orologiaio dell'universo gli dice la strada fra le costellazioni. Verso terra l'unica cosa luminosa sono gli incendi. In Albania i pastori bruciano tutto per fare pascoli; senti l'odore dell'erba bruciata a decine di miglia. Ardevano e ardono ancora mille fuochi attorno al Mediterraneo, sulla nostra rotta d'Oriente. Quelli di maggio sui monti dal Friuli alla Macedonia per celebrare la fertilità nel nome di San Giorgio o di San Floriano. I fuochi delle torri di guardia arabe e veneziane, costellazioni ardenti dall'Eubea a Cipro, da Malamocco ad Algeri. E poi, in tempo di novilunio, i roghi di piante resinose sulle barche da pesce azzurro, le "luminiere", falò naviganti antenati delle "lampare", accesi per catturar sgombri negli arcipelaghi della Dalmazia. Di notte arde anche l'immaginazione, ti porta ancora più lontano, in fondo al Mar Nero, oltre Trebisonda, sul Caucaso, verso i roghi divini di Zoroastro, i pozzi petroliferi sul Mar Caspio, le "pietre ardenti" - in persiano "Nafta" - sull'altopiano iranico. E le raffinerie del Golfo, i bivacchi dei nomadi ai confini dell'Afghanistan, i fuochi dei camionisti sulle rive dell'Indo, tra i monti dove finì la corsa di Alessandro il Grande.
Paolo Rumiz
Paolo Rumiz, triestino, è scrittore e viaggiatore. Con Feltrinelli ha pubblicato La secessione leggera (2001), Tre uomini in bicicletta (con Francesco Altan; 2002), È Oriente (2003), La leggenda dei monti …