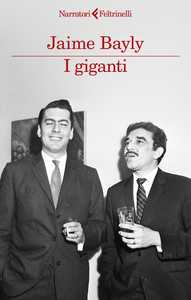Suad Amiry: Il funerale di Arafat
22 Dicembre 2004
‟Non andate lassù, c’è troppa gente”, ci ha detto uno degli innumerevoli ragazzini nelle strade di Ramallah. Abbiamo parcheggiato la macchina più vicino che potevamo, vale a dire a un quarto d’ora a piedi dalla casa di mia suocera.
Più andavamo avanti e più diventava difficile raggiungere la nostra destinazione. A ogni passo la folla si faceva più compatta e più densa. Strada facendo, ho incontrato Amira Hass e il suo fotografo, che stava trasportando una scala. ‟Affittare uno spazio negli edifici intorno alla Muqata’a è talmente caro che abbiamo deciso di portarci la nostra scala”, ha spiegato Amira. Persino un’israeliana progressista come Amira non riteneva che l’occasione valesse più del prezzo di una scala a pioli.
‟Non ti preoccupare Amira, ti porterò con me sul balcone di mia suocera.”
‟Davvero!”, mi ha risposto felice. ‟Sì, certo, ma ti prego, Amira, non dire a mia suocera e agli altri che sei israeliana. Oggi non è esattamente la giornata ideale”, le dico con un certo imbarazzo.
‟Che cosa le devo dire? Lo sai che non sono capace di mentire.”
‟Non dirle niente”, concludo.
Ci facciamo strada tra la folla.
‟Dammene due... o forse tre... anzi facciamo... quattro”, dico al ragazzino che vende dei palloncini bianchi su cui è stampata la foto in bianco e nero di Arafat.
D’un tratto mi ritorna in mente la scena del film di Elia Suleiman, Intervento divino: un identico palloncino (in quel caso rosso) vola in cielo e, sfidando l’esercito israeliano, supera i checkpont di Qalandia e di al-Ram e si spinge fino a Gerusalemme dove va a incoronare la Cupola della Roccia.
Quanto sarebbe piaciuto a Arafat e ad altri che altrettanto potesse succedere, oggi, alla sua bara!
In questo caso, però, ci sarebbe voluta un’immaginazione ancora più fertile e forse un miracolo di qualità superiore.
Lungo strada mi presentano a un giornalista del ‟New York Times”. Ben sapendo che i media americani hanno descritto Arafat in modo scorretto, decido di enfatizzare l’affetto e l’ammirazione che ho per lui:
‟Era un leader storico”.
‟Arafat era una figura iconica.”
‟Arafat era il simbolo del Movimento nazionale palestinese.”
‟Tutti i palestinesi hanno un debole per Arafat; tanto i suoi oppositori, quanto i suoi sostenitori; quando ci mettiamo a parlare di ciò che proviamo per Abu Ammar, siamo tutti schizofrenici.”
‟È merito di Arafat e dell’OLP se io e molti altri ci sentiamo orgogliosi di essere palestinesi” (il che è un tantino esagerato).
‟È merito di Arafat se oggi la Palestina e i palestinesi figurano sulla mappa e sull’agenda politica internazionale”.
‟È diventato un magnete per tutti i rifugiati palestinesi della diaspora.”
‟È stato la forza centrifuga attorno a cui si sono formati l’intero movimento di liberazione e la nazione.”
Sapevo che cominciava a suonare come una sfilza di luoghi comuni! Di certo non erano le cose che io e altri amici dicevamo a proposito di Arafat nelle nostre conversazioni diurne o nei nostri incontri serali. Ma, come si dice in arabo, alla il-mayyet la tajouz ella il-Rahmeh (i morti meritano solo benedizioni e buone parole).
Compresa la natura pubblicitaria della mia intervista, il bravo giornalista del ‟New York Times” mi interrompe garbatamente dicendo:
‟Grazie miiiiiiiiille, è stato davvero istruttivo”. La cortesia è quel che più mi piace degli americani, la sincerità è un altro paio di maniche. Ho visto che si girava dall’altra parte nella speranza di incontrare un analista più sottile e sofisticato.
Ho deciso di essere un po’ più critica con Christophe del quotidiano francese ‟Liberation”, anche in segno d’apprezzamento nei confronti di Chirac e della posizione assunta dalla Francia:
‟In qualche modo Arafat non è riuscito a compiere il salto necessario a trasformarlo, da leader di un movimento di liberazione, in capo di stato”, dico.
‟Non va dimenticato che non era nella natura di Arafat costruire istituzioni. Come ha scritto stamattina Mahmud Darwish: Abu Ammar era come un padre che non vuole che i figli crescano e diventino indipendenti’.
No, Arafat non era un ostacolo alla pace, come sostengono Sharon e Bush. È Sharon che non vuole rinunciare alla confisca di terre arabe e alla costruzione di insediamenti ebraici. Ecco perché Arafat non ha mai creduto alla serietà di Israele rispetto alla pace.
Penso che sia noi sia gli israeliani abbiamo perso una grande occasione, perché Arafat era l’unico leader in grado di mantenere le promesse. Ma nell’istante in cui è morto Rabin, Oslo è finita”.
Alla fine della seconda intervista, eravamo arrivati al caseggiato di mia suocera. Come in tutti gli altri edifici che danno sulla Muqata’a, una folla immensa stava cercando con le buone e con le cattive di raggiungere il tetto.
‟No, non puoi entrare”, mi dice un gigantesco guardiano che ha assunto il controllo sull’accesso al palazzo.
‟Ma cosa dici? Io abito qui”, gli rispondo con voce autorevole e piuttosto irritata.
Dopo qualche discussione e un po’ di tira-e-molla riusciamo a entrare.
Transitando dall’ancora più affollata scala del palazzo, arriviamo al secondo piano. La porta dell’appartamento di Umm Salim è spalancata. Lei è lì in piedi, in preda allo shock. Sapevo che, mentre molti di noi avevano una relazione di amore/odio nei confronti di Arafat, lei lo adorava senza riserve.
Le avevo sentito dire spesso: ‟Poverino, sono così triste per lui. Nessun altro ha mai sacrificato la propria vita come ha fatto lui. Non capisco come faccia a vivere in condizioni così terribili, in mezzo a tutta quella polvere”. Come ogni donna di casa, Umm Salim era convinta che per Arafat il problema più grave fosse che alla Muqata’a c’era troppa polvere. E chissà che un giorno la cartella clinica francese non dimostri che aveva ragione!
‟Ciao mamma, yeslam rasek (mi rincresce per la morte di Arafat)”, la bacio.
Ha l’aria totalmente sopraffatta.
‟Chi sono queste persone? Come mai tutti questi estranei hanno occupato il mio balcone? In vita mia non ho mai visto gente tanto maleducata; non mi hanno nemmeno avvertita che sarebbero venuti. Io non vado in visita nemmeno dagli amici più stretti senza avvisarli prima. Ma non so chi sono...”, continua a ripetere.
‟Ma mamma, questo è un giorno molto speciale, Arafat non muore tutti i giorni, tutti vogliono assistere a questo momento storico”, cerco invano di tranquillizzarla.
‟Smettila di spostare i mobili”, urla Umm Salim.
‟Stiamo cercando di fare più spazio, in modo che più gente possa vedere”, sento dire a Sawsan da lontano. Povera Sawsan, mi dico.
‟Come più gente? No!” Umm Salim va alla porta dell’appartamento e sento che dà due giri di chiave. Poi si precipita verso Mohammad, che sta cercando di liberare la finestra dai vasi di piante. ‟Smettila!”, grida al povero Mohammad che sta solo cercando di rendersi utile. ‟Ma se non le sposto, la gente le rovinerà”. Rendendosi conto delle buone intenzioni di Mohammad, lei lo lascia fare, ma lo segue come un’ombra per controllare dove mette le piante.
Attraverso il salone e raggiungo il balcone, tirandomi dietro Salim, Rima, Alex, Amira e il suo fotografo con la scala. Con la coda dell’occhio vedo Umm Salim marciare sul fotografo israeliano e urlargli: ‟Perché la scala?” Gli ho suggerito di lasciarla fuori, cosa che lui ha fatto. Deve aver pensato che Umm Salim abbia fiutato che è israeliano.
Conoscendo mia suocera piuttosto bene, ho deciso di ignorarla per tutto il pomeriggio e di risparmiare la mia energia per l’occasione.
Ero sbalordita. Umm Salim aveva assolutamente ragione: come aveva fatto tutta quella gente a raggiungere il suo balcone?
‟Hi Sawsan, hi Samira, ciao Rose, marhaba Jihan, salam Nazmi, keefak Iyad, sahar, yara, benvenuta Dina. Questo è tuo figlio? E queste sono le tue due figlie! Perbacco, come sono cresciute!” Erano anni che non vedevo Dina. A forza di occuparmi degli ospiti, stavo quasi dimenticando perché ero lì: ‟hi Mohammad, salam Mohannad, Fadwa, ciao Marcellino, keefak habibi”, lo accarezzo sulla testa. ‟Hi Daoud, ciao Naylah, quando sei tornata dallo Yemen? Marhaba Khaldoun, Alyisar, Imad, Rana, Nura e Michel ”
Pur sforzandomi, non riuscivo a capire come avesse fatto quell’intera e numerosa famiglia a raggiungere il nostro balcone. Capendo la stranezza della situazione, la donna mi si è avvicinata e mi ha detto: ‟Forse non ti ricordi di me, sono la cognata di Janin, questo è mio marito, queste le mie tre figlie, i miei figli, e i bambini nel salone sono i miei nipoti”.
Salim e Rima si sono messi a dare una mano a Mohammad nel tentativo di sgombrare il balcone dai mobili, in modo da creare più spazio. Sembrava che Umm Salim si fosse definitivamente arresa al fatto; infatti stava dando loro istruzioni. Come spesso in casi del genere, facevo finta di ignorarla, anche se da lontano le tenevo nevroticamente gli occhi puntati addosso.
Dio, è il funerale del nostro beneamato presidente ed eccoci tutti qui a occuparci ossessivamente di faccende mondane.
Ho deciso di concentrarmi sull’evento che ci aveva riuniti tutti in quella casa.
Davanti al balcone, sotto i miei occhi, c’era un mare in tempesta: decine di migliaia di giovani uomini (shabab) erano riusciti a entrare nella Muqata’a o a disporsi attorno ad essa.
La gente era salita su qualsiasi cosa sovrastasse il quartier generale: tetti degli edifici, serbatoi d’acqua, balconi, terrazzi, tetti dei garage, muretti dei giardini, mura di cinta del compound stesso, cumuli di macerie. I giovani fisicamente più in forma e più vigorosi stavano salendo su alberi di ogni tipo e misura. Nei giardini ai piedi del nostro balcone i rami degli ulivi ondeggiavano sotto il peso di decine di giovani appollaiati a mo’ di scimmia. I tre grandi cipressi attorno alla tomba in pietra che nel giro di qualche minuto avrebbe dovuto accogliere il corpo di Arafat formicolavano di shabab. Con una mano si tenevano al tronco e ai rami dell’albero, mentre con l’altra sventolavano enormi bandiere e fotografie di Arafat.
Osservando gli shabab che si arrampicavano sui pali dell’elettricità mi sono resa conto che la Palestina potrebbe competere tranquillamente con i circhi russi e rumeni.
Sul palo elettrico proprio di fronte a noi erano saliti cinque uomini: tre si tenevano aggrappati al palo, il quarto si era seduto sulla scatola elettrica appesa ad esso, e il più fortunato (o forse il più pigro) se ne stava seduto rilassato in cima al palo. Alla nostra destra c’era un giovane che aveva un palo tutto per sé e ci stava seduto sopra nel più elegante del modi: sistemate le chiappe in cima al palo, aveva disteso la gamba sinistra sul filo elettrico, a un’altezza di circa otto metri.
Il funerale doveva essere riservato solo ai funzionari del governo e ai dignitari, che venivano accuratamente perquisiti prima di valicare i cancelli di ferro del compound. Le centinaia di uomini della sicurezza, venuti da diverse città palestinesi (chi in divisa kaki, chi in blu scuro, altri in uniforme da guerriglia, chi con il berretto rosso, chi verde) erano sepolti in un mare crescente di folla, che continuava a scavalcare il muro di cemento alto tre metri ricoperto di filo spinato. Il filo spinato veniva a poco a poco strappato per agevolare il passaggio degli shabab. Gli uomini della sicurezza tentavano disperatamente di non perdere la battaglia contro la fiumana che stava riversandosi sulle mura della Muqata’a. Invano, visto che i giovani shabab erano inarrestabili come le gocce di un violento acquazzone.
Nel mezzo c’era la banda militare. I suonatori avevano un aspetto fiducioso; da lontano riuscivamo a vederli, ma non a sentire il suono dei loro tamburi, trombe, tromboni e cornamuse. Ben presto, tuttavia, loro e i loro strumenti musicali sono stati inghiottiti dall’onda di piena.
Funzionari del governo e dignitari, per lo più in abiti blu scuro o uggiosi completi grigi (non ho mai capito perché, quando si mettono in tiro, gli uomini si somiglino così tanto, persino dopo aver passato un bel po’ di tempo e speso un sacco di soldi a scegliere con cura l’abito che indosseranno), non avevano rinunciato al protocollo del funerale di stato nonostante le violente e tempestose ondate di giovani, che si abbattevano su di loro da ogni parte. In men che non si dica era diventato impossibile distinguere tra uomini della sicurezza, banda musicale, funzionari del governo e dignitari; erano stati tutti sommersi dalle ondate tempestose di una massa amorfa e colorata, e parzialmente coperti da centinaia di bandiere palestinesi, un pugno di bandiere francesi e una canadese. Mancavano le verdi bandiere utilizzate dai musulmani (unica eccezione, il vessillo che sventolava in cima a un edificio nei pressi della Muqata’a).
Qualunque cosa la banda musicale avesse avuto intenzione di suonare, era stata sostituita da una salva di colpi d’arma da fuoco e da un grido salmodiato:
Yasser tak tak tak (clap, clap, clap)
Yasser tak tak tak (clap, clap, clap)
Yasser tak tak tak
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
STAVAMO ASPETTANDO CON ANSIA il corpo di Arafat che doveva arrivare in volo dal Cairo.
Erano esattamente le 14.30 quando abbiamo cominciato a sentire sulle nostre teste il ronzio degli elicotteri. Il momento della verità era finalmente giunto. Ci sono voluti solo pochi secondi prima che il cielo si aprisse. Impossibile ormai distinguere il rumore dei colpi d’arma da fuoco sparati dalle centinaia di uomini della sicurezza e di attivisti politici, le urla dei presenti al funerale, gli slogan lanciati dall’alto dei tetti e degli edifici, i ritornelli scanditi dalle scimmie arrampicate sugli alberi, l’eco del turbolento mare umano all’interno della Muqata’a.
E la bufera di polvere creata dai due elicotteri egiziani non ha fatto che aggiungere tragedia a una scena già drammatica in sé.. Per qualche secondo abbiamo perso di vista la scena. Quando abbiamo recuperato la nostra visione, chi era caduto dagli alberi, chi penzolava nel vuoto aggrappato ai fili dell’elettricità, mentre molti altri attorno agli elicotteri erano stati letteralmente spazzati via. Sembrava un dipinto di Bruegel, non sapevo esattamente quale, forse ‟Così va il mondo: ciechi che guidano ciechi”.
Ci sono voluti pochi secondi prima che le due zone semicircolari vuote create dai due elicotteri si riempissero nuovamente di corpi umani. Le onde umane o ciò che in quel momento somigliava piuttosto alle tauz (dune di sabbia formate dalla forza del vento) si erano aperte per fare spazio agli elicotteri. Per una frazione di secondo sono riuscita a vedere il tappeto rosso lungo il quale si sarebbe dovuta svolgere la prevista processione militare ufficiale (accompagnata dalla banda militare al suono dell’inno nazionale palestinese).
Le masse in attesa erano ora ferme sotto gli elicotteri a mezz’aria, che ben presto sarebbero stato circondati e inghiottiti dalla folla.
In quel momento esatto, non era chiaro se stessimo contando i secondi che ci separavano dall’atterraggio degli elicotteri o se ne avessimo paura.
Ci sono stati alcuni minuti di contemplazione prima che quel mare di gente decidesse che direzione prendere.
Le teste di Sa’eb Erekat e Abed Rabbo (che accompagnavano il corpo di Arafat) si sono affacciate allo sportello di sinistra dell’elicottero che stava alla nostra destra. Tuttavia era impossibile spalancare lo sportello senza ferire seriamente qualcuno. Le due teste sono scomparse rapidamente dietro lo sportello chiuso, perdendo un’opportunità d’oro in vista della prossima campagna elettorale.
È successo un po’ prima che riuscissimo a vedere la bara di Arafat, avvolta nella bandiera palestinese, apparire dall’altra parte dello stesso elicottero.
Il mare ondeggiante è rifluito con forza verso destra.
Da quel momento il funerale ha acquistato una vita tutta sua: Sa’eb e Abed sono stati, come il resto dei funzionari governativi e dei dignitari, spazzati via dal forte riflusso.
La moltitudine popolare aveva deciso: ARAFAT È NOSTRO.
Il corpo di Arafat si è librato sulla testa della gente. Era come un’assicella che naviga nella direzione imposta da una burrasca forte e benigna.
Se i vecchi dell’OLP e i funzionari del governo si erano arresi alla moltitudine popolare, i giovani uomini della sicurezza non lo avevano certo fatto.
Pareva che, tra i giovani armati e in uniforme della sicurezza e gli shabab (giovani senza uniforme, ma forniti di qualche arma), la battaglia per il corpo del beneamato fosse appena cominciata.
Lo spettacolo a colpi di arma da fuoco che si è svolto sotto i nostri occhi sembrava il match finale e decisivo di una partita per l’eternità.
Abbiamo visto una jeep militare che cercava di farsi strada tra la folla ondeggiante; è stato una specie di miracolo che siano riusciti a caricarci sopra la bara. All’apparenza gli uomini della sicurezza avevano messo a segno il primo goal.
Ci sono volute circa due ore prima che le due squadre riuscissero a deporre la bara di Arafat nella fossa costruita a meno di trecento metri dal punto da cui era partita.
Solo quando quella massa umana ha cominciato a assottigliarsi abbiamo capito che il corpo e noi con lui poteva riposare in pace.
E solo il giorno dopo il funerale, dalle pagine del quotidiano ‟al-Ayam”, abbiamo appreso quale sarebbe dovuta essere la marasim (logistica) ufficiale della cerimonia funebre.
Quel giorno il comando era passato nelle mani delle masse.
Tahia al jamaheer (lunga vita alle masse)!!!
Traduzione dall’inglese di Maria Nadotti
Più andavamo avanti e più diventava difficile raggiungere la nostra destinazione. A ogni passo la folla si faceva più compatta e più densa. Strada facendo, ho incontrato Amira Hass e il suo fotografo, che stava trasportando una scala. ‟Affittare uno spazio negli edifici intorno alla Muqata’a è talmente caro che abbiamo deciso di portarci la nostra scala”, ha spiegato Amira. Persino un’israeliana progressista come Amira non riteneva che l’occasione valesse più del prezzo di una scala a pioli.
‟Non ti preoccupare Amira, ti porterò con me sul balcone di mia suocera.”
‟Davvero!”, mi ha risposto felice. ‟Sì, certo, ma ti prego, Amira, non dire a mia suocera e agli altri che sei israeliana. Oggi non è esattamente la giornata ideale”, le dico con un certo imbarazzo.
‟Che cosa le devo dire? Lo sai che non sono capace di mentire.”
‟Non dirle niente”, concludo.
Ci facciamo strada tra la folla.
‟Dammene due... o forse tre... anzi facciamo... quattro”, dico al ragazzino che vende dei palloncini bianchi su cui è stampata la foto in bianco e nero di Arafat.
D’un tratto mi ritorna in mente la scena del film di Elia Suleiman, Intervento divino: un identico palloncino (in quel caso rosso) vola in cielo e, sfidando l’esercito israeliano, supera i checkpont di Qalandia e di al-Ram e si spinge fino a Gerusalemme dove va a incoronare la Cupola della Roccia.
Quanto sarebbe piaciuto a Arafat e ad altri che altrettanto potesse succedere, oggi, alla sua bara!
In questo caso, però, ci sarebbe voluta un’immaginazione ancora più fertile e forse un miracolo di qualità superiore.
Lungo strada mi presentano a un giornalista del ‟New York Times”. Ben sapendo che i media americani hanno descritto Arafat in modo scorretto, decido di enfatizzare l’affetto e l’ammirazione che ho per lui:
‟Era un leader storico”.
‟Arafat era una figura iconica.”
‟Arafat era il simbolo del Movimento nazionale palestinese.”
‟Tutti i palestinesi hanno un debole per Arafat; tanto i suoi oppositori, quanto i suoi sostenitori; quando ci mettiamo a parlare di ciò che proviamo per Abu Ammar, siamo tutti schizofrenici.”
‟È merito di Arafat e dell’OLP se io e molti altri ci sentiamo orgogliosi di essere palestinesi” (il che è un tantino esagerato).
‟È merito di Arafat se oggi la Palestina e i palestinesi figurano sulla mappa e sull’agenda politica internazionale”.
‟È diventato un magnete per tutti i rifugiati palestinesi della diaspora.”
‟È stato la forza centrifuga attorno a cui si sono formati l’intero movimento di liberazione e la nazione.”
Sapevo che cominciava a suonare come una sfilza di luoghi comuni! Di certo non erano le cose che io e altri amici dicevamo a proposito di Arafat nelle nostre conversazioni diurne o nei nostri incontri serali. Ma, come si dice in arabo, alla il-mayyet la tajouz ella il-Rahmeh (i morti meritano solo benedizioni e buone parole).
Compresa la natura pubblicitaria della mia intervista, il bravo giornalista del ‟New York Times” mi interrompe garbatamente dicendo:
‟Grazie miiiiiiiiille, è stato davvero istruttivo”. La cortesia è quel che più mi piace degli americani, la sincerità è un altro paio di maniche. Ho visto che si girava dall’altra parte nella speranza di incontrare un analista più sottile e sofisticato.
Ho deciso di essere un po’ più critica con Christophe del quotidiano francese ‟Liberation”, anche in segno d’apprezzamento nei confronti di Chirac e della posizione assunta dalla Francia:
‟In qualche modo Arafat non è riuscito a compiere il salto necessario a trasformarlo, da leader di un movimento di liberazione, in capo di stato”, dico.
‟Non va dimenticato che non era nella natura di Arafat costruire istituzioni. Come ha scritto stamattina Mahmud Darwish: Abu Ammar era come un padre che non vuole che i figli crescano e diventino indipendenti’.
No, Arafat non era un ostacolo alla pace, come sostengono Sharon e Bush. È Sharon che non vuole rinunciare alla confisca di terre arabe e alla costruzione di insediamenti ebraici. Ecco perché Arafat non ha mai creduto alla serietà di Israele rispetto alla pace.
Penso che sia noi sia gli israeliani abbiamo perso una grande occasione, perché Arafat era l’unico leader in grado di mantenere le promesse. Ma nell’istante in cui è morto Rabin, Oslo è finita”.
Alla fine della seconda intervista, eravamo arrivati al caseggiato di mia suocera. Come in tutti gli altri edifici che danno sulla Muqata’a, una folla immensa stava cercando con le buone e con le cattive di raggiungere il tetto.
‟No, non puoi entrare”, mi dice un gigantesco guardiano che ha assunto il controllo sull’accesso al palazzo.
‟Ma cosa dici? Io abito qui”, gli rispondo con voce autorevole e piuttosto irritata.
Dopo qualche discussione e un po’ di tira-e-molla riusciamo a entrare.
Transitando dall’ancora più affollata scala del palazzo, arriviamo al secondo piano. La porta dell’appartamento di Umm Salim è spalancata. Lei è lì in piedi, in preda allo shock. Sapevo che, mentre molti di noi avevano una relazione di amore/odio nei confronti di Arafat, lei lo adorava senza riserve.
Le avevo sentito dire spesso: ‟Poverino, sono così triste per lui. Nessun altro ha mai sacrificato la propria vita come ha fatto lui. Non capisco come faccia a vivere in condizioni così terribili, in mezzo a tutta quella polvere”. Come ogni donna di casa, Umm Salim era convinta che per Arafat il problema più grave fosse che alla Muqata’a c’era troppa polvere. E chissà che un giorno la cartella clinica francese non dimostri che aveva ragione!
‟Ciao mamma, yeslam rasek (mi rincresce per la morte di Arafat)”, la bacio.
Ha l’aria totalmente sopraffatta.
‟Chi sono queste persone? Come mai tutti questi estranei hanno occupato il mio balcone? In vita mia non ho mai visto gente tanto maleducata; non mi hanno nemmeno avvertita che sarebbero venuti. Io non vado in visita nemmeno dagli amici più stretti senza avvisarli prima. Ma non so chi sono...”, continua a ripetere.
‟Ma mamma, questo è un giorno molto speciale, Arafat non muore tutti i giorni, tutti vogliono assistere a questo momento storico”, cerco invano di tranquillizzarla.
‟Smettila di spostare i mobili”, urla Umm Salim.
‟Stiamo cercando di fare più spazio, in modo che più gente possa vedere”, sento dire a Sawsan da lontano. Povera Sawsan, mi dico.
‟Come più gente? No!” Umm Salim va alla porta dell’appartamento e sento che dà due giri di chiave. Poi si precipita verso Mohammad, che sta cercando di liberare la finestra dai vasi di piante. ‟Smettila!”, grida al povero Mohammad che sta solo cercando di rendersi utile. ‟Ma se non le sposto, la gente le rovinerà”. Rendendosi conto delle buone intenzioni di Mohammad, lei lo lascia fare, ma lo segue come un’ombra per controllare dove mette le piante.
Attraverso il salone e raggiungo il balcone, tirandomi dietro Salim, Rima, Alex, Amira e il suo fotografo con la scala. Con la coda dell’occhio vedo Umm Salim marciare sul fotografo israeliano e urlargli: ‟Perché la scala?” Gli ho suggerito di lasciarla fuori, cosa che lui ha fatto. Deve aver pensato che Umm Salim abbia fiutato che è israeliano.
Conoscendo mia suocera piuttosto bene, ho deciso di ignorarla per tutto il pomeriggio e di risparmiare la mia energia per l’occasione.
Ero sbalordita. Umm Salim aveva assolutamente ragione: come aveva fatto tutta quella gente a raggiungere il suo balcone?
‟Hi Sawsan, hi Samira, ciao Rose, marhaba Jihan, salam Nazmi, keefak Iyad, sahar, yara, benvenuta Dina. Questo è tuo figlio? E queste sono le tue due figlie! Perbacco, come sono cresciute!” Erano anni che non vedevo Dina. A forza di occuparmi degli ospiti, stavo quasi dimenticando perché ero lì: ‟hi Mohammad, salam Mohannad, Fadwa, ciao Marcellino, keefak habibi”, lo accarezzo sulla testa. ‟Hi Daoud, ciao Naylah, quando sei tornata dallo Yemen? Marhaba Khaldoun, Alyisar, Imad, Rana, Nura e Michel ”
Pur sforzandomi, non riuscivo a capire come avesse fatto quell’intera e numerosa famiglia a raggiungere il nostro balcone. Capendo la stranezza della situazione, la donna mi si è avvicinata e mi ha detto: ‟Forse non ti ricordi di me, sono la cognata di Janin, questo è mio marito, queste le mie tre figlie, i miei figli, e i bambini nel salone sono i miei nipoti”.
Salim e Rima si sono messi a dare una mano a Mohammad nel tentativo di sgombrare il balcone dai mobili, in modo da creare più spazio. Sembrava che Umm Salim si fosse definitivamente arresa al fatto; infatti stava dando loro istruzioni. Come spesso in casi del genere, facevo finta di ignorarla, anche se da lontano le tenevo nevroticamente gli occhi puntati addosso.
Dio, è il funerale del nostro beneamato presidente ed eccoci tutti qui a occuparci ossessivamente di faccende mondane.
Ho deciso di concentrarmi sull’evento che ci aveva riuniti tutti in quella casa.
Davanti al balcone, sotto i miei occhi, c’era un mare in tempesta: decine di migliaia di giovani uomini (shabab) erano riusciti a entrare nella Muqata’a o a disporsi attorno ad essa.
La gente era salita su qualsiasi cosa sovrastasse il quartier generale: tetti degli edifici, serbatoi d’acqua, balconi, terrazzi, tetti dei garage, muretti dei giardini, mura di cinta del compound stesso, cumuli di macerie. I giovani fisicamente più in forma e più vigorosi stavano salendo su alberi di ogni tipo e misura. Nei giardini ai piedi del nostro balcone i rami degli ulivi ondeggiavano sotto il peso di decine di giovani appollaiati a mo’ di scimmia. I tre grandi cipressi attorno alla tomba in pietra che nel giro di qualche minuto avrebbe dovuto accogliere il corpo di Arafat formicolavano di shabab. Con una mano si tenevano al tronco e ai rami dell’albero, mentre con l’altra sventolavano enormi bandiere e fotografie di Arafat.
Osservando gli shabab che si arrampicavano sui pali dell’elettricità mi sono resa conto che la Palestina potrebbe competere tranquillamente con i circhi russi e rumeni.
Sul palo elettrico proprio di fronte a noi erano saliti cinque uomini: tre si tenevano aggrappati al palo, il quarto si era seduto sulla scatola elettrica appesa ad esso, e il più fortunato (o forse il più pigro) se ne stava seduto rilassato in cima al palo. Alla nostra destra c’era un giovane che aveva un palo tutto per sé e ci stava seduto sopra nel più elegante del modi: sistemate le chiappe in cima al palo, aveva disteso la gamba sinistra sul filo elettrico, a un’altezza di circa otto metri.
Il funerale doveva essere riservato solo ai funzionari del governo e ai dignitari, che venivano accuratamente perquisiti prima di valicare i cancelli di ferro del compound. Le centinaia di uomini della sicurezza, venuti da diverse città palestinesi (chi in divisa kaki, chi in blu scuro, altri in uniforme da guerriglia, chi con il berretto rosso, chi verde) erano sepolti in un mare crescente di folla, che continuava a scavalcare il muro di cemento alto tre metri ricoperto di filo spinato. Il filo spinato veniva a poco a poco strappato per agevolare il passaggio degli shabab. Gli uomini della sicurezza tentavano disperatamente di non perdere la battaglia contro la fiumana che stava riversandosi sulle mura della Muqata’a. Invano, visto che i giovani shabab erano inarrestabili come le gocce di un violento acquazzone.
Nel mezzo c’era la banda militare. I suonatori avevano un aspetto fiducioso; da lontano riuscivamo a vederli, ma non a sentire il suono dei loro tamburi, trombe, tromboni e cornamuse. Ben presto, tuttavia, loro e i loro strumenti musicali sono stati inghiottiti dall’onda di piena.
Funzionari del governo e dignitari, per lo più in abiti blu scuro o uggiosi completi grigi (non ho mai capito perché, quando si mettono in tiro, gli uomini si somiglino così tanto, persino dopo aver passato un bel po’ di tempo e speso un sacco di soldi a scegliere con cura l’abito che indosseranno), non avevano rinunciato al protocollo del funerale di stato nonostante le violente e tempestose ondate di giovani, che si abbattevano su di loro da ogni parte. In men che non si dica era diventato impossibile distinguere tra uomini della sicurezza, banda musicale, funzionari del governo e dignitari; erano stati tutti sommersi dalle ondate tempestose di una massa amorfa e colorata, e parzialmente coperti da centinaia di bandiere palestinesi, un pugno di bandiere francesi e una canadese. Mancavano le verdi bandiere utilizzate dai musulmani (unica eccezione, il vessillo che sventolava in cima a un edificio nei pressi della Muqata’a).
Qualunque cosa la banda musicale avesse avuto intenzione di suonare, era stata sostituita da una salva di colpi d’arma da fuoco e da un grido salmodiato:
Yasser tak tak tak (clap, clap, clap)
Yasser tak tak tak (clap, clap, clap)
Yasser tak tak tak
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
STAVAMO ASPETTANDO CON ANSIA il corpo di Arafat che doveva arrivare in volo dal Cairo.
Erano esattamente le 14.30 quando abbiamo cominciato a sentire sulle nostre teste il ronzio degli elicotteri. Il momento della verità era finalmente giunto. Ci sono voluti solo pochi secondi prima che il cielo si aprisse. Impossibile ormai distinguere il rumore dei colpi d’arma da fuoco sparati dalle centinaia di uomini della sicurezza e di attivisti politici, le urla dei presenti al funerale, gli slogan lanciati dall’alto dei tetti e degli edifici, i ritornelli scanditi dalle scimmie arrampicate sugli alberi, l’eco del turbolento mare umano all’interno della Muqata’a.
E la bufera di polvere creata dai due elicotteri egiziani non ha fatto che aggiungere tragedia a una scena già drammatica in sé.. Per qualche secondo abbiamo perso di vista la scena. Quando abbiamo recuperato la nostra visione, chi era caduto dagli alberi, chi penzolava nel vuoto aggrappato ai fili dell’elettricità, mentre molti altri attorno agli elicotteri erano stati letteralmente spazzati via. Sembrava un dipinto di Bruegel, non sapevo esattamente quale, forse ‟Così va il mondo: ciechi che guidano ciechi”.
Ci sono voluti pochi secondi prima che le due zone semicircolari vuote create dai due elicotteri si riempissero nuovamente di corpi umani. Le onde umane o ciò che in quel momento somigliava piuttosto alle tauz (dune di sabbia formate dalla forza del vento) si erano aperte per fare spazio agli elicotteri. Per una frazione di secondo sono riuscita a vedere il tappeto rosso lungo il quale si sarebbe dovuta svolgere la prevista processione militare ufficiale (accompagnata dalla banda militare al suono dell’inno nazionale palestinese).
Le masse in attesa erano ora ferme sotto gli elicotteri a mezz’aria, che ben presto sarebbero stato circondati e inghiottiti dalla folla.
In quel momento esatto, non era chiaro se stessimo contando i secondi che ci separavano dall’atterraggio degli elicotteri o se ne avessimo paura.
Ci sono stati alcuni minuti di contemplazione prima che quel mare di gente decidesse che direzione prendere.
Le teste di Sa’eb Erekat e Abed Rabbo (che accompagnavano il corpo di Arafat) si sono affacciate allo sportello di sinistra dell’elicottero che stava alla nostra destra. Tuttavia era impossibile spalancare lo sportello senza ferire seriamente qualcuno. Le due teste sono scomparse rapidamente dietro lo sportello chiuso, perdendo un’opportunità d’oro in vista della prossima campagna elettorale.
È successo un po’ prima che riuscissimo a vedere la bara di Arafat, avvolta nella bandiera palestinese, apparire dall’altra parte dello stesso elicottero.
Il mare ondeggiante è rifluito con forza verso destra.
Da quel momento il funerale ha acquistato una vita tutta sua: Sa’eb e Abed sono stati, come il resto dei funzionari governativi e dei dignitari, spazzati via dal forte riflusso.
La moltitudine popolare aveva deciso: ARAFAT È NOSTRO.
Il corpo di Arafat si è librato sulla testa della gente. Era come un’assicella che naviga nella direzione imposta da una burrasca forte e benigna.
Se i vecchi dell’OLP e i funzionari del governo si erano arresi alla moltitudine popolare, i giovani uomini della sicurezza non lo avevano certo fatto.
Pareva che, tra i giovani armati e in uniforme della sicurezza e gli shabab (giovani senza uniforme, ma forniti di qualche arma), la battaglia per il corpo del beneamato fosse appena cominciata.
Lo spettacolo a colpi di arma da fuoco che si è svolto sotto i nostri occhi sembrava il match finale e decisivo di una partita per l’eternità.
Abbiamo visto una jeep militare che cercava di farsi strada tra la folla ondeggiante; è stato una specie di miracolo che siano riusciti a caricarci sopra la bara. All’apparenza gli uomini della sicurezza avevano messo a segno il primo goal.
Ci sono volute circa due ore prima che le due squadre riuscissero a deporre la bara di Arafat nella fossa costruita a meno di trecento metri dal punto da cui era partita.
Solo quando quella massa umana ha cominciato a assottigliarsi abbiamo capito che il corpo e noi con lui poteva riposare in pace.
E solo il giorno dopo il funerale, dalle pagine del quotidiano ‟al-Ayam”, abbiamo appreso quale sarebbe dovuta essere la marasim (logistica) ufficiale della cerimonia funebre.
Quel giorno il comando era passato nelle mani delle masse.
Tahia al jamaheer (lunga vita alle masse)!!!
Traduzione dall’inglese di Maria Nadotti
Suad Amiry
Suad Amiry (1951) è un’architetta palestinese, fondatrice e direttrice del Riwaq Center for Architectural Conservation a Ramallah. Cresciuta tra Amman, Damasco, Beirut e Il Cairo, ha studiato architettura all’American University …