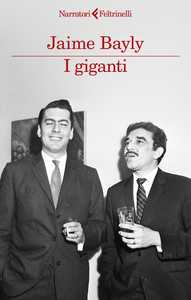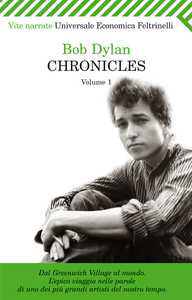Dylan, vita della mia vita
11 Gennaio 2005
Proviamo a immaginare la scena. L’occasione: un convegno su "Poesia e canzone". Il luogo: l’aula magna di un’università o di un liceo, forse occupata. Il tempo: una data imprecisata fra l’inizio degli anni settanta e qualche mese fa (i dibattiti su "Poesia e canzone" si svolgono sempre in un tempo indefinito, e comunque alcuni esperti continuano a ripetere le stesse cose da trent’anni in qua). Prende la parola una specialista di letteratura angloamericana. L’amplificazione non funziona. L’oratrice soffia nel microfono (non si fa!), poi sente un fischio e copre il microfono con le mani (non si fa!) Rivelando che fra la pagina scritta e il fenomeno misterioso della voce amplificata c’è un divario incolmabile, in teoria e in pratica. Adesso si sente. Bene! L’oratrice parla di Bob Dylan, della New York della fine degli anni cinquanta, inizio dei sessanta, e della beat generation, e di Kerouac, Corso, Ferlinghetti: certo, è da lì che viene, è lì che è cresciuto. Interviene lo studioso delle tradizioni popolari: ma non bisogna dimenticare Woody Guthrie e il blues, e il fatto che Dylan si ponesse come il continuatore della linea più pura del movimento folk statunitense, contrapposta alle deviazioni commerciali di gruppi come i Brothers Four, e perfino di Harry Belafonte. Ribadisce (tirando acqua al suo mulino) il critico rock: sì, ma innestandosi poi in un recupero parallelo dell’autenticità del rock and roll originale, contro il perbenismo dei cantanti pseudorock dei primissimi anni sessanta come Neil Sedaka, e degli autori di canzoni in serie del Brill Building (Leiber-Stoller, Goffin-King eccetera). Il pubblico ondeggia, perplesso dallo specialismo. Ma poi tutti annuiscono, quando i tre relatori quasi in coro concordano sulla parola magica: "autenticità".
È chiaro come il sole: qualunque sia la fonte, Dylan convince per la sua naturalezza, per la spontaneità vulcanica dei suoi versi (è evidente che la musica è solo uno sfondo, un accompagnamento) che sgorgano come l’Apocalisse dalle labbra del Teologo.
Ha macinato Jukebox all’idrogeno e Bound for Glory, Elvis Presley e William Blake (ah, Blake!), e da lì è sgorgata Like a Rolling Stone, la più grande canzone rock della storia (applausi). Poi arriva al microfono uno, con degli occhialetti sul naso. Dice che se Dylan non avesse sentito la ballata Jenny dei pirati di Bertolt Brecht e Kurt Weill probabilmente non gli sarebbe mai venuto in mente di scrivere canzoni come It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding) , Mr. Tambourine Man, A Hard Rain’s A-Gonna Fall; che se quella ballata non l’avesse esaminata pezzo per pezzo, cercando di capire che cos’era che la faceva funzionare, forse nemmeno gli sarebbe venuto in mente che canzoni come quelle potevano essere scritte. Si sentono degli "Ah!" di dispetto fra il pubblico, gli esperti si innervosiscono.
Il tizio con gli occhialetti insiste: sostiene che Dylan avrebbe preso quella canzone, l’avrebbe aperta e smontata, scoprendo che era la forma, erano le associazioni indotte dal verso libero, la struttura e la noncuranza per le risapute certezze melodiche a renderla quella faccenda seria che era, affilata come una lama. Woody Guthrie non aveva mai scritto una cosa simile. Indignazione degli esperti. Si guardano stralunati. Perfino l’etnomusicologo e il critico rock solidarizzano, fanno cenni suggerendosi che quello lì dev’essere matto, o il solito noioso paleomarxista di passaggio: Dylan e Brecht (e Weill), ma scherziamo! Il signor Zimmerman che "smonta" una canzone da L’opera da tre soldi, che parla di forma, di struttura. Cosa ci tocca sentire! Per fortuna il resto dell’intervento del tizio con gli occhialetti è coperto dalle urla del pubblico e dalle interruzioni degli esperti: dalla registrazione destinata alla pubblicazione degli atti (dai quali l’intervento sarà ovviamente escluso) si apprenderebbe perfino che secondo Dylan i poeti della beat generation erano "superati", che i Brothers Four non erano poi tanto male, e che quelli del Brill Building erano i maestri dell’arte della canzone occidentale, con la melodia ben congegnata e i versi semplici, e che uno dei suoi preferiti era Neil Sedaka, perché si scriveva i suoi brani e li eseguiva. Siamo al delirio. Il critico rock, mentre il tizio con gli occhialetti torna al suo posto, sbertucciato dai più facinorosi, ricorda che Neil Sedaka era quello che cantò anche in italiano, cose come Il re dei pagliacci ed Esagerata.
Per il titolo e il contesto di questo articolo, cari lettori, mi è impossibile proseguire senza rivelare quello che avete già capito tutti: che il tizio con gli occhialetti dell’ipotetico dibattito altri non è se non lo stesso Bob Dylan, e che le sue affermazioni folli e scandalose sono citazioni - in alcuni casi letterali - dell’autobiografia (Chronicles - Volume 1), con la traduzione di Alessandro Carrera (buona - e quanto difficile! - la traduzione e l’utile apparato di note; sarebbe stato gradito un indice dei nomi e uno delle canzoni). Come sempre lo scandalo è nella mente di chi si scandalizza, quindi il primo possibile equivoco da allontanare è che Dylan abbia inteso deliberatamente distruggere il proprio mito, contraddicendo punto per punto ciò che si sapeva di lui dalle fonti disponibili in precedenza. Tranquilli (anche gli esperti!): Woody Guthrie occupa il posto importantissimo che gli spetta, e anche il blues, e il rock and roll "autentico" dell’etichetta Sun. E i poeti come Kerouac, Ferlinghetti, Corso vengono riconosciuti come una delle presenze più vive, anche se in una realtà affollata dai segni vistosi di un cambiamento che consegnerà quella presenza al passato.
Le prime cento pagine del libro sono una vera delizia per chi abbia conosciuto (anche indirettamente) e amato New York e l’America a cavallo fra i due decenni, cinquanta e sessanta, e i protagonisti ci sono tutti. Ma nel raccontare quella stagione a più di quarant’anni di distanza Dylan evita - anche per necessità - l’uniformità di dettagli cui hanno teso i suoi biografi: queste sono "cronache" lacunose, dove però improvvisamente ci si tuffa in profondità, allargando il campo su scene nascoste, con grandissima vivezza di particolari. Facciamo un esempio. Nella "classica" biografia di Anthony Scaduto (2003: la prima edizione americana è del 1971) si accenna di passaggio alle frequentazioni di Suze Rotolo, la fidanzata di Dylan nel periodo newyorkese delle prime canzoni e delle prime incisioni. Si dice in due righe che "Suze era molto amica di un gruppo di artisti del Village che avevano in programma dei lavori di Bertolt Brecht".
La notizia serve, con altre, a farci capire la personalità di Suze, la sua autonomia intellettuale rispetto a Bob, il quale invece "aveva bisogno di una donna che accettasse di non essere altro che il suo riflesso". Nei Chronicles Dylan dedica almeno una dozzina di pagine a Suze Rotolo. Per inciso, è l’unica delle sue donne ad ottenere il beneficio di un nome (nel libro in due capitoli distinti Dylan parla affettuosamente di "mia moglie": si dimentica di dirci che si tratta di due mogli diverse). Buona parte di quelle pagine sono spese per riconoscere gratitudine nei confronti di Suze, istigatrice di alcuni incontri fondamentali: con la pittura di Red Grooms, con la poesia di Rimbaud e soprattutto con lo spettacolo di canzoni brechtiane allestito al Theatre de Lys. Su Jenny dei pirati Dylan si sofferma per pagine intere: chi avrebbe mai sospettato che quella canzone fosse stata così importante per lui, leggendo quelle due righe nella "mitica biografia" di Scaduto? Il fatto che ci troviamo di fronte a un Volume 1 rende immediatamente chiaro che non si tratta di un’autobiografia completa. E nemmeno di un ‟chronicle” in senso proprio, che dovrebbe essere un resoconto di fatti "nell’ordine in cui si sono svolti" (Oxford Dictionary). Il primo e il secondo capitolo si riferiscono al 1961; il terzo ci porta al 1970-71 e alla registrazione (avvenuta a Nashville) dell’album New Morning; il quarto salta in avanti di sedici anni, e poi si dilunga (in modo molto piacevole e interessante) sulla realizzazione di Oh Mercy! , nel marzo del 1989 a New Orleans, insieme a Daniel Lanois; il quinto e ultimo ci riporta agli esordi, prima a Minneapolis nel 1959, e poi a New York, alla vigilia del successo. Quindi dovremo aspettare i prossimi volumi per conoscere la "verità" di Dylan su alcuni dei momenti più importanti della sua vita e della sua carriera: il primo successo, l’incontro con i Beatles, la "svolta" elettrica e la contestazione dei tradizionalisti a Newport, il misterioso incidente in motocicletta del 1966, l’omaggio alla musica country in Nashville Skyline, e più avanti la conversione al cristianesimo, e così via.
Di fatto, in questo primo volume si parla molto poco delle canzoni più note di Dylan, per lo più citate di passaggio proprio come esempi di canzoni riuscite e famose, e ci si sofferma abbastanza a lungo su brani che è difficile non definire "minori", come quelli dei due album della cui registrazione l’autore ci offre un resoconto. Eppure, in definitiva, l’aspetto più importante di questo libro, quello che aggiunge dei tasselli nuovi e fondamentali alla nostra conoscenza di Dylan e della sua opera, è proprio la sua riflessione sulle canzoni, sul fare musica. Non la pur vivida carrellata di personaggi, di caratteri, di voci, di gesti, che ci consegna ritratti difficilmente eguagliabili di Joan Baez, di John Hammond (il produttore discografico), di Albert Grossman (il manager), perfino di John Wayne: no, è il livello di analisi dei processi della scrittura, della composizione, dell’interpretazione delle canzoni che fa di Chronicles un libro importante e rivelatore. Dylan scrive, a un certo punto: "( ) se le mie canzoni si riducevano alle parole allora perché Duane Eddy, il grande chitarrista di rock and roll, ne aveva registrato un album di versioni puramente strumentali? I musicisti l’avevano sempre saputo che nelle mie canzoni c’era qualcosa di più che non le sole parole, ma la maggior parte della gente non fa il musicista". Ecco, a quella maggior parte della gente che non fa il musicista Dylan spiega - non didascalicamente, a volte in modo abbastanza criptico - i segreti del suo mestiere. Racconta di come trascrivesse i testi dei blues di Robert Johnson per capire la loro energia misteriosa. Analizza sulla carta lo choc provato nell’ascoltare la musica e le parole di Jenny dei pirati. E la dizione di Woody Guthrie, e quel suo modo di buttare dentro "il suono dell’ultima lettera di una parola ogni volta che ne aveva voglia e l’effetto era quello di un pugno". E la sua scoperta decisiva, negli anni ottanta, di un modo di accompagnarsi alla chitarra su una scansione dispari, seguendo le note della scala, creando una divisione ritmica contraddittoria rispetto alla regolarità del battere e del levare, capace di ridare vita anche alle interpretazioni più stanche. Altro che spontaneità, altro che naturalezza, altro che ruolo accessorio della musica! Gli esperti se ne accorgeranno?
È chiaro come il sole: qualunque sia la fonte, Dylan convince per la sua naturalezza, per la spontaneità vulcanica dei suoi versi (è evidente che la musica è solo uno sfondo, un accompagnamento) che sgorgano come l’Apocalisse dalle labbra del Teologo.
Ha macinato Jukebox all’idrogeno e Bound for Glory, Elvis Presley e William Blake (ah, Blake!), e da lì è sgorgata Like a Rolling Stone, la più grande canzone rock della storia (applausi). Poi arriva al microfono uno, con degli occhialetti sul naso. Dice che se Dylan non avesse sentito la ballata Jenny dei pirati di Bertolt Brecht e Kurt Weill probabilmente non gli sarebbe mai venuto in mente di scrivere canzoni come It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding) , Mr. Tambourine Man, A Hard Rain’s A-Gonna Fall; che se quella ballata non l’avesse esaminata pezzo per pezzo, cercando di capire che cos’era che la faceva funzionare, forse nemmeno gli sarebbe venuto in mente che canzoni come quelle potevano essere scritte. Si sentono degli "Ah!" di dispetto fra il pubblico, gli esperti si innervosiscono.
Il tizio con gli occhialetti insiste: sostiene che Dylan avrebbe preso quella canzone, l’avrebbe aperta e smontata, scoprendo che era la forma, erano le associazioni indotte dal verso libero, la struttura e la noncuranza per le risapute certezze melodiche a renderla quella faccenda seria che era, affilata come una lama. Woody Guthrie non aveva mai scritto una cosa simile. Indignazione degli esperti. Si guardano stralunati. Perfino l’etnomusicologo e il critico rock solidarizzano, fanno cenni suggerendosi che quello lì dev’essere matto, o il solito noioso paleomarxista di passaggio: Dylan e Brecht (e Weill), ma scherziamo! Il signor Zimmerman che "smonta" una canzone da L’opera da tre soldi, che parla di forma, di struttura. Cosa ci tocca sentire! Per fortuna il resto dell’intervento del tizio con gli occhialetti è coperto dalle urla del pubblico e dalle interruzioni degli esperti: dalla registrazione destinata alla pubblicazione degli atti (dai quali l’intervento sarà ovviamente escluso) si apprenderebbe perfino che secondo Dylan i poeti della beat generation erano "superati", che i Brothers Four non erano poi tanto male, e che quelli del Brill Building erano i maestri dell’arte della canzone occidentale, con la melodia ben congegnata e i versi semplici, e che uno dei suoi preferiti era Neil Sedaka, perché si scriveva i suoi brani e li eseguiva. Siamo al delirio. Il critico rock, mentre il tizio con gli occhialetti torna al suo posto, sbertucciato dai più facinorosi, ricorda che Neil Sedaka era quello che cantò anche in italiano, cose come Il re dei pagliacci ed Esagerata.
Per il titolo e il contesto di questo articolo, cari lettori, mi è impossibile proseguire senza rivelare quello che avete già capito tutti: che il tizio con gli occhialetti dell’ipotetico dibattito altri non è se non lo stesso Bob Dylan, e che le sue affermazioni folli e scandalose sono citazioni - in alcuni casi letterali - dell’autobiografia (Chronicles - Volume 1), con la traduzione di Alessandro Carrera (buona - e quanto difficile! - la traduzione e l’utile apparato di note; sarebbe stato gradito un indice dei nomi e uno delle canzoni). Come sempre lo scandalo è nella mente di chi si scandalizza, quindi il primo possibile equivoco da allontanare è che Dylan abbia inteso deliberatamente distruggere il proprio mito, contraddicendo punto per punto ciò che si sapeva di lui dalle fonti disponibili in precedenza. Tranquilli (anche gli esperti!): Woody Guthrie occupa il posto importantissimo che gli spetta, e anche il blues, e il rock and roll "autentico" dell’etichetta Sun. E i poeti come Kerouac, Ferlinghetti, Corso vengono riconosciuti come una delle presenze più vive, anche se in una realtà affollata dai segni vistosi di un cambiamento che consegnerà quella presenza al passato.
Le prime cento pagine del libro sono una vera delizia per chi abbia conosciuto (anche indirettamente) e amato New York e l’America a cavallo fra i due decenni, cinquanta e sessanta, e i protagonisti ci sono tutti. Ma nel raccontare quella stagione a più di quarant’anni di distanza Dylan evita - anche per necessità - l’uniformità di dettagli cui hanno teso i suoi biografi: queste sono "cronache" lacunose, dove però improvvisamente ci si tuffa in profondità, allargando il campo su scene nascoste, con grandissima vivezza di particolari. Facciamo un esempio. Nella "classica" biografia di Anthony Scaduto (2003: la prima edizione americana è del 1971) si accenna di passaggio alle frequentazioni di Suze Rotolo, la fidanzata di Dylan nel periodo newyorkese delle prime canzoni e delle prime incisioni. Si dice in due righe che "Suze era molto amica di un gruppo di artisti del Village che avevano in programma dei lavori di Bertolt Brecht".
La notizia serve, con altre, a farci capire la personalità di Suze, la sua autonomia intellettuale rispetto a Bob, il quale invece "aveva bisogno di una donna che accettasse di non essere altro che il suo riflesso". Nei Chronicles Dylan dedica almeno una dozzina di pagine a Suze Rotolo. Per inciso, è l’unica delle sue donne ad ottenere il beneficio di un nome (nel libro in due capitoli distinti Dylan parla affettuosamente di "mia moglie": si dimentica di dirci che si tratta di due mogli diverse). Buona parte di quelle pagine sono spese per riconoscere gratitudine nei confronti di Suze, istigatrice di alcuni incontri fondamentali: con la pittura di Red Grooms, con la poesia di Rimbaud e soprattutto con lo spettacolo di canzoni brechtiane allestito al Theatre de Lys. Su Jenny dei pirati Dylan si sofferma per pagine intere: chi avrebbe mai sospettato che quella canzone fosse stata così importante per lui, leggendo quelle due righe nella "mitica biografia" di Scaduto? Il fatto che ci troviamo di fronte a un Volume 1 rende immediatamente chiaro che non si tratta di un’autobiografia completa. E nemmeno di un ‟chronicle” in senso proprio, che dovrebbe essere un resoconto di fatti "nell’ordine in cui si sono svolti" (Oxford Dictionary). Il primo e il secondo capitolo si riferiscono al 1961; il terzo ci porta al 1970-71 e alla registrazione (avvenuta a Nashville) dell’album New Morning; il quarto salta in avanti di sedici anni, e poi si dilunga (in modo molto piacevole e interessante) sulla realizzazione di Oh Mercy! , nel marzo del 1989 a New Orleans, insieme a Daniel Lanois; il quinto e ultimo ci riporta agli esordi, prima a Minneapolis nel 1959, e poi a New York, alla vigilia del successo. Quindi dovremo aspettare i prossimi volumi per conoscere la "verità" di Dylan su alcuni dei momenti più importanti della sua vita e della sua carriera: il primo successo, l’incontro con i Beatles, la "svolta" elettrica e la contestazione dei tradizionalisti a Newport, il misterioso incidente in motocicletta del 1966, l’omaggio alla musica country in Nashville Skyline, e più avanti la conversione al cristianesimo, e così via.
Di fatto, in questo primo volume si parla molto poco delle canzoni più note di Dylan, per lo più citate di passaggio proprio come esempi di canzoni riuscite e famose, e ci si sofferma abbastanza a lungo su brani che è difficile non definire "minori", come quelli dei due album della cui registrazione l’autore ci offre un resoconto. Eppure, in definitiva, l’aspetto più importante di questo libro, quello che aggiunge dei tasselli nuovi e fondamentali alla nostra conoscenza di Dylan e della sua opera, è proprio la sua riflessione sulle canzoni, sul fare musica. Non la pur vivida carrellata di personaggi, di caratteri, di voci, di gesti, che ci consegna ritratti difficilmente eguagliabili di Joan Baez, di John Hammond (il produttore discografico), di Albert Grossman (il manager), perfino di John Wayne: no, è il livello di analisi dei processi della scrittura, della composizione, dell’interpretazione delle canzoni che fa di Chronicles un libro importante e rivelatore. Dylan scrive, a un certo punto: "( ) se le mie canzoni si riducevano alle parole allora perché Duane Eddy, il grande chitarrista di rock and roll, ne aveva registrato un album di versioni puramente strumentali? I musicisti l’avevano sempre saputo che nelle mie canzoni c’era qualcosa di più che non le sole parole, ma la maggior parte della gente non fa il musicista". Ecco, a quella maggior parte della gente che non fa il musicista Dylan spiega - non didascalicamente, a volte in modo abbastanza criptico - i segreti del suo mestiere. Racconta di come trascrivesse i testi dei blues di Robert Johnson per capire la loro energia misteriosa. Analizza sulla carta lo choc provato nell’ascoltare la musica e le parole di Jenny dei pirati. E la dizione di Woody Guthrie, e quel suo modo di buttare dentro "il suono dell’ultima lettera di una parola ogni volta che ne aveva voglia e l’effetto era quello di un pugno". E la sua scoperta decisiva, negli anni ottanta, di un modo di accompagnarsi alla chitarra su una scansione dispari, seguendo le note della scala, creando una divisione ritmica contraddittoria rispetto alla regolarità del battere e del levare, capace di ridare vita anche alle interpretazioni più stanche. Altro che spontaneità, altro che naturalezza, altro che ruolo accessorio della musica! Gli esperti se ne accorgeranno?
Chronicles. Vol. I di Bob Dylan
Siamo nel 1961, all'epoca in cui Dylan giunge a Manhattan, ed è attraverso i suoi occhi e la sua mente aperta che possiamo gettare uno sguardo sul Greenwich Village. La New York di Dylan è la magica città delle possibilità: feste piene di fumo e che durano la notte intera, straordinarie scoperte le…