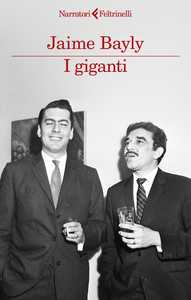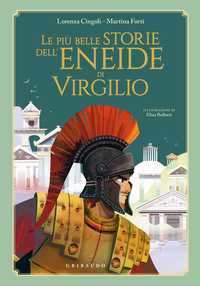Paolo Rumiz: Il Gesù di Damasco
23 Agosto 2005
Il cruscotto psichedelico di Ahmed buca la notte verso Damasco, incrocia camion sauditi illuminati come alberi di natale, affianca un serpente di luci con le prime targhe irachene, si riempie di musica carovaniera, supera un grande cartello azzurro con la scritta Baghdad, mi spinge in un dormiveglia popolato di raffinerie illuminate (il Kuwait?), donne misteriose (Aleppo?) e canneti nel vento (Nassiriya?) verso il Golfo Persico. E´ un vero califfo Ahmed il tassista. Pacioso e debordante, con in bocca sempre la stessa, fondamentale parola-chiave: «No problem». Sul sedile posteriore uno scatolone di biscotti, il narghilé, una scorta di bottiglie d´acqua, una coperta per dormire.
Alla fine dell´autostrada, la Capitale brilla sul fianco di una montagna come una granita al limone, una cesta di diamanti nell´antro di Alì Babà, una nebulosa di mille e una luce bianca completamente priva di tracce rettilinee. L´aria è purissima, il deserto è vicino. Sei milioni di abitanti, ma non è una megalopoli di alieni, è una città plurale dove ti senti a casa anche da straniero, un centro che ha conservato parte della sua originale complessità. Ma tutta la Siria è fatta così, il segno antico di Cristo è ovunque, dal Monte Libano al deserto, visibile, sbandierato, diluito in una presenza islamica mai totalitaria: quella discreta e tollerante degli Aleviti, i musulmani più vicini a Gesù.
«Mi raccomando, appena entri in Siria avverti il ministero che stai viaggiando con visto da giornalista», mi hanno ripetuto a Roma prima di partire. Ebbene, sono tre giorni che telefono con insistenza a Damasco, ma non c´è funzionario che si allarmi o voglia appiopparmi un angelo custode. L´unica cosa che mi sorveglia è la faccia di Assad jr., il giovane presidente-oculista onnipresente su mille cartelloni. Viaggio in libertà, ho l´impressione che tutto in Siria sia meglio di quello che ti aspetti.
Un´anarchia polifonica totale
Il primo segnale parte nitido, poi un secondo, un terzo, un quarto rompono definitivamente il silenzio. Non è più la voce preregistrata che esce in simultanea dai minareti turchi. Quella dei muezzin siriani è un´anarchia polifonica totale. Richiami striduli, baritonali, rauchi, lenti, nasali, profondi oppure bassi come quelli di un pope. Un´onda sonora ramificata che invade il labirinto con la prima luce del sole e ti conduce verso la grande meta, la moschea degli Omeiadi. Un magnete della fede, nel cuore del bazar.
Ahmed mi guida nelle strade piene. Compaiono i primi chador, neri, inconfondibili. Incorniciano il volto di donne dagli occhi terribili, invecchiate in fretta, che vanno piagnucolando alla moschea, per pregare nel mausoleo di Hussein, il martire dei martiri, il segno insanguinato della discordia con i sunniti. «Stai attento - avverte il tassista - no muslim», quelle non sono musulmane. Come non sono musulmane? «Shia, shia, no muslim» ripete Ahmed con convinzione. Sono sciite, persiane o irachene. Quindi non musulmane. La deviazione nell´Islam spinge subito il viaggio in direzioni inattese.
Mi fermo a parlare con tre donne in nero, accovacciate nell´ombra. Capiscono che sono italiano. Una mi chiede soldi, un´altra mi dice di seguirla, si leva le scarpe all´ingresso della moschea, traversa scalza l´immenso cortile inondato di luce, si ferma nell´aria rovente col vento che le gonfia il sottanone, si gira su se stessa, guarda in alto, dirige il mio sguardo verso un minareto sul muro perimetrale esterno della moschea, e sibila: Issa, Gesù. Ahmed conferma, è Gesù. Il minareto è la torre dove Lui annuncerà la fine dei tempi e dividerà i buoni dai reprobi. Qui a Damasco lo sanno anche i bambini.
La sciita mi fa ancora cenno di seguirla nella luce calcinata del cortile, mi porta ululando piano all´ingresso principale della moschea. Ululano sempre queste donne in nero, è come se il loro chador imprigionasse e lasciasse sfiatare un dolore infinito. Accarezzano muri, baciano portali, biascicano piangendo litanie. Dentro, un brusio di fedeli, mendicanti, turisti musulmani con videotelefonini, una coabitazione di estasi e indifferenza, tecnologia imbecille e proporzioni pitagoriche. La donna traversa i tappeti verso il centro della moschea, si ferma davanti a un grande sarcofago appena visibile in una gabbia di vetri verdi.
«Giovanni Battista», sussurra. È la tomba di Giovanni Battista, traduce Ahmed sempre più sicuro di sé. È il mausoleo dell´uomo del Giordano, circondato di pellegrini pachistani in lacrime, sauditi genuflessi, donne venute da chissadove che infilano banconote propiziatrici in ogni fessura della tomba, bambini che giocano sui tappeti. Un catafalco verde, come quello di Mevlana a Konja. E anche qui, come nella casa dei dervisci, un´onda devozionale diretta, che by-passa l´egemonia degli imam, richiama imperiosamente il cristianesimo dal cuore più profondo dell´Islam. «Lasciati portare dall´onda del sacro», mi avevano avvertito prima di partire i monaci di Bose in Piemonte. Ma stavolta non immagino neppure lontanamente che la sorpresa è solo all´inizio.
«Noi di Damasco siamo diventati cristiani prima di San Paolo».
Un antiquario tenta di accalappiarmi chiedendomi da dove vengo. Sì chiama Josef, parla anche l´italiano ed è siro-cattolico. «Noi di Damasco - si vanta - siamo diventati cristiani prima di San Paolo». Mi invita nella bottega; dalla terrazza al terzo piano, spiega, potrò vedere tutta la città. Saliamo una scala a chiocciola, sbuchiamo in un negozio ingombro di oggetti. «Ecco - dice - da questa parte hai i tessuti dei musulmani. Qui i legni intarsiati dei cristiani. E qui gli ottoni fatti dagli ebrei». In tre pareti, le tre religioni del Libro sotto forma di suppellettili.
Ebrei? Ce ne sono ancora? «Ce ne saranno sì e no una ventina. Vivono qui da tremila anni, il grosso se n´è andato dieci anni fa, con gli accordi di Madrid, dopo la prima guerra del Golfo». Sento che il viaggio mi porta indietro nel tempo con una logica di ferro. Ogni monoteismo rimanda al suo predecessore. La donna sciita mi ha spedito da Cristo, ora il cristiano mi spedisce dagli ebrei. Dalla terrazza l´antiquario indica la sinagoga, lontano, in un labirinto simile ai Bassi napoletani.
Chiedo ad Ahmed se se la sente. «No problem» risponde senza scomporsi. Damasco e Gerusalemme sono ancora in guerra, le linee telefoniche tagliate, ma noi partiamo in cerca di ebrei nel cuore del bazar. Idea talmente folle da essere fattibile. Where is haus yahuddin? «Ici très peu de juifs»; «Juifs allés, allés». Pochi ebrei, ebrei partiti. Ma tutti collaborano a orientarci senza imbarazzo. Il quartiere non ha perso la memoria. Un ciabattino mi disegna una mappa, il falegname ci manda nella bottega di un robivecchi. Ormai navighiamo a vista, Ahmed è stupefatto. Ha vissuto 20 anni a Damasco ma per quelle strade non c´è mai stato.
Il macellaio mi manda dal panettiere, una stanza rovente come l´antro di Efesto, col forno che inghiotte pagnotte e le cuoce in un attimo gonfiandole come palloni. Distribuisco sigari, i lavoranti ci regalano pane caldo. La gente dei vicoli lo compra appena fatto dalla finestra della bottega. Chiedo: «La sinagoga? Dov´è la sinagoga?». Un cliente indica una casa sprangata con catene, ripete Yahuddin, m´accorgo che il rione è pieno di case chiuse, il segno di un epico trasloco. Riparto per stradine coperte di vite americana.
Un nome, via El Katateeb, un patio con alberi di fico, mosaici e immondizie, miseria e nobiltà. Poi le mura della scuola ebraica fondata appena 15 anni fa e subito abbandonata. Una custode ci caccia via. La scuola è diventata di Stato, il suk della storia ha inghiottito anche questo. Ma ne vado, ma con la strana sensazione di essere a casa, protetto da un´unica confraternita mercantile, come se il bazar fosse abitato da ebrei travestiti da musulmani, un popolo di Zelig dove la parola «levantino» diventa di colpo trasparente.
Alla fine dell´autostrada, la Capitale brilla sul fianco di una montagna come una granita al limone, una cesta di diamanti nell´antro di Alì Babà, una nebulosa di mille e una luce bianca completamente priva di tracce rettilinee. L´aria è purissima, il deserto è vicino. Sei milioni di abitanti, ma non è una megalopoli di alieni, è una città plurale dove ti senti a casa anche da straniero, un centro che ha conservato parte della sua originale complessità. Ma tutta la Siria è fatta così, il segno antico di Cristo è ovunque, dal Monte Libano al deserto, visibile, sbandierato, diluito in una presenza islamica mai totalitaria: quella discreta e tollerante degli Aleviti, i musulmani più vicini a Gesù.
«Mi raccomando, appena entri in Siria avverti il ministero che stai viaggiando con visto da giornalista», mi hanno ripetuto a Roma prima di partire. Ebbene, sono tre giorni che telefono con insistenza a Damasco, ma non c´è funzionario che si allarmi o voglia appiopparmi un angelo custode. L´unica cosa che mi sorveglia è la faccia di Assad jr., il giovane presidente-oculista onnipresente su mille cartelloni. Viaggio in libertà, ho l´impressione che tutto in Siria sia meglio di quello che ti aspetti.
Un´anarchia polifonica totale
Il primo segnale parte nitido, poi un secondo, un terzo, un quarto rompono definitivamente il silenzio. Non è più la voce preregistrata che esce in simultanea dai minareti turchi. Quella dei muezzin siriani è un´anarchia polifonica totale. Richiami striduli, baritonali, rauchi, lenti, nasali, profondi oppure bassi come quelli di un pope. Un´onda sonora ramificata che invade il labirinto con la prima luce del sole e ti conduce verso la grande meta, la moschea degli Omeiadi. Un magnete della fede, nel cuore del bazar.
Ahmed mi guida nelle strade piene. Compaiono i primi chador, neri, inconfondibili. Incorniciano il volto di donne dagli occhi terribili, invecchiate in fretta, che vanno piagnucolando alla moschea, per pregare nel mausoleo di Hussein, il martire dei martiri, il segno insanguinato della discordia con i sunniti. «Stai attento - avverte il tassista - no muslim», quelle non sono musulmane. Come non sono musulmane? «Shia, shia, no muslim» ripete Ahmed con convinzione. Sono sciite, persiane o irachene. Quindi non musulmane. La deviazione nell´Islam spinge subito il viaggio in direzioni inattese.
Mi fermo a parlare con tre donne in nero, accovacciate nell´ombra. Capiscono che sono italiano. Una mi chiede soldi, un´altra mi dice di seguirla, si leva le scarpe all´ingresso della moschea, traversa scalza l´immenso cortile inondato di luce, si ferma nell´aria rovente col vento che le gonfia il sottanone, si gira su se stessa, guarda in alto, dirige il mio sguardo verso un minareto sul muro perimetrale esterno della moschea, e sibila: Issa, Gesù. Ahmed conferma, è Gesù. Il minareto è la torre dove Lui annuncerà la fine dei tempi e dividerà i buoni dai reprobi. Qui a Damasco lo sanno anche i bambini.
La sciita mi fa ancora cenno di seguirla nella luce calcinata del cortile, mi porta ululando piano all´ingresso principale della moschea. Ululano sempre queste donne in nero, è come se il loro chador imprigionasse e lasciasse sfiatare un dolore infinito. Accarezzano muri, baciano portali, biascicano piangendo litanie. Dentro, un brusio di fedeli, mendicanti, turisti musulmani con videotelefonini, una coabitazione di estasi e indifferenza, tecnologia imbecille e proporzioni pitagoriche. La donna traversa i tappeti verso il centro della moschea, si ferma davanti a un grande sarcofago appena visibile in una gabbia di vetri verdi.
«Giovanni Battista», sussurra. È la tomba di Giovanni Battista, traduce Ahmed sempre più sicuro di sé. È il mausoleo dell´uomo del Giordano, circondato di pellegrini pachistani in lacrime, sauditi genuflessi, donne venute da chissadove che infilano banconote propiziatrici in ogni fessura della tomba, bambini che giocano sui tappeti. Un catafalco verde, come quello di Mevlana a Konja. E anche qui, come nella casa dei dervisci, un´onda devozionale diretta, che by-passa l´egemonia degli imam, richiama imperiosamente il cristianesimo dal cuore più profondo dell´Islam. «Lasciati portare dall´onda del sacro», mi avevano avvertito prima di partire i monaci di Bose in Piemonte. Ma stavolta non immagino neppure lontanamente che la sorpresa è solo all´inizio.
«Noi di Damasco siamo diventati cristiani prima di San Paolo».
Un antiquario tenta di accalappiarmi chiedendomi da dove vengo. Sì chiama Josef, parla anche l´italiano ed è siro-cattolico. «Noi di Damasco - si vanta - siamo diventati cristiani prima di San Paolo». Mi invita nella bottega; dalla terrazza al terzo piano, spiega, potrò vedere tutta la città. Saliamo una scala a chiocciola, sbuchiamo in un negozio ingombro di oggetti. «Ecco - dice - da questa parte hai i tessuti dei musulmani. Qui i legni intarsiati dei cristiani. E qui gli ottoni fatti dagli ebrei». In tre pareti, le tre religioni del Libro sotto forma di suppellettili.
Ebrei? Ce ne sono ancora? «Ce ne saranno sì e no una ventina. Vivono qui da tremila anni, il grosso se n´è andato dieci anni fa, con gli accordi di Madrid, dopo la prima guerra del Golfo». Sento che il viaggio mi porta indietro nel tempo con una logica di ferro. Ogni monoteismo rimanda al suo predecessore. La donna sciita mi ha spedito da Cristo, ora il cristiano mi spedisce dagli ebrei. Dalla terrazza l´antiquario indica la sinagoga, lontano, in un labirinto simile ai Bassi napoletani.
Chiedo ad Ahmed se se la sente. «No problem» risponde senza scomporsi. Damasco e Gerusalemme sono ancora in guerra, le linee telefoniche tagliate, ma noi partiamo in cerca di ebrei nel cuore del bazar. Idea talmente folle da essere fattibile. Where is haus yahuddin? «Ici très peu de juifs»; «Juifs allés, allés». Pochi ebrei, ebrei partiti. Ma tutti collaborano a orientarci senza imbarazzo. Il quartiere non ha perso la memoria. Un ciabattino mi disegna una mappa, il falegname ci manda nella bottega di un robivecchi. Ormai navighiamo a vista, Ahmed è stupefatto. Ha vissuto 20 anni a Damasco ma per quelle strade non c´è mai stato.
Il macellaio mi manda dal panettiere, una stanza rovente come l´antro di Efesto, col forno che inghiotte pagnotte e le cuoce in un attimo gonfiandole come palloni. Distribuisco sigari, i lavoranti ci regalano pane caldo. La gente dei vicoli lo compra appena fatto dalla finestra della bottega. Chiedo: «La sinagoga? Dov´è la sinagoga?». Un cliente indica una casa sprangata con catene, ripete Yahuddin, m´accorgo che il rione è pieno di case chiuse, il segno di un epico trasloco. Riparto per stradine coperte di vite americana.
Un nome, via El Katateeb, un patio con alberi di fico, mosaici e immondizie, miseria e nobiltà. Poi le mura della scuola ebraica fondata appena 15 anni fa e subito abbandonata. Una custode ci caccia via. La scuola è diventata di Stato, il suk della storia ha inghiottito anche questo. Ma ne vado, ma con la strana sensazione di essere a casa, protetto da un´unica confraternita mercantile, come se il bazar fosse abitato da ebrei travestiti da musulmani, un popolo di Zelig dove la parola «levantino» diventa di colpo trasparente.
Paolo Rumiz
Paolo Rumiz, triestino, è scrittore e viaggiatore. Con Feltrinelli ha pubblicato La secessione leggera (2001), Tre uomini in bicicletta (con Francesco Altan; 2002), È Oriente (2003), La leggenda dei monti …