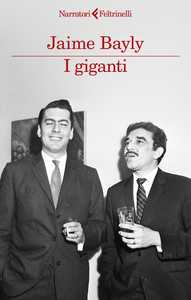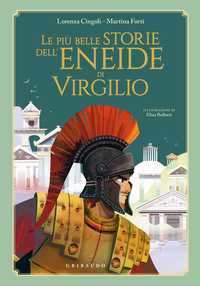Giorgio Bocca: Quando Torino viveva nel mito con la squadra dei sogni granata
26 Settembre 2005
‟Era una notte buia e tempestosa” l’incipit sembra scritto per quel settembre in cui l’aereo del Torino si schiantò sul muraglione della basilica di Superga. Da Torino quella notte non si vedevano le luci della funicolare, una nuvolaglia nera copriva la collina e la sferzava con una pioggia battente. Nessun superstite.
Quando la notizia scese per radio sulla città per molti fu la fine di un mondo, di un miracolo che aveva cambiato la città, di una allegria che si rinnovava ogni giorno al pensiero che quella grande squadra era fra le migliori del mondo, come il Santos di Pelè e il wunder team di Vienna. Guardavamo quel buio e non potevamo credere che fosse cosparso dai resti di quell’aereo finito, non si poteva capire come, sul sepolcreto dei Savoia con tutto quello spazio vuoto che c’era fra Torino e le montagne di Ivrea. Poi la città si fermò per i funerali dei suo campioni, il corteo era lungo -dalla Gran Madre a piazza Castello -, al fianco del feretro di Bacigalupo, il giovane portiere arrivato da Genova camminavano tenendosi per mano le sue due fidanzatine, due sedicenni di buona famiglia che solo con quel lutto avevano saputo l’una dell’altra. Chi non c’è stato non può capire quel lutto, quel silenzio, quel rintocco di campane a morto lungo la valle del Po da Moncalieri ai Cappuccini, lungo i Murazzi di piazza Vittorio, sotto i giardini di villa della Regina, dove stanno gli imbarcaderi della Cerea, dove suonava l’orchestra del maestro Angelini nei mesi gelidi e roventi in cui si usciva dalla guerra e dalla paura e i ragazzi del Torino, che se ne andavano nel corteo senza fine delle bare, fra due ali di folla, facevano parte di quel che c’era in quella città di eccitante, di corroborante: un paese a pezzi, sconfitto, occupato dagli inglesi e dagli americani, dai loro carri armati parcheggiati sui viali, grossi come una casa, presto dimenticati, come se non ci fossero nella nostra certezza di venir fuori dalle rovine, di uscire indenni dalla sconfitta. E in questa vitalità indomita quella squadra di calcio ci stava, e non si voleva credere che se ne andasse.
Nel settembre del '45 quel Torino si era rifugiato a Santa Vittoria, fra Alba e Bra, dal Filadelfia al campetto del Cinzano. Ospitato dal conte Marone, amico del presidente Novo. C’era anche l’ebreo ungherese Erbatein, il mister, l’allenatore che stava compiendo il miracolo di mettere assieme un calcio danubiano, lento e armonioso, con l’efficienza inglese, di trasformare in atleti duri e forti i figli di famiglie contadine e numerose: i Sentimenti di Modena arrivavano a quattro come i Ferraris del vercellese, come la stirpe croata dei Varglien. E a noi partigiani quella vacanza dei calciatori dava un po’ fastidio, qualcuno pensò di arrivare un mattino al campo del Cinzano e di far correre a raffiche di mitra i Menti e i Gabetto e gli altri campioni del Toro. Per fortuna c’era altro di più urgente da fare e arrivammo al 25 aprile e poi alla ripresa del campionato con quel regalo da nessuno previsto di una squadra bella e fatta che girava come un motore indovinato. Come l’avevano fatta Novo e Erbstein? Metà perché erano due maghi del calcio - meno famosi di Vittorio Pozzo, il commissario unico due volte campione del mondo, ma più intelligenti di lui, meno ufficiali degli alpini - metà perché erano uomini di coraggio, di fiuto e fortunati. E così erano andanti a pescare Mazzola e Loich nel Venezia, Ossola dalle parti di piazza Statuto, Menti a Padova, Rigamonti a Brescia e dopo aver riciclato lo juventino Gabetto e chiamato Ballerin e Maroso e il ragazzo Bacigalupo avevano messo assieme una squadra di affinità elettive che inventava il calcio appena gli davi un pallone e partiva trascinata dall’estro. Ci sono dei giocatori di calcio che hanno degli occhi anche nella nuca, che vedono anche con la schiena, che sanno quel che gli succede attorno, per cui il calcio diventa il gioco più facile, più semplice del mondo, una cosa che fila via da sola. E questo cominciava al Filadelfia da quando sbucavano al sottopassaggio e chiamati per nome si voltavano e scherzavano e Gabetto faceva una spaccata per divertirci.
Forse perché il Filadelfia era piccolo e i giocatori ti sembrava di tirarli per la maglia ma non ho mai più visto una famiglia sportiva così, una intesa così fra giocatori e pubblico, fra giocatori e città. Al Filadelfia non c’erano dei tifosi anonimi c’erano dei tipi, ciascuno con il suo nome e il suo mestiere, pazzi e lieti per il Torino. C’era Biagio il parrucchiere di via Garibaldi che ogni mattino faceva la barba a Ossola e Gabetto come se celebrasse una messa. C’era il marchese Carlino di Moncrivello, discendente degli Aleramo del Vasto, un marcantonio biondo dagli occhi azzurri che il mattino dormiva, il pomeriggio passava delle ore alla confetteria Peyrano a bere il cappuccino e a parlare del Torino e di notte andava al tabarin seguito di malavoglia dalla moglie, una Rivetti di Biella cui faceva pagar caro il titolo di marchesa: champagne per tutti e poi il bicchiere alzato in gesto di sfida verso i borsarineri con entraineuses al fianco che erano lì per rimorchiare. Una sera a pranzo da un Radicati di Primeglio e una con Maurizio, torinista marcio che rigenerava vecchi pneumatici e poi partiva con il suo camioncino verso il Sud, pronto però ad andarsene prima che scoprissero che lasciavano sull’asfalto due tracce nere come il carbone o il Pino che commerciava in diamanti, li ingoiava ad Amsterdam e li cacava a Torino e nessuno lo fermava mai alla dogana perché era piccolo, biondo con occhi da prima comunione.
Il popolo del Toro si ritrovava la domenica della partita in via Roma, nei caffè della Galleria dove c’era la redazione della "Stampa". Per anni i palazzi della vicina piazza San Carlo sono stati solo facciate, dietro c’erano le macerie dei bombardamenti, ma nella piazza c’era posto per le nostre auto. Ci conoscevamo tutti, il commissario unico Pozzo arrivava accompagnato da due giornalisti giovani della "Stampa" come da due attendenti e da uno che poi si uccise perché essere gay in quella Torino, nonostante il re Umberto, era terribilmente dura. C’è anche il Carlin direttore del "Guerin sportivo" pittore mancato, grande disegnatore che aveva in gran dispetto se stesso e tutti e il piccolo Casalbore sempre inspiegabilmente allegro come certi napoletani. Arrivata l’ora di andare alla partita partivamo tutti assieme con un concerto di clacson. Il Moncrivello in testa su una fuoriserie di Pininfarina. Arrivavano a quell’ora in centro i funzionari Fiat che venivano a trovare l’amante, nei grandi casoni della piccola borghesia con le portinaie a guardia dei cortili, capelli di canapa e odore di cavoli bolliti.
Quando la notizia scese per radio sulla città per molti fu la fine di un mondo, di un miracolo che aveva cambiato la città, di una allegria che si rinnovava ogni giorno al pensiero che quella grande squadra era fra le migliori del mondo, come il Santos di Pelè e il wunder team di Vienna. Guardavamo quel buio e non potevamo credere che fosse cosparso dai resti di quell’aereo finito, non si poteva capire come, sul sepolcreto dei Savoia con tutto quello spazio vuoto che c’era fra Torino e le montagne di Ivrea. Poi la città si fermò per i funerali dei suo campioni, il corteo era lungo -dalla Gran Madre a piazza Castello -, al fianco del feretro di Bacigalupo, il giovane portiere arrivato da Genova camminavano tenendosi per mano le sue due fidanzatine, due sedicenni di buona famiglia che solo con quel lutto avevano saputo l’una dell’altra. Chi non c’è stato non può capire quel lutto, quel silenzio, quel rintocco di campane a morto lungo la valle del Po da Moncalieri ai Cappuccini, lungo i Murazzi di piazza Vittorio, sotto i giardini di villa della Regina, dove stanno gli imbarcaderi della Cerea, dove suonava l’orchestra del maestro Angelini nei mesi gelidi e roventi in cui si usciva dalla guerra e dalla paura e i ragazzi del Torino, che se ne andavano nel corteo senza fine delle bare, fra due ali di folla, facevano parte di quel che c’era in quella città di eccitante, di corroborante: un paese a pezzi, sconfitto, occupato dagli inglesi e dagli americani, dai loro carri armati parcheggiati sui viali, grossi come una casa, presto dimenticati, come se non ci fossero nella nostra certezza di venir fuori dalle rovine, di uscire indenni dalla sconfitta. E in questa vitalità indomita quella squadra di calcio ci stava, e non si voleva credere che se ne andasse.
Nel settembre del '45 quel Torino si era rifugiato a Santa Vittoria, fra Alba e Bra, dal Filadelfia al campetto del Cinzano. Ospitato dal conte Marone, amico del presidente Novo. C’era anche l’ebreo ungherese Erbatein, il mister, l’allenatore che stava compiendo il miracolo di mettere assieme un calcio danubiano, lento e armonioso, con l’efficienza inglese, di trasformare in atleti duri e forti i figli di famiglie contadine e numerose: i Sentimenti di Modena arrivavano a quattro come i Ferraris del vercellese, come la stirpe croata dei Varglien. E a noi partigiani quella vacanza dei calciatori dava un po’ fastidio, qualcuno pensò di arrivare un mattino al campo del Cinzano e di far correre a raffiche di mitra i Menti e i Gabetto e gli altri campioni del Toro. Per fortuna c’era altro di più urgente da fare e arrivammo al 25 aprile e poi alla ripresa del campionato con quel regalo da nessuno previsto di una squadra bella e fatta che girava come un motore indovinato. Come l’avevano fatta Novo e Erbstein? Metà perché erano due maghi del calcio - meno famosi di Vittorio Pozzo, il commissario unico due volte campione del mondo, ma più intelligenti di lui, meno ufficiali degli alpini - metà perché erano uomini di coraggio, di fiuto e fortunati. E così erano andanti a pescare Mazzola e Loich nel Venezia, Ossola dalle parti di piazza Statuto, Menti a Padova, Rigamonti a Brescia e dopo aver riciclato lo juventino Gabetto e chiamato Ballerin e Maroso e il ragazzo Bacigalupo avevano messo assieme una squadra di affinità elettive che inventava il calcio appena gli davi un pallone e partiva trascinata dall’estro. Ci sono dei giocatori di calcio che hanno degli occhi anche nella nuca, che vedono anche con la schiena, che sanno quel che gli succede attorno, per cui il calcio diventa il gioco più facile, più semplice del mondo, una cosa che fila via da sola. E questo cominciava al Filadelfia da quando sbucavano al sottopassaggio e chiamati per nome si voltavano e scherzavano e Gabetto faceva una spaccata per divertirci.
Forse perché il Filadelfia era piccolo e i giocatori ti sembrava di tirarli per la maglia ma non ho mai più visto una famiglia sportiva così, una intesa così fra giocatori e pubblico, fra giocatori e città. Al Filadelfia non c’erano dei tifosi anonimi c’erano dei tipi, ciascuno con il suo nome e il suo mestiere, pazzi e lieti per il Torino. C’era Biagio il parrucchiere di via Garibaldi che ogni mattino faceva la barba a Ossola e Gabetto come se celebrasse una messa. C’era il marchese Carlino di Moncrivello, discendente degli Aleramo del Vasto, un marcantonio biondo dagli occhi azzurri che il mattino dormiva, il pomeriggio passava delle ore alla confetteria Peyrano a bere il cappuccino e a parlare del Torino e di notte andava al tabarin seguito di malavoglia dalla moglie, una Rivetti di Biella cui faceva pagar caro il titolo di marchesa: champagne per tutti e poi il bicchiere alzato in gesto di sfida verso i borsarineri con entraineuses al fianco che erano lì per rimorchiare. Una sera a pranzo da un Radicati di Primeglio e una con Maurizio, torinista marcio che rigenerava vecchi pneumatici e poi partiva con il suo camioncino verso il Sud, pronto però ad andarsene prima che scoprissero che lasciavano sull’asfalto due tracce nere come il carbone o il Pino che commerciava in diamanti, li ingoiava ad Amsterdam e li cacava a Torino e nessuno lo fermava mai alla dogana perché era piccolo, biondo con occhi da prima comunione.
Il popolo del Toro si ritrovava la domenica della partita in via Roma, nei caffè della Galleria dove c’era la redazione della "Stampa". Per anni i palazzi della vicina piazza San Carlo sono stati solo facciate, dietro c’erano le macerie dei bombardamenti, ma nella piazza c’era posto per le nostre auto. Ci conoscevamo tutti, il commissario unico Pozzo arrivava accompagnato da due giornalisti giovani della "Stampa" come da due attendenti e da uno che poi si uccise perché essere gay in quella Torino, nonostante il re Umberto, era terribilmente dura. C’è anche il Carlin direttore del "Guerin sportivo" pittore mancato, grande disegnatore che aveva in gran dispetto se stesso e tutti e il piccolo Casalbore sempre inspiegabilmente allegro come certi napoletani. Arrivata l’ora di andare alla partita partivamo tutti assieme con un concerto di clacson. Il Moncrivello in testa su una fuoriserie di Pininfarina. Arrivavano a quell’ora in centro i funzionari Fiat che venivano a trovare l’amante, nei grandi casoni della piccola borghesia con le portinaie a guardia dei cortili, capelli di canapa e odore di cavoli bolliti.
Giorgio Bocca
Giorgio Bocca (Cuneo, 1920 - Milano, 2011) è stato tra i giornalisti italiani più noti e importanti. Ha ricevuto il premio Ilaria Alpi alla carriera nel 2008. Feltrinelli ha pubblicato …