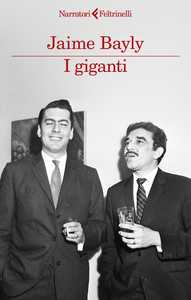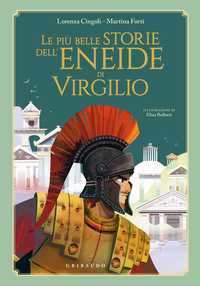Stefano Rodotà: Se il Papa ha paura della libertà
06 Dicembre 2005
Bisogna avere una gran fede nelle virtù del dialogo per non ritrarsi scorati di fronte ad una affermazione che imputa al "relativismo" la responsabilità d’essere uno dei fattori che contribuiscono alla negazione della libertà religiosa. Ora, il relativismo avrà pure mille peccati, sui quali incessantemente insiste Benedetto XVI, tra i quali l’attribuire pari rilevanza a punti di vista tra loro diversi e persino contrastanti. Ma, proprio per questo, contribuisce ad espandere il rispetto dell’altro, delle sue opinioni e credenze, e quindi la libertà di tutti e di ciascuno in ogni sfera in cui questa voglia manifestarsi.
La libertà dei credenti in una religione è combattuta, negata, limitata, dove incontra un altro punto di vista religioso, ideologico o politico che pretende l’esclusività. Dove, quindi, s’instaura un conflitto tra assoluti, ciascuno dei quali cerca di sopraffare l’altro. E’ il caso dei regimi totalitari, delle teocrazie variamente organizzate, dei paesi dove impera una religione di Stato. Non è quel che accade nelle democrazie che, appunto, si fondano sul pluralismo. In questo senso, proprio quel "predominio culturale del relativismo", che inquieta il Pontefice, è il miglior vaccino contro le tentazioni di chi vuol comprimere la libertà religiosa.
Fatte queste considerazioni, che dovrebbero apparire banali, l’ultima sottolineatura di Benedetto XVI può essere interpretata, in una sua versione più forte, come la pretesa di veder riconosciuta una Verità assoluta, di fronte alla quale dovrebbe tacere ogni dissenso o pensiero critico; o, in una versione più debole, come una ulteriore richiesta di non confinare la religione soltanto nella sfera privata.
La prima interpretazione è evidentemente inaccettabile, contrastante com’è con i caratteri della democrazia e con i principi costituzionali. In essa si riflette piuttosto una visione non nuova, quella di una tradizione cattolica "che nel re legittimo, alleato con la Chiesa, scorgeva il caposaldo per l’opera di ricostruzione" necessaria per "rimediare all’opera deleteria svoltasi a partire del Settecento" (così Arturo Carlo Jemolo in apertura del gran libro su Chiesa e Stato negli ultimi cento anni che dovrebbe essere lettura obbligata in questi tempi difficili).
La seconda appare piuttosto come una forzatura, poiché storia e cronaca recenti mostrano con quanta intensità e continuità la religione, giustamente, si manifesti nella sfera pubblica. Le resistenze, allora, non riguardano questo elemento, ma una conseguenza che se ne vorrebbe trarre: il riconoscimento di un nuovo "temporalismo", con l’attribuzione alla Chiesa di un potere di governo sociale che abbandoni il principio che vuole lo Stato e la Chiesa, "ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani" (articolo 7 della Costituzione). Due parti autonome e distinte, dunque. E questo, lo espresse con parole chiare e misurate Giuseppe Dossetti all’Assemblea costituente, vuol dire che "nessuna di esse delega o attribuisce poteri all’altra o può, per contro, in qualsiasi modo, divenire strumento dell’altra". È interesse comune che la separazione rimanga, e che la legittima pluralità dei diversi punti di vista venga tenuta ferma, proprio per evitare che si creino condizioni propizie sia alla compressione della libertà religiosa che alla limitazione della libertà di discussione nella sfera pubblica.
Tracciare nitidamente questa linea di confine, e rispettarla, non è cosa facile. Con forza, e ripetutamente, le gerarchie ecclesiastiche hanno rivendicato la loro libertà di parola, come manifestazione diretta della libertà religiosa. E’ ovvio che sia così, e che in società complesse, dove tutto si tiene, la Chiesa ritenga che non vi siano limiti al suo intervento. Ma questa dilatazione porta con sé due conseguenze. La prima riguarda il magistero in senso proprio della Chiesa, che evidentemente non può incontrare limiti, e tuttavia non può esprimersi in forme tali da condizionare il libero svolgimento di attività e funzioni pubbliche. La seconda si riferisce alle valutazioni, anch’esse in principio legittime, sulla vicenda politica quotidiana, si tratti delle intercettazioni telefoniche o della riforma costituzionale. Qui le organizzazioni ecclesiastiche non possono pretendere alcun privilegio, sono soggetti politici tra gli altri e devono sottostare alle regole della discussione pubblica. Che, tra l’altro, permette di consentire o dissentire a seconda delle opinioni espresse, togliendo ogni peso alla tesi di chi vuol cogliere in contraddizione i laici che, caso per caso, apprezzano o respingono le posizioni della Conferenza episcopale, di un cardinale o di un vescovo.
Ma la separazione tra Stato e Chiesa è stata contestata recentemente, ad esempio da monsignor Caffarra, con una mossa culturale e politica che conferma la propensione, da una parte, ad una "revisione costituzionale indiretta", che mette in discussione proprio punti essenziali della prima parte della Costituzione; e, dall’altra, con un pericoloso avvicinamento tra peccato e reato che può accantonare una delle più importanti acquisizioni della civiltà moderna, la distinzione tra norma morale e norma giuridica. Che non è questione formale o nominalistica: riguarda, infatti, la individuazione del soggetto che ha il potere di valutare e sanzionare i comportamenti individuali o collettivi. Se il peccato diviene il riferimento fondamentale, quel potere rischia di trasferirsi interamente nelle mani della Chiesa e i parlamenti potrebbero mantenere qualche prerogativa solo a condizione di farsi meri strumenti di trasmissione della sua volontà.
E’ un’altra versione della critica al relativismo, perché la definizione del reato si presenterebbe come il risultato di un processo di valutazione che tien conto di fattori culturali, sociali, politici, per loro natura variabili e per ciò sospetti, perché non fondati su valori forti e permanenti. Ma, a parte ogni altra considerazione, è proprio la storia a smentire la fondatezza di tesi del genere.
Qualche giorno fa, in tutto il mondo, si è manifestato contro la pena di morte, ricordando che essa era stata cancellata il 30 novembre 1786 dal Granducato di Toscana. Una decisione che veniva a pochi anni dalla pubblicazione, nel 1774, Dei delitti e delle pene di Cesare Beccarla, frutto del gran rispetto per il valore della vita di quell’illuminismo oggi presentato come radice di relativismi, o addirittura di orrori. Quanto forti e profondi siano i valori che accompagnano la laicità è cosa che può esser colta solo con una attenzione culturale che sembra esser stata travolta da approssimazioni e dogmatismi, da uno sguardo corto quanto i tempi di uno spettacolo televisivo. E, per tornare ai riferimenti di Jemolo, è troppo chiedere di dare un’occhiata, ad esempio, ad un libro come Settecento riformatore di Franco Venturi, che tra l’altro sarebbe un buon viatico anche per tanti riformisti dell’ultima ora?
Serve un po’ di buona cultura, e di attenzione reciproca, per far decollare una discussione sui valori che ci riporti all’altezza non di tempi mitici, ma delle giornate in cui laici e cattolici, senza concessioni ma senza strumentalismi, stendevano quella gran carta dei valori che ancora oggi è la Costituzione della Repubblica.
La libertà dei credenti in una religione è combattuta, negata, limitata, dove incontra un altro punto di vista religioso, ideologico o politico che pretende l’esclusività. Dove, quindi, s’instaura un conflitto tra assoluti, ciascuno dei quali cerca di sopraffare l’altro. E’ il caso dei regimi totalitari, delle teocrazie variamente organizzate, dei paesi dove impera una religione di Stato. Non è quel che accade nelle democrazie che, appunto, si fondano sul pluralismo. In questo senso, proprio quel "predominio culturale del relativismo", che inquieta il Pontefice, è il miglior vaccino contro le tentazioni di chi vuol comprimere la libertà religiosa.
Fatte queste considerazioni, che dovrebbero apparire banali, l’ultima sottolineatura di Benedetto XVI può essere interpretata, in una sua versione più forte, come la pretesa di veder riconosciuta una Verità assoluta, di fronte alla quale dovrebbe tacere ogni dissenso o pensiero critico; o, in una versione più debole, come una ulteriore richiesta di non confinare la religione soltanto nella sfera privata.
La prima interpretazione è evidentemente inaccettabile, contrastante com’è con i caratteri della democrazia e con i principi costituzionali. In essa si riflette piuttosto una visione non nuova, quella di una tradizione cattolica "che nel re legittimo, alleato con la Chiesa, scorgeva il caposaldo per l’opera di ricostruzione" necessaria per "rimediare all’opera deleteria svoltasi a partire del Settecento" (così Arturo Carlo Jemolo in apertura del gran libro su Chiesa e Stato negli ultimi cento anni che dovrebbe essere lettura obbligata in questi tempi difficili).
La seconda appare piuttosto come una forzatura, poiché storia e cronaca recenti mostrano con quanta intensità e continuità la religione, giustamente, si manifesti nella sfera pubblica. Le resistenze, allora, non riguardano questo elemento, ma una conseguenza che se ne vorrebbe trarre: il riconoscimento di un nuovo "temporalismo", con l’attribuzione alla Chiesa di un potere di governo sociale che abbandoni il principio che vuole lo Stato e la Chiesa, "ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani" (articolo 7 della Costituzione). Due parti autonome e distinte, dunque. E questo, lo espresse con parole chiare e misurate Giuseppe Dossetti all’Assemblea costituente, vuol dire che "nessuna di esse delega o attribuisce poteri all’altra o può, per contro, in qualsiasi modo, divenire strumento dell’altra". È interesse comune che la separazione rimanga, e che la legittima pluralità dei diversi punti di vista venga tenuta ferma, proprio per evitare che si creino condizioni propizie sia alla compressione della libertà religiosa che alla limitazione della libertà di discussione nella sfera pubblica.
Tracciare nitidamente questa linea di confine, e rispettarla, non è cosa facile. Con forza, e ripetutamente, le gerarchie ecclesiastiche hanno rivendicato la loro libertà di parola, come manifestazione diretta della libertà religiosa. E’ ovvio che sia così, e che in società complesse, dove tutto si tiene, la Chiesa ritenga che non vi siano limiti al suo intervento. Ma questa dilatazione porta con sé due conseguenze. La prima riguarda il magistero in senso proprio della Chiesa, che evidentemente non può incontrare limiti, e tuttavia non può esprimersi in forme tali da condizionare il libero svolgimento di attività e funzioni pubbliche. La seconda si riferisce alle valutazioni, anch’esse in principio legittime, sulla vicenda politica quotidiana, si tratti delle intercettazioni telefoniche o della riforma costituzionale. Qui le organizzazioni ecclesiastiche non possono pretendere alcun privilegio, sono soggetti politici tra gli altri e devono sottostare alle regole della discussione pubblica. Che, tra l’altro, permette di consentire o dissentire a seconda delle opinioni espresse, togliendo ogni peso alla tesi di chi vuol cogliere in contraddizione i laici che, caso per caso, apprezzano o respingono le posizioni della Conferenza episcopale, di un cardinale o di un vescovo.
Ma la separazione tra Stato e Chiesa è stata contestata recentemente, ad esempio da monsignor Caffarra, con una mossa culturale e politica che conferma la propensione, da una parte, ad una "revisione costituzionale indiretta", che mette in discussione proprio punti essenziali della prima parte della Costituzione; e, dall’altra, con un pericoloso avvicinamento tra peccato e reato che può accantonare una delle più importanti acquisizioni della civiltà moderna, la distinzione tra norma morale e norma giuridica. Che non è questione formale o nominalistica: riguarda, infatti, la individuazione del soggetto che ha il potere di valutare e sanzionare i comportamenti individuali o collettivi. Se il peccato diviene il riferimento fondamentale, quel potere rischia di trasferirsi interamente nelle mani della Chiesa e i parlamenti potrebbero mantenere qualche prerogativa solo a condizione di farsi meri strumenti di trasmissione della sua volontà.
E’ un’altra versione della critica al relativismo, perché la definizione del reato si presenterebbe come il risultato di un processo di valutazione che tien conto di fattori culturali, sociali, politici, per loro natura variabili e per ciò sospetti, perché non fondati su valori forti e permanenti. Ma, a parte ogni altra considerazione, è proprio la storia a smentire la fondatezza di tesi del genere.
Qualche giorno fa, in tutto il mondo, si è manifestato contro la pena di morte, ricordando che essa era stata cancellata il 30 novembre 1786 dal Granducato di Toscana. Una decisione che veniva a pochi anni dalla pubblicazione, nel 1774, Dei delitti e delle pene di Cesare Beccarla, frutto del gran rispetto per il valore della vita di quell’illuminismo oggi presentato come radice di relativismi, o addirittura di orrori. Quanto forti e profondi siano i valori che accompagnano la laicità è cosa che può esser colta solo con una attenzione culturale che sembra esser stata travolta da approssimazioni e dogmatismi, da uno sguardo corto quanto i tempi di uno spettacolo televisivo. E, per tornare ai riferimenti di Jemolo, è troppo chiedere di dare un’occhiata, ad esempio, ad un libro come Settecento riformatore di Franco Venturi, che tra l’altro sarebbe un buon viatico anche per tanti riformisti dell’ultima ora?
Serve un po’ di buona cultura, e di attenzione reciproca, per far decollare una discussione sui valori che ci riporti all’altezza non di tempi mitici, ma delle giornate in cui laici e cattolici, senza concessioni ma senza strumentalismi, stendevano quella gran carta dei valori che ancora oggi è la Costituzione della Repubblica.
Stefano Rodotà
Stefano Rodotà (1933-2017) è stato professore emerito di Diritto civile all’Università di Roma “La Sapienza”. Ha insegnato in molte università straniere ed è stato parlamentare in Italia e in Europa. …