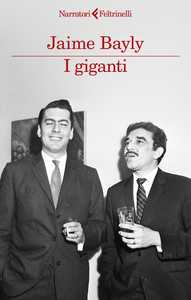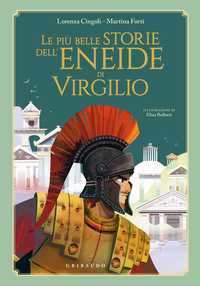Erri De Luca: Kathmandu, la città in cui i bambini non piangono
26 Aprile 2006
Il piccolo aereo si infilò nella valle e la risalì puntando verso l’alto. D’improvviso atterrò su una pista disposta in salita. Quando invece che in discesa, un atterraggio si fa in salita, sei in Nepal, anzi in Nepàl, per una volta la pronuncia napoletana aiuta. A Kathmandu non lo sai ancora, sei stordito dai fusi, dal dono di una ghirlanda al collo e dall’arrembaggio sonoro di una città asiatica. Sei nella capitale delle montagne più alte della terra, ma da lì non si vedono. Per le sue strade brulica un’umanità magra e veloce, affumicata dai gas di scarico del motore Asia. Nell’aprile, già estivo per noi, gli alpinisti passeggiano in sandali, ma nelle loro valigie hanno le quattro stagioni. Non resteranno per quattro stagioni, ma le attraverseranno lo stesso, passando a piedi dalle risaie ai ghiacciai. A Kathmandu gli alpinisti mangiano forte, addentano bistecche di Yak, in previsione dei liofilizzati d’alta quota. Mangiano forte pure al ritorno dalle quote alte, sotto la spinta di una fame più sana e più silenziosa. Aprile e maggio sono i mesi buoni, prima del monsone di giugno che sfratta gli ultimi scalatori. Si può arrivare senza attrezzatura e procurarsela tutta sul posto, Kathmandu è il più grande bazar alpinistico del mondo: nel paio di giorni di sosta obbligata, in attesa delle formalità burocratiche di una spedizione di alta quota, lo scalatore va al tempio delle scimmie o a vedere il gran Buddha con gli occhi azzurri. Ovunque si sposti incontra un genere umano bisognoso di tutto e sorridente a oltranza. Non si sente piangere un bambino. C’è da toccarsi le orecchie per controllare se non ci sono finiti dei tappi per sbaglio: in mezzo alla folla di bambini scalzi, di corsa, accesi da un gioco, spenti da una stanchezza, un malanno, non si sente piangere. Per me questo coincide con la civiltà. Non si misura a parlamenti e redditi procapite, la civiltà, ma a pianti di bambini. Diversi scalatori dopo un po’di spedizioni in Nepal si sono impegnati a dare una mano al popolo che li aveva accolti, serviti fino agli ultimi gradini delle loro salite, fino al sacrificio personale. Non erano alpinisti quei popoli di montagna. Anzi per tradizione ritenevano le montagne la residenza delle divinità, perciò da non violare. Invece imparavano a servire e seguire quegli arruolatori stranieri che avevano bisogno delle loro schiene per il trasporto dei materiali. Dimostrarono di avere buone anche altre parti, mani, fegato, nervi. Mantenevano in fitto la vita per un salario irrisorio per chi lo pagava, enorme per chi lo intascava. Lo squilibrio è una mossa della nostra civiltà. Diversi scalatori a forza di spedizioni si sono trasformati in sostenitori, in portatori di aiuti al popolo del Nepal. Uno celebre: Hillary, primo salitore dell’Everest, un italiano: Fausto De Stefani, tutti gli ottomila saliti, uomini così hanno raccolto aiuti, fondato scuole, ospedali. Il Nepal è il perfetto sottosopra: cime volute accanitamente e pagate da chi se lo può permettere e un fondovalle lacero, piegato. Uomini come Hillary e De Stefani restituiscono qualcosa di quella grandezza che hanno calpestato con i loro ramponi piantati sulle punte più alte di quella terra. Restituiscono qualcosa a quel popolo per gratitudine. Ecco un altro parametro accanto al pianto dei bambini: la gratitudine che un posto sa suscitare nei suoi passanti venuti da lontano, misura la civiltà di un luogo. Là dove le forze di natura sono più sfrenate e più precaria è la tenuta del corpo umano, si sta più da inquilini di passaggio che da proprietari. È una bella mossa quella cerimonia propiziatoria che ogni spedizione compie ai piedi del gigante, scusandosi con la montagna per la violazione del suo spazio. È un atto di civiltà imparato lì, dimenticato altrove. Gran parte del territorio nepalese è da tempo sottratto al governo centrale della guerriglia maoista. L’anno scorso nella spedizione al Dhaulagiri (8.172 metri) attraversammo quelle zone contese. In Nepal si va molto a piedi, le strade finiscono presto. Per raggiungere le pendici del Dhaulagiri ci vogliono più di cento chilometri di cammino. In cima a un’altura incontrammo una bandiera rossa. Era il segno del confine, da lì si entrava in un’altra giurisdizione. Il passaggio era uguale, la povertà pure. Ci fu richiesta una tassa di venti euro a testa, ci fu rilasciata una ricevuta per quietanza. Non vedemmo soldati nè armi. In ogni villaggio i bambini chiedevano penne da scrivere. Ho avuto vergogna lì di fare per mestiere lo scrittore e non averne mille da offrire.
Erri De Luca
Erri De Luca è nato a Napoli nel 1950. Ha pubblicato con Feltrinelli: Non ora, non qui (1989), Una nuvola come tappeto (1991), Aceto, arcobaleno (1992), In alto a sinistra (1994), Alzaia (1997, …