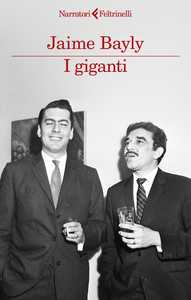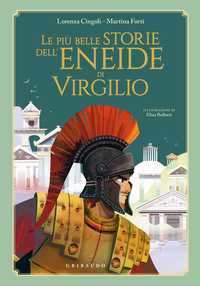Gabriele Romagnoli: Mondiali 2006. Arrivederci Da Ricardo alle olandesine, la Nazionale dei rimpianti
30 Giugno 2006
Lo ‟splashtime” è finito. Nelle piscine serie designa il periodo di tempo in cui è concesso ai bambini di fare casino tuffandosi e sguazzando in acqua. Dopo, nelle otto vasche restano solo i nuotatori veri. Quelli che ai Mondiali si sono soltanto tuffati sono già passati per lo spogliatoio e tornati a casa. Alcuni però, ci hanno lasciato troppo presto, meritando, almeno, una cerimonia d’addio prima di scomparire nell’abisso della memoria. Questa è la Nazionale dei rimpianti, i top 11 che avremmo voluto vedere ancora. Ricardo. Era il portiere dell’Angola. Assomigliava al personaggio creato da Malamud nel romanzo ‟Il migliore” e interpretato da Robert Redford al cinema. Un giocatore fuori tempo massimo, con la carriera interrotta, tornato con un passato oscuro e una promessa senza pretese: ‟Mister, mi allenerò tutti i giorni”. Trentasei anni, emigrato per sfuggire a una guerra. Ingaggiato e dimenticato come una valigia senza padrone sul rullo di un aeroporto portoghese. Convocato perché in tutta l’Angola non si trovava un portiere, si è presentato, si è allenato, ha giocato, è stato eletto uomo partita nello 0 a 0 con il Messico in cui ha parato tutto. Come ‟il migliore” scompare di nuovo nell’ombra della sua vita. Pantsil. Era il giocatore del Ghana che, dopo la vittoria con la Repubblica Ceca, ha corso per il campo sventolando la bandiera d’Israele. Sventolando quel simbolo Pantsil ha assolto tre importanti funzioni. Prima: ha contestato l’insopportabile coro nazionalista e identitario che impone di cantare l’inno, dedicare al presidente e difendere l’orgoglio patrio sfregiato dai commentatori stranieri. Secondo: suscitando la protesta delle diplomazie arabe ne ha confermato l’ilare incapacità di essere serie. Terzo: ha semplicemente ribadito la fondatezza del proverbio lucano ‟chiamo padre chi mi dà da mangiare”. Mahdavikia. Era il poligamo iraniano a cui, alla vigilia, sono stati dedicati articoli di colore. Giocatore trascurabile, di lui sì avremmo voluto le intercettazioni, la sera al telefono con quattro mogli, una dopo l’altra. ‟Mi manchi”, ‟Anche tu”. ‟Quando torni?”, ‟Presto”. ‟Ti amo”, ‟Ti amo”. ‟Mi manchi”, ‟Anche tu”. ‟Quando torni?”, ‟Presto”. ‟Ti amo”, ‟Ti amo”. ‟Mi manchi”, ‟Anche tu”. ‟Quando torni?”, ‟Presto”. ‟Ti amo”, ‟Ti amo”. ‟Mi manchi”, ‟Anche tu”. ‟Quando torni?”, ‟Presto”. ‟Ti amo”, ‟Ti amo”. Nedved. Era Nedved. E se n’è andato probabilmente per sempre, con il pallone e la zazzera d’oro. Non era simpatico a molti, anche perché in Italia ha giocato in squadre simpatiche a pochi. Ma era uno di quelli che non si arrendono, anche quando sembra finita e non hai nessuno intorno. Continuava a pestare, tirare, scuotere la testa. Facendolo, ha cambiato molti destini. L’ultimo, come per chiunque, era fuori portata. La Volpe. Se questo era un hombre. Piantato davanti alla panchina del Messico con la faccia da hidalgo e una cravatta che sfidava ogni giudizio, ha rischiato di fregare l’Argentina che gli aveva dato i natali e una maglia da terzo portiere campione del mondo. Rinnegato, vendicativo e creativo, ha pensato di poter sfidare Peck a un mezzogiorno di fuoco. Poi è scesa la notte. Hiddink. Era un signore. E lo resterà. Antitesi estetica di La Volpe: camicia bianca inamidata e gemelli. Alchimista capace di trarre succo da ogni rapa, in ogni continente. Ha disposto l’Australia sul campo facendo finta che fosse una squadra di calcio, ha ipnotizzato il pubblico, attirando su di sé gli occhi. L’illusione è riuscita finché il karma ha preteso che i conti fossero regolati dopo quattro anni: arbitro dà, arbitro toglie. Ha accolto il verdetto con eleganza. Tanto è già sull’aereo per la Russia. Lui, nel 2010, lo rivedremo. Poll. Era un arbitro, Così assicurano. ‟Exit Poll” hanno titolato i tabloid inglesi la sua prematura cacciata per aver mostrato tre cartellini gialli allo stesso calciatore prima di espellerlo. Peccato davvero non sia rimasto. La professione arbitrale ha bisogno di essere riformata, le regole del gioco pure e lui sembrava il più indicato a farlo. Uno così sarebbe stato bello vederlo dirigere la finale. Owen. Era, dell’Inghilterra, una delle già fragili punte. Si è rotto in una di quelle maniere che fa male vedere. Seduti in poltrona si fa una smorfia con il viso e ci si tocca istintivamente la gamba. Poi si pensa alla fatica che può costare stare fuori, andare dal fisioterapista invece che a ballare con le ‟mogliose”, aspettare, leggere quelli che scrivono: ‟è stato un colpo di fortuna, ora giocheremo con il 4-5-1”, quelli che ‟non ce la farà a riprendersi”, riprovarci invece. Owen diventa il capitano di una pattuglia ‟missing in action”, talenti spezzati alla vigilia della battaglia e fin qui poco recuperati. Per tutti loro sul biglietto d’auguri c’è la faccia di Ronaldo. Le olandesine. Erano le più colorate, belle, allegre. A Francoforte protestavano perché non potevano andare a visitare gli eros center, a Berlino bevevano più degli uomini, a Norimberga sono sparite, così, lasciandoci con la sospetta cortesia delle ucraine, la follia delle inglesi e le francesi dipinte di blu. Il bello di questi Mondiali rispetto all’edizione asiatica è che il pubblico è vero: per il Portogallo tifano portoghesi, per l’Argentina argentini. Ma se Van Basten avesse fatto giocare l’ottavo a Van Nistelrooy, forse tutto sarebbe ancora più bello. Torres. Era quell’attaccante spagnolo che sembrava appena uscito dalla casa del Grande Fratello: Fernando, quello con la cresta gialla che faceva gli scherzi a Raul, il vecchio del gruppo. Era, anche, un giocatore devastante, secondo, in proiezione, solo a Messi. Come i giovani di questo tempo, dopo essersi lamentati delle gerarchie gerontofile ottiene uno spazio e se lo prende a metà. Affonda nel confronto con la solida vetustà di Zidane e lascia sul campo la traccia dell’universale deragliamento della cosiddetta ‟meglio gioventù”, guerrigliera, zapatera o salottiera che fosse. L’Africa. Era il continente emergente. Manco stavolta affiorerà nelle semifinali. Ha spedito in Germania le rappresentanze di federazioni sgangherate, pittoresca quella del Togo, con l’allenatore fantasma e i giocatori in sciopero. Ha evitato il collasso con il colpo di coda del Ghana. Si è immalinconita per l’assenza di Nigeria, Camerun e perfino dell’Egitto, che è campione continentale perché ha giocato in casa. Giocherà in casa la prossima volta e, se ha imparato qualcosa da queste spedizioni, riuscirà, come fecero gli asiatici, a sfatare il tabù e continuare a giocare quando l’ora del dilettante sarà finita.
Gabriele Romagnoli
Gabriele Romagnoli (Bologna, 1960) Giornalista professionista, a lungo inviato per “La Stampa”, direttore di “GQ” e Raisport è ora editorialista a “la Repubblica”. Narratore e saggista, il suo ultimo libro è …