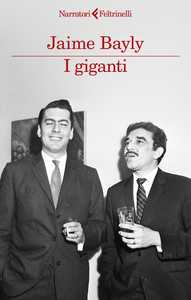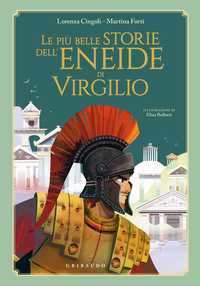Vittorio Zucconi: Altman, lautoritratto dellAmerica
27 Novembre 2006
Robert Altman era divenuto l’autoritratto vivente dell’America, un viso alla John Houston, alla James Coburn, alla Lee Marvin, ispido, storto, burbero, allegro, disordinato come un letto di motel a Nashville o sfatto come una barella portaferiti in un ospedale militare da campo M. A. S. H., con le tracce della propria storia esibite senza make up. Il viso bellissimo dell’America onesta con se stessa. Era, naturalmente, esecrato dall’America retorica, bigotta, cotonata e laccata, quella che ci deve ripetere a ogni discorso di essere ‟la più grande democrazia del mondo benedetta da Dio” con un’insistenza che tradisce l’ansia di non esserlo. Ma in mezzo secolo di lavoro cinematografico, dai cortometraggi che produceva a raffica nel 1955 per 250 dollari a botta, (55 in un anno) alla sua morte silenziosa e discreta la sera di lunedì scorso in un ospedale di Los Angeles a 81 anni di età, il narratore dell’America come è, e non come vorrebbe essere, non aveva mai cercato di convincere nessuno. Neppure il grande pubblico che lo ha ammirato a distanza senza mai abbracciarlo, sospettandolo della colpa che Hollywood non perdona, quella di essere un intellettuale. E per di più anche un po’ di sinistra. In realtà, anche se aveva annunciato come tanti il proposito, puntualmente poi disatteso da tutti, di emigrare all’estero nel 2000 se George Bush avesse vinto le elezioni, Altman era soprattutto un "missourian", un tipico figlio di quello stato del Missouri (era nato a Kansas City) che ha scelto come proprio motto le parole ‟Show Me”, fatemi vedere perché altrimenti non ci credo. In questa terra di San Tommasi della prateria, di scettici che le hanno viste tutte perché da lì partivano i tratturi per le mandrie di animali spinte verso i macelli dell’Ovest, "Bob" era nato da un cattolicissimo padre tedesco ricco assicuratore e da una protestantissima mamma che vantava addirittura antenati sul veliero dei pellegrine, il Mayflower. E delle maniere burbere, riservate e ruvide dei "missourian", compresi quelli celebri come il presidente Harry Truman, il sardonico, a volte fin troppo enigmatico, osservatore delle debolezze e dei tic americani, aveva dato prova fino all’ultimo. Fino a pochi mesi or sono, quando la Hollywood che lui aveva combattuto e disprezzato per tutta la vita, gli concesse l’Oscar che si dà a chi non deve vincere un Oscar vero, la statuetta "alla carriera", soltanto la seconda moglie e gli intimi sapevano che dieci anni prima aveva subito un trapianto di cuore. ‟So che un Oscar alla carriera si dà a chi sta per morire” disse fingendo di non essere commosso ‟ma io ho intenzione di farvi l’ultimo dispetto e lavorare ancora per almeno quattro o cinque anni”. Si saprà soltanto più tardi che quello sarebbe stato l’ultimo sberleffo, perché il cuore di ricambio stava già perdendo i colpi, ma ‟almeno la soddisfazione di prendere un premio da morto, alla memoria, non gliel’ho data” confidò a Julian Fellowes, lo sceneggiatore di uno dei suoi film più sontuosi e complessi, Gosford Park, che vinse un Oscar vero, ma soltanto per la sceneggiatura. Non fu la sola soddisfazione amara contro quell’establishment della cultura di celluloide contro il quale aveva combattuto dal momento in cui aveva rinunciato al suo primo sogno, quello di fare i soldi inventando un nuovo tipo di medaglietta per i cani ed era passato dietro la cinepresa. M. A. S. H, il suo film più celebre sulla insensatezza delle guerre che lui aveva combattuto nel posto più pericoloso, quello di bombardiere a bordo dei B24, era stato respinto da cinque registi, prima che lui accettasse di produrlo nel 1970. I protagonisti, la sua sanguinosa satira dei pomposi studios cinematografici che lo odiavano ricambiati, come Nashville, parodia del mondo autoreferenziale della country music che generò ironicamente una delle più popolari ballate americane, "I’m easy" cantata da Keith Carradine, seguirono forse inconsciamente lo stesso filo di nota, cioè utilizzare la realtà per renderla grottesca, in una sorta di realismo surreale ma efficace. M. A. S. H, che partorì poi la serie più longeva e più amata nella storia della tv americana, fu per la generazione del Vietnam, in quel 1970, ciò che Comma 22 di Joseph Heller era stato per la generazione della Seconda Guerra. Il teorema secondo il quale soltanto essendo pazzi si può sopravvivere alla pazzia della guerra. Hitchcock lo adorava, e gli affidò la regia di sei episodi della propria leggendaria serie tv. L’Europa e il resto del mondo, sempre pronti ad abbracciare e adottare chiunque graffi la prepotenza laccata dei miti americani così rafforzandoli, venerava in lui quella autoironia che tanto difetta alla macchina dei sogni hollywoodiani. Ma lui sosteneva di non essere affatto un narratore, un cantore, meno che mai un "social critic", un savonarola di costumi e di mala tempora, a parte la ribellione costante contro la mafia degli studios. ‟A me interessano i rapporti tra le persone, le storie sono un effetto, non una causa dell’interazione fra esseri umani” sosteneva e per questo, considerandoli generosamente come esseri umani, permetteva agli attori di improvvisare sul set, di seguire la propria ispirazione, adattando la storia a loro e non viceversa. E in questa sua "poetica" dell’ispirazione sta quella sincerità che "Tinseltown", la Hollywood di stagnola, temeva e rifiutava, più della sua incapacità di produrre, in più di ottanta film e telefilm girati, successi in serie. Troppo iconoclasta per piacere ai custodi delle icone politiche, ideologiche e cinematografiche, oggi spacciate per America, come dollari falsi.
Vittorio Zucconi
Vittorio Zucconi (1944-2019), giornalista e scrittore, è stato condirettore di repubblica.it e direttore di Radio Capital, dove ha condotto TG Zero. Dopo aver cominciato nel 1963 come cronista precario a …