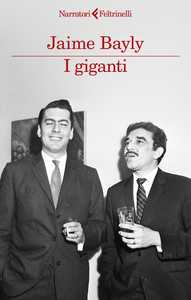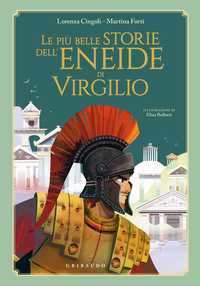Salvatore Natoli: Con Welby ma attenti agli alibi
18 Dicembre 2006
Quella di Welby è una drammatica storia privata che ha, però, riportato al centro del dibattito pubblico una questione mai sopita, anzi ricorrente, come quella dell’accanimento terapeutico e della cosiddetta eutanasia o meglio morte assistita.
Si tratta di uno dei dilemmi morali tra i più rilevanti per le soluzioni sempre più urgenti che esige e per la mutazioni di mentalità che può apportare circa il senso della vita e della morte. Un dibattito che diviene sempre più cogente dal momento che le condizioni estreme della vita umana la nascita e la morte hanno da tempo perso la loro fissità naturale e sono sempre di più suscettibili di manipolazione.
E non siamo che agli inizi.
Nel caso della morte, in alcuni casi, la medicina può oggi differirla sine die. Welby rifiuta il prolungamento della vita che la medicina gli consente perché quella che vive o più esattamente è costretto a vivere non gli pare affatto vita, anzi la ritiene una violenza perpetrata su di lui, una tortura o, come egli dice, una prigionia. Credo a quel che Welby dice e lo prendo sul serio. In una vicenda individuale così drammatica non mi sento di fare altrimenti né di dire al sofferente che la vita è da vivere fino in fondo e in qualsiasi modo e meno che mai che non è padrone della sua vita. E se non è lui, chi lo è? Dio si potrebbe dire. Ma per dirlo, in Dio bisognerebbe crederci.
Ma questa vicenda personale diviene immediatamente pubblica nel momento in cui si tratta di sospendere la terapia. Cosa che di per sé nel caso di Welby sarebbe del tutto legittima, dal momento che la Costituzione consente ad ognuno di rifiutare una terapia. D’altra parte il rifiuto dell’accanimento terapeutico è condiviso anche da chi si oppone alla morte assistita.
Nel caso di Webly, però, la sospensione della terapia provocherebbe una terribile agonia e per evitarla bisognerebbe staccare il ventilatore polmonare e quindi provocare la morte.
Si passerebbe dalla sospensione dell’accanimento terapeutico all’eutanasia.
Ma ciò allo stato non è consentito.
La ministro Turco si è rivolta al Consiglio superiore di sanità per chiedere lumi e sapere se si tratta di sospensione di terapia o altro. La questione, come da varie parti si viene dicendo, sta passando per molte mani e si complica. È necessario che vi sia un’autorità unica.
Per quanto attiene al caso Welby spero si trovi presto una soluzione adeguata, ma la questione resta ugualmente aperta. Ma quand’anche fosse eutanasia la si può ammettere? In una situazione sempre più ingravescente e irreversibile ove le cure non hanno più alcuna efficacia salvo forse le palliative, che tra l’altro possono accelerare la morte è giusto o meno aiutare qualcuno che lo richiede a morire? Io ritengo sia giusto. Il compito della medicina è certo quello di guarire e qualora ciò non fosse possibile quello di curare. Ma se le cure si rivelano inutili il compito della medicina è quello di non fare soffrire e perciò di non prolungare attraverso una vita sempre più artificiale e questa volta davvero poco naturale - la sofferenza di un paziente terminale. Il sofferente è l’unico davvero competente della sua condizione e deve poter decidere della propria fine. Sul piano del diritto non mi sembra possono essere sollevate obiezioni. Lo stato di diritto, che si è venuto elaborando nel corso della modernità, è caratterizzato dall’implementazione costante dei diritti soggettivi. Al centro di ogni dispositivo giuridico resta la persona e i dispositivi giuridici devono essere elaborati in funzione del mantenimento e ampliamento delle libertà individuali sempre che non interferiscano con quelle altrui.
Esistono poi norme che sono vincolanti per tutti e norme che tutelano le scelte dei singoli: leggi a cui tutti si devono conformare e leggi che in determinate circostanze ognuno può per sé singolarmente utilizzare. Tra la sospensione della terapia e la morte assistita spesso il confine è breve, ma in ogni caso è giusto permettere agli individui che si trovano in condizioni irreversibili di evitare ulteriore e inutili sofferenze. La partita è chiusa. Non si vede perché una richiesta d’aiuto a morire debba essere disattesa, quando si constata che non c’è più nulla da fare e ogni intervento è ormai sovrappiù.
Certo, una norma non può essere fatta né per Welby né per altri in particolare.
Ma il caso singolare solleva una questione generale: in breve, costringere a vivere in certe condizioni è violenza, non aiutare a morire spietatezza. Pare peraltro, che laddove la morte assistita è consentita non siano poi molti a chiederla. A coloro che temono il peggio, vale la pena ricordare che gli uomini non hanno una gran voglia di morire e questa volta, sì, per natura. Evidentemente nel consentire la morte assistita è necessario elaborare un articolato di legge che la permette ma certamente non la faciliti.
Ma se sul piano della legge è giusto riconoscere al singolo il diritto di decidere della propria fine, senza che gli sia imposta una dolorosa sopravvivenza, che chiamerei piuttosto submorienza altra cosa invece è assecondare una mentalità facilitante.
Bisogna tenere conto che le mutazioni di mentalità non avvengono per dibattito, ma s’impiantano per pratica. Dal momento in cui una certa cosa è permessa non la si discute più: diviene ovvia. E allora perché non praticarla? Ma quel che è lecito non è detto che sia buono o che comunque sia il meglio. Questo è un rischio oggettivo e bisogna riconoscere che su questo le Chiese, a parte le loro impertinenza sulle legislazioni, hanno una spiccata sensibilità.
Consentire la morte assistita potrebbe dare luogo ad un’impalpabile mutazione di mentalità. E non è il solo caso. Potrebbe perciò accadere che gli uomini non essendo all’altezza della sofferenza e per molti versi lo sono sempre meno liquidassero il sofferente e la morte assistita, lungi dal salvaguardare la dignità del morente, si tramutasse impalpabilmente in un’indisponibilità a prendersi reciprocamente in carico sino alla fine e incondizionatamente. Anche questa sarebbe eutanasia, ma dell’amore.
Vizi e virtù una volta che s’impiantano diventano abitudini: semplicemente si vivono. Per questo quel che è valido sul piano del diritto e delle libertà, per eterogenesi dei fini potrebbe divenire un alibi del disamore.
La vita non è mai interamente nostra: viviamo gli uni della vita altri.
Può dunque accadere che nella più atroce delle sofferenze qualcuno abbia il coraggio di portare all’estremo limite la sua vita se si sente importante per qualcuno o, se credente, si sente nonostante tutto amato da Dio.
Quel che dunque è legittimo in diritto non è detto sia sufficiente per la vita, che è più drammatica e complessa di qualsiasi legislazione e che può essere voluta fi- no all’estremo delle sue possibilità se si è capaci di generosità. La legge garantisce il diritto, ma l’amore non lo si può imporre per legge. La morte assistita può divenire una copertura per la debolezza, un alibi per il disamore. Potrebbe, al contrario, essere l’ultimo estremo atto di pietà. E la pietà é un modo dell’amore. Ma chi decide delle intenzioni? Lasciamo spazio alla libertà.
Intanto regoliamola per legge per evitare l’arbitrio o, peggio ancora, il sottobanco.
Salvatore Natoli
Salvatore Natoli è professore di Filosofia teoretica. Tra le sue opere ricordiamo: Ermeneutica e genealogia. Filosofia e metodo in Nietzsche, Heidegger, Foucault (Feltrinelli, 1980), L’esperienza del dolore. Le forme del …