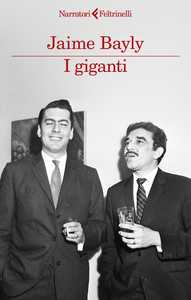Paolo Rumiz: Addio a Kapuscinski, missione reporter
24 Gennaio 2007
È morto Ryszard Kapuscinski, uno dei più grandi reporter del mondo. Per la sua professione non si era mai risparmiato, ed è stata probabilmente la professione a portarselo via. Polacco, era nato a Pinsk, nell’attuale Bielorussia, nel marzo del 1932. Aveva scritto libri e reportage straordinari dall’Africa, l’America latina, dalla Russia sovietica e dalle zone più calde del Medio Oriente. Operato tre giorni fa di cancro, era già gravemente malato di cuore. Non era uomo di grandi alberghi, viaggiava tra i poveri dei poveri. Con loro aveva condiviso la paura e la fame. Aveva rischiato di essere bruciato, vivo, linciato, fucilato. Aveva superato una forma grave di malaria cerebrale e anche la tubercolosi. Ovunque, diventava parte del mondo che raccontava. In prima linea.
Eppure era fragile. Al primo incontro con lui, nel gennaio del 99 all’aeroporto di Zurigo, credetti di aver sbagliato persona. Dopo aver letto i suoi reportage, me l’ero immaginato forte come un Indiana Jones. E così, quando vidi sbucare dalla tormenta un omino agitato, dal passo sbilenco e lo sguardo indifeso, per non salutare la persona sbagliata sbirciai la foto sul retro di copertina del libro che avevo con me. Non poteva essere quello, pensai, l’eroe che aveva sfidato l’inverno artico e la malaria dei Tropici, l’uomo che aveva assistito a ventisette rivoluzioni, traversato Africa e Sudamerica in guerra, vissuto il grande gelo della Russia sovietica e il rovente risveglio dell’Islam.
Invece era lui. Ryszard Kapuscinski, l’autore di Ebano capolavoro sulla forza e fragilità del continente africano, scritto in quarant’anni di viaggi, o di Imperium, straordinaria testimonianza vissuta dal di dento del crollo dell’Unione Sovietica. Era lui, l’uomo che aveva fotografato come nessuno la caduta dello Shah di Persia e l’avvento al potere dell’ayatollah Khomeini, il giornalista che era stato capace di entrare nei segreti della corte dell’ultimo imperatore d'Etiopia e di raccontare le storie del greco Erodoto, vecche di due millenni, e di calarle negli eventi del mondo attuale. Kapuscinski, uno dei pochi giornalisti al mondo ancora capace di andare nei luoghi non illuminati dai riflettori, lontano, il più possibile lontandall’informazione-spettacolo.
Diavolo d’un uomo, pensai quando mi fu di fronte nella sala del check-in. dove starà la sua forza? Come avrà fatto, pensai, questo curato di campagna, a tornare con i taccuini pieni di storie dai luoghi più difficili del Pianeta? Sul volo da Zurigo a Milano m’accorsi che ringraziava le hostess per ogni nonnulla. "La nostra professione dipende dagli altri," sorrideva quasi per escusarsi della sua gentilezza. "Se non hai rispetto per gli altri, ti si chiudono tutte le porte." Era euforico, non mostrava di avere diecimila ore di volo alle spalle. Era geneticamente incapace di criticare una persona. In Polonia girava voce che persino di fronte alla domanda "Cosa pensa di Hitler?" avesse risposto con un memorabile: "Non era una brava persona".
Lo rividi tre volte a Varsavia, camminammo nella neve del Ghetto che non c’era più, parlammo a lungo nella sua mansarda piena di libri dove ogni parete corrispondeva a un continente. Poi, a novembre dello scorso anno, fu la sua ultima visita in Italia, e lo accompagnai sull’altopiano di Renon, sopra Bolzano, a visitare la piccola casa fin-de-siècle di Bronislaw Malinowski, l’antropologo polacco che aveva viaggiato in Oceania, gettato le basi del reportage. Kapuscinski aveva chiesto di vederla perché, raccontava, aveva deciso di ripercorrere la sua strada verso il Pacifico. L’Oceano era l’ultimo sogno, l’orizzonte mancante. La voglia di tagliare i ponti ancora una volta. Lontano, agli antipodi, in mari dove nessuno lo conosceva, dove non aveva conferenze da tenere, libri da firmare.
Si sporse sulla forra dell’Isarco, guardò il fiume gonfio ottocento metri più in basso. Stava in piedi sotto il cielo grigio, su un prato che declinava come una pista per deltaplani. Era stupito dalle nubi che andavano verso oriente, regolari come un fiume, e creavano sull’altopiano l’effetto ottico di un’isola che si muoveva nella direzione opposta. Uno zatterone che andava, con a bordo case, uomini e animali, tra gli iceberg delle Grandi Alpi. Osservava tutto con attenzione, vedeva cose che gli altri non notavano. Era felice, lontano dall’ufficialità e dalla fama. La sentiva come una prigione.
Prati, foglie rosse, meli e castagni, una minuscola chiesa dedicata alla Madonna della Neve. Sullo sfondo, casette anni venti e panorama svizzero. Intorno, ombre di uomini illustri Mahler, Kafka, Freud venuti a riposare da queste parti. Ma i panorami, disse, non erano fatti per scrivere. La bellezza distraeva. "Per scrivere bisogna chiudersi in una cella, come i monaci. Niente panorami. Bisogna restare senza distrazioni, soli con la memoria. Cervantes scrisse Don Chisciotte in galera, no? Io mi limito a barricarmi nella mia mansarda di Varsavia."
Scendemmo a piedi verso la fattoria Seberg, per incontrare degli studenti trentini che avevano lavorato un anno sui suoi libri. Il Maestro era felice, adorava stare fra i giovani, lontano dalle telecamere. Costruì il suo cenacolo attorno alla stufa, fece personalmente i complimenti alla cuoca, mentre dalla cucina già arriva la zuppa e due contadini con la faccia alla Peter Brueghel si accomodarono nel bovindo. Tutti erano incantati dalla semplicità delle sue domande, dalla curiosità infantile, dalla totale assenza di cinismo, dallo stupore continuo.
Disse ai ragazzi: "In tanti mi chiedono interviste. Io rispondo: su cosa?’ E loro mi dicono: qualsiasi cosa’. Ecco, vedete, allora m’arrabbio. Io non sono un animale esotico, non voglio essere dato in pasto alla gente; il pubblico ha diritto a essere informato. E io sono al servizio della gente". Si informava sui ragazzi, li bersagliava di domande sui loro sogni, soprattutto li esortava a stare tra i poveri. Disse: "Non potete ignorarli, se volete fare questo mestiere. I poveri sono l’ottanta per cento del pianeta. I più sfortunati sono i bambini. Ricchi, supernutriti e annoiati da una parte. Sofferenti e infelici dall’altra. Di tutte le porcherie del mondo, questa è ingiustizia che mi offende di più."
Quando arrivarono gli knödel e i crauti, lui, che aveva lo stomaco rovinato da decenni di nomadismo, mandò giù ugualmente la sua razione. "Dovete mangiare con la gente che descrivete. Fare la fame con loro. Immedesimarvi all’estremo. Condividere tutto. Anche in Africa, dove non c’è nulla, dove la natura è un tiranno che ti schianta. E’ il segreto del reportage". Non si capiva se parlasse di sé o di un missionario. "In Africa confessò - non telefonavo mai a casa, non volevo diventare un outsider."
Lentamente, svelava la sua forza. Era quella di un "insider", un grande infiltrato. Andammo a camminare, il sole autunnale impregnava Renon di luce albicocca. Una studentessa mi disse all’orecchio: "ci renderemo conto solo fra vent’anni della cosa enorme che stiamo vivendo ora". Lui camminava e raccontava: "Bach fece a piedi tutta la Germania per incontrare il suo maestro. Erodoto camminò seimila chilometri per verificare un solo dettaglio del suo racconto. Oggi nessuno fa niente del genere. Perché? C’è un vuoto, anche voi ragazzi lo sentite. Avete Internet? Vero. Ma non vi basta, perché sapete benissimo di essere manipolati. Allora, ecco, venite a cercare un vecchio arnese come me. Avete bisogno di un testimone diretto del tempo."
Osservava ogni cosa. Il deposito delle mele a seccare, i sacchi di castagne appena raccolte, persino il letame. Ryzsard si muoveva con circospezione, aveva un modo guardingo di impolverare le scarpe; sembrava sempre un contadino col suo primo paio. Ricordai i suoi sandali indossati a casa, i suoi scarponcini a mollo nella neve fra i tram di Varsavia con le luci rosse lampeggianti, i piccoli passi tra la folla a racimolare dettagli sulla vita di strada, i chioschi di fiori, il mercato ortofrutticolo. "A venticinque anni ne comprai il primo paio" raccontò. "Da bambino a Pinsk avevamo solo sandali di corteccia intrecciata."
Le scarpe! Il piacere di metterne di buone, di costruirci sopra un mestiere lungo migliaia di chilometri; un sogno che parte dalla terra natale, il labirinto d’acque di nome Polesie, in bilico tra Bielorussia e Ucraina. La voglia di tornare a piedi a quel mondo perduto, darne testimonianza "per evitare che sparisca dalla memoria". La regione più povera d’Europa, fatta di marcite, fiumi, villaggi raggiungibili solo via acqua. "Vivevamo di pesce, funghi, bacche. Ma eravamo una grande comunità, fatta di lituani, ebrei, polacchi, bielorussi, tedeschi, tartari. È stato lì che ho imparato a capire l’Altro e a rapportarmi con gli Ultimi."
Tornammo a valle, l’auto scendeva sulla strada del Brennero, l’antico imbuto degli eserciti e delle mercanzie. Guardava dal finestrino, apriva continuamente il notes a spirale, scriveva Dio solo sa cosa. Gli chiesi se non si sarebbe fatto una vacanza sulle Alpi. "No disse - in ferie dopo un giorno mi annoio." E Varsavia, allora? "Varsavia è solo il luogo dove tirare il fiato e preparare un nuovo viaggio." Insistetti: ma lei avrà pure una sua Itaca. "No. Ulisse vagava, ma aveva un sogno: tornare. Io non posso. Sono condannato a errare. Non ho una tana. Faccio un mestiere logorante; non si vive a lungo, se lo si fa sul serio. Bisognerebbe fermarsi presto, come i piloti di linea, il problema è che non riesci a staccare."
Andammo a cena dall’amico Francesco Comina oltre il Talvera, che divideva le due Bolzano italiana e tedesca un po’ come la Neretva spacca le due Mostar. A tavola c’era buon vino rosso e buona musica, dalla finestra aperta arriva il rumore italianissimo delle stoviglie delle case vicine. La Bolzano tedesca pareva lontanissima. Sopra il cortile, il nero profilo della montagne sarentine, con le luci dei masi alti e, più in su, le stelle. Tornammo a piedi oltre il fiume. C’era un ubriaco steso in mezzo al ponte. Il Maestro era stanco, si appoggiò alla balaustra. Le ultime notizie parlavano di un attentato alle truppe americane in Iraq, ma a lui la cronaca non importava. Si guardò le scarpe, sorrise inquieto. "Erodoto sapeva quello che gli americani in Medio Oriente si ostinano a non voler capire. Sapeva che lì non esiste una linea del fronte. Sapeva che quelle genti sapevano solo colpire e scappare. Duemila anni fa l’armata di Dario imperatore credette di poter sconfiggere gli sciti, ma si trovò davanti all’immensità della steppa, solo col suo esercito inutile, davanti a un nemico imprendibile. Bush non ne ha ancora preso atto". Ce ne andammo piano, nella notte senza luna.
Eppure era fragile. Al primo incontro con lui, nel gennaio del 99 all’aeroporto di Zurigo, credetti di aver sbagliato persona. Dopo aver letto i suoi reportage, me l’ero immaginato forte come un Indiana Jones. E così, quando vidi sbucare dalla tormenta un omino agitato, dal passo sbilenco e lo sguardo indifeso, per non salutare la persona sbagliata sbirciai la foto sul retro di copertina del libro che avevo con me. Non poteva essere quello, pensai, l’eroe che aveva sfidato l’inverno artico e la malaria dei Tropici, l’uomo che aveva assistito a ventisette rivoluzioni, traversato Africa e Sudamerica in guerra, vissuto il grande gelo della Russia sovietica e il rovente risveglio dell’Islam.
Invece era lui. Ryszard Kapuscinski, l’autore di Ebano capolavoro sulla forza e fragilità del continente africano, scritto in quarant’anni di viaggi, o di Imperium, straordinaria testimonianza vissuta dal di dento del crollo dell’Unione Sovietica. Era lui, l’uomo che aveva fotografato come nessuno la caduta dello Shah di Persia e l’avvento al potere dell’ayatollah Khomeini, il giornalista che era stato capace di entrare nei segreti della corte dell’ultimo imperatore d'Etiopia e di raccontare le storie del greco Erodoto, vecche di due millenni, e di calarle negli eventi del mondo attuale. Kapuscinski, uno dei pochi giornalisti al mondo ancora capace di andare nei luoghi non illuminati dai riflettori, lontano, il più possibile lontandall’informazione-spettacolo.
Diavolo d’un uomo, pensai quando mi fu di fronte nella sala del check-in. dove starà la sua forza? Come avrà fatto, pensai, questo curato di campagna, a tornare con i taccuini pieni di storie dai luoghi più difficili del Pianeta? Sul volo da Zurigo a Milano m’accorsi che ringraziava le hostess per ogni nonnulla. "La nostra professione dipende dagli altri," sorrideva quasi per escusarsi della sua gentilezza. "Se non hai rispetto per gli altri, ti si chiudono tutte le porte." Era euforico, non mostrava di avere diecimila ore di volo alle spalle. Era geneticamente incapace di criticare una persona. In Polonia girava voce che persino di fronte alla domanda "Cosa pensa di Hitler?" avesse risposto con un memorabile: "Non era una brava persona".
Lo rividi tre volte a Varsavia, camminammo nella neve del Ghetto che non c’era più, parlammo a lungo nella sua mansarda piena di libri dove ogni parete corrispondeva a un continente. Poi, a novembre dello scorso anno, fu la sua ultima visita in Italia, e lo accompagnai sull’altopiano di Renon, sopra Bolzano, a visitare la piccola casa fin-de-siècle di Bronislaw Malinowski, l’antropologo polacco che aveva viaggiato in Oceania, gettato le basi del reportage. Kapuscinski aveva chiesto di vederla perché, raccontava, aveva deciso di ripercorrere la sua strada verso il Pacifico. L’Oceano era l’ultimo sogno, l’orizzonte mancante. La voglia di tagliare i ponti ancora una volta. Lontano, agli antipodi, in mari dove nessuno lo conosceva, dove non aveva conferenze da tenere, libri da firmare.
Si sporse sulla forra dell’Isarco, guardò il fiume gonfio ottocento metri più in basso. Stava in piedi sotto il cielo grigio, su un prato che declinava come una pista per deltaplani. Era stupito dalle nubi che andavano verso oriente, regolari come un fiume, e creavano sull’altopiano l’effetto ottico di un’isola che si muoveva nella direzione opposta. Uno zatterone che andava, con a bordo case, uomini e animali, tra gli iceberg delle Grandi Alpi. Osservava tutto con attenzione, vedeva cose che gli altri non notavano. Era felice, lontano dall’ufficialità e dalla fama. La sentiva come una prigione.
Prati, foglie rosse, meli e castagni, una minuscola chiesa dedicata alla Madonna della Neve. Sullo sfondo, casette anni venti e panorama svizzero. Intorno, ombre di uomini illustri Mahler, Kafka, Freud venuti a riposare da queste parti. Ma i panorami, disse, non erano fatti per scrivere. La bellezza distraeva. "Per scrivere bisogna chiudersi in una cella, come i monaci. Niente panorami. Bisogna restare senza distrazioni, soli con la memoria. Cervantes scrisse Don Chisciotte in galera, no? Io mi limito a barricarmi nella mia mansarda di Varsavia."
Scendemmo a piedi verso la fattoria Seberg, per incontrare degli studenti trentini che avevano lavorato un anno sui suoi libri. Il Maestro era felice, adorava stare fra i giovani, lontano dalle telecamere. Costruì il suo cenacolo attorno alla stufa, fece personalmente i complimenti alla cuoca, mentre dalla cucina già arriva la zuppa e due contadini con la faccia alla Peter Brueghel si accomodarono nel bovindo. Tutti erano incantati dalla semplicità delle sue domande, dalla curiosità infantile, dalla totale assenza di cinismo, dallo stupore continuo.
Disse ai ragazzi: "In tanti mi chiedono interviste. Io rispondo: su cosa?’ E loro mi dicono: qualsiasi cosa’. Ecco, vedete, allora m’arrabbio. Io non sono un animale esotico, non voglio essere dato in pasto alla gente; il pubblico ha diritto a essere informato. E io sono al servizio della gente". Si informava sui ragazzi, li bersagliava di domande sui loro sogni, soprattutto li esortava a stare tra i poveri. Disse: "Non potete ignorarli, se volete fare questo mestiere. I poveri sono l’ottanta per cento del pianeta. I più sfortunati sono i bambini. Ricchi, supernutriti e annoiati da una parte. Sofferenti e infelici dall’altra. Di tutte le porcherie del mondo, questa è ingiustizia che mi offende di più."
Quando arrivarono gli knödel e i crauti, lui, che aveva lo stomaco rovinato da decenni di nomadismo, mandò giù ugualmente la sua razione. "Dovete mangiare con la gente che descrivete. Fare la fame con loro. Immedesimarvi all’estremo. Condividere tutto. Anche in Africa, dove non c’è nulla, dove la natura è un tiranno che ti schianta. E’ il segreto del reportage". Non si capiva se parlasse di sé o di un missionario. "In Africa confessò - non telefonavo mai a casa, non volevo diventare un outsider."
Lentamente, svelava la sua forza. Era quella di un "insider", un grande infiltrato. Andammo a camminare, il sole autunnale impregnava Renon di luce albicocca. Una studentessa mi disse all’orecchio: "ci renderemo conto solo fra vent’anni della cosa enorme che stiamo vivendo ora". Lui camminava e raccontava: "Bach fece a piedi tutta la Germania per incontrare il suo maestro. Erodoto camminò seimila chilometri per verificare un solo dettaglio del suo racconto. Oggi nessuno fa niente del genere. Perché? C’è un vuoto, anche voi ragazzi lo sentite. Avete Internet? Vero. Ma non vi basta, perché sapete benissimo di essere manipolati. Allora, ecco, venite a cercare un vecchio arnese come me. Avete bisogno di un testimone diretto del tempo."
Osservava ogni cosa. Il deposito delle mele a seccare, i sacchi di castagne appena raccolte, persino il letame. Ryzsard si muoveva con circospezione, aveva un modo guardingo di impolverare le scarpe; sembrava sempre un contadino col suo primo paio. Ricordai i suoi sandali indossati a casa, i suoi scarponcini a mollo nella neve fra i tram di Varsavia con le luci rosse lampeggianti, i piccoli passi tra la folla a racimolare dettagli sulla vita di strada, i chioschi di fiori, il mercato ortofrutticolo. "A venticinque anni ne comprai il primo paio" raccontò. "Da bambino a Pinsk avevamo solo sandali di corteccia intrecciata."
Le scarpe! Il piacere di metterne di buone, di costruirci sopra un mestiere lungo migliaia di chilometri; un sogno che parte dalla terra natale, il labirinto d’acque di nome Polesie, in bilico tra Bielorussia e Ucraina. La voglia di tornare a piedi a quel mondo perduto, darne testimonianza "per evitare che sparisca dalla memoria". La regione più povera d’Europa, fatta di marcite, fiumi, villaggi raggiungibili solo via acqua. "Vivevamo di pesce, funghi, bacche. Ma eravamo una grande comunità, fatta di lituani, ebrei, polacchi, bielorussi, tedeschi, tartari. È stato lì che ho imparato a capire l’Altro e a rapportarmi con gli Ultimi."
Tornammo a valle, l’auto scendeva sulla strada del Brennero, l’antico imbuto degli eserciti e delle mercanzie. Guardava dal finestrino, apriva continuamente il notes a spirale, scriveva Dio solo sa cosa. Gli chiesi se non si sarebbe fatto una vacanza sulle Alpi. "No disse - in ferie dopo un giorno mi annoio." E Varsavia, allora? "Varsavia è solo il luogo dove tirare il fiato e preparare un nuovo viaggio." Insistetti: ma lei avrà pure una sua Itaca. "No. Ulisse vagava, ma aveva un sogno: tornare. Io non posso. Sono condannato a errare. Non ho una tana. Faccio un mestiere logorante; non si vive a lungo, se lo si fa sul serio. Bisognerebbe fermarsi presto, come i piloti di linea, il problema è che non riesci a staccare."
Andammo a cena dall’amico Francesco Comina oltre il Talvera, che divideva le due Bolzano italiana e tedesca un po’ come la Neretva spacca le due Mostar. A tavola c’era buon vino rosso e buona musica, dalla finestra aperta arriva il rumore italianissimo delle stoviglie delle case vicine. La Bolzano tedesca pareva lontanissima. Sopra il cortile, il nero profilo della montagne sarentine, con le luci dei masi alti e, più in su, le stelle. Tornammo a piedi oltre il fiume. C’era un ubriaco steso in mezzo al ponte. Il Maestro era stanco, si appoggiò alla balaustra. Le ultime notizie parlavano di un attentato alle truppe americane in Iraq, ma a lui la cronaca non importava. Si guardò le scarpe, sorrise inquieto. "Erodoto sapeva quello che gli americani in Medio Oriente si ostinano a non voler capire. Sapeva che lì non esiste una linea del fronte. Sapeva che quelle genti sapevano solo colpire e scappare. Duemila anni fa l’armata di Dario imperatore credette di poter sconfiggere gli sciti, ma si trovò davanti all’immensità della steppa, solo col suo esercito inutile, davanti a un nemico imprendibile. Bush non ne ha ancora preso atto". Ce ne andammo piano, nella notte senza luna.
Paolo Rumiz
Paolo Rumiz, triestino, è scrittore e viaggiatore. Con Feltrinelli ha pubblicato La secessione leggera (2001), Tre uomini in bicicletta (con Francesco Altan; 2002), È Oriente (2003), La leggenda dei monti …