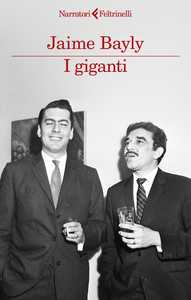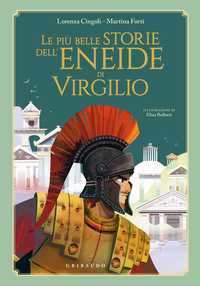Stefano Rodotà: Il pericolo del mercato degli ovuli
22 Febbraio 2007
Non sorprende che il Governo britannico voglia consentire alle donne di vendere i loro ovuli per finalità di ricerca. Infatti, proprio per sfuggire anche alle regole sul divieto di trarre profitto dal corpo e dalle sue parti, non aveva firmato la Convenzione europea di biomedicina e rimane ostile ad altri documenti internazionali che vanno nella stessa direzione. La ragione è chiara. Scelta la via del mercato puro e duro, deve essere eliminato ogni ostacolo sulla via di una industria biotecnologica il più possibile efficiente e competitiva.
Le reazioni sono state immediate, così come le difese dell’orientamento annunciato. Si richiamano i benefici per la ricerca, si sottolinea la moralità di un provvedimento che metterebbe fine all’ipocrisia di una situazione in cui la vendita viene praticata sottobanco. Sullo sfondo, ma già percepibile, si coglie l’argomento di chi ricorda come sia proprio il mercato a rendere possibile la migliore allocazione delle risorse, riprendendo le indicazioni che gli studiosi dell’analisi economica del diritto hanno sviluppato ampiamente per sostenere l’ammissibilità della vendita degli organi. Ma la logica economica, e la stessa libertà di ricerca, devono fare i conti con il fatto che qui sono implicati il corpo e la stessa vita. Possiamo accettare il principio che, anche in queste materie, vuole che la guida sia soltanto quella offerta dal mercato? O uno dei grandi interrogativi del nostro tempo non è proprio quello che riguarda ciò che può stare e ciò che non deve stare nel mercato?
Risposte chiare sono già venute da molti documenti internazionali e da leggi nazionali. Nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’articolo 3, si trova un esplicito "divieto di fare del corpo umano e delle sue parti, in quanto tali, una fonte di lucro". Formula, questa, che riprende e conferma quel che già era scritto nella Convenzione sulla biomedicina e nella Dichiarazione universale sul genoma umano, e che viene esplicitamente fatta discendere dalla necessità di rispettare la dignità della persona, dichiarata "inviolabile" dal primo articolo della Carta dei diritti fondamentali.
L’importanza di questi principi si coglie in modo più netto se si considerano le situazioni concrete e le esperienze dei luoghi dove già sono ammesse forme di commercializzazione del corpo. Chi è disposto a vendere? Chi si trova in situazioni di difficoltà economica. Non è certo un caso che, nell’area europea, l’unico paese che consente la commercializzazione degli organi sia il più povero, la Moldavia. Diventa così chiara la conseguenza principale dell’ammissibilità del commercio del corpo, delle sue parti, dei suoi prodotti. La nascita di una nuova forma di società castale, di una nuova stratificazione di produttori e consumatori, dove i più ricchi (singole persone, società farmaceutiche, centri di ricerca) comprano pezzi del corpo dei più poveri. Mai ho dato troppo credito alle narrazioni riguardanti persone trovate morte e private di alcuni organi, reni in particolare. Ma è storia ben provata quella di costose cliniche dove è possibile approvvigionarsi di organi venduti da poveri turchi o pachistani. Ed i cataloghi statunitensi di ragazze pronte a vendere i loro ovuli o a dare il loro "utero in affitto", compilati nel paese più ricco del mondo e rinvenibili anche su Internet, lasciano intravedere storie di difficoltà personali, debolezze culturali. Non a caso, e non a sproposito, si è parlato di una "cannibalizzazione" tecnologica, che attraversa il mondo e che non solo crea nuove forme di dominio dell’uomo sull’uomo, ma determina una radicale riduzione a merce del corpo dei più deboli. E’ una rappresentazione intimidatrice, truculenta? O è piuttosto la fedele descrizione di quel che può accadere in una organizzazione sociale quando il mercato pretende di penetrare in ogni sua piega, di sottomettere alla sua regola ogni momento della vita?
Si obietta. Quei divieti sono l’espressione di un inammissibile paternalismo, addirittura di un autoritarismo che vuole sostituire una regola proibizionista alla libera decisione di ogni persona. Che cosa risponderebbe l’immigrato clandestino al quale si chiedesse se preferisce lavorare in nero e rischiare la vita su ponteggi senza le protezioni necessarie per evitare infortuni mortali o vendere pulitamente un organo, con rischi ridottissimi per la sua integrità fisica, riuscendo così a vivere meglio per un certo periodo, libero dalle immediate angosce economiche? Ma sono proprio queste domande a mostrare che la tutela della libertà e dell’autonomia delle persone non passa attraverso il loro abbandono, obbligandole a "scelte tragiche", in cui il dominio del bisogno è così forte da escludere ogni traccia di consenso libero. Una società davvero rispettosa della dignità e della libertà delle persona deve operare in modo da eliminare gli ostacoli di fatto che impediscono il libero sviluppo della personalità, come vuole la nostra civilissima Costituzione, non rendere i più deboli sempre più prigionieri della loro debolezza. Non liberiamoci dell’ipocrisia dei traffici clandestini con una ipocrisia sociale ancora maggiore.
Non credo che queste siano considerazioni sproporzionate rispetto alla proposta di passare ad un legittimo commercio degli ovuli. Già si è detto che le 250 sterline promesse, non particolarmente allettanti per le donne inglesi, sarebbero invece un incentivo consistente per donne dell’Est europeo: verrebbe così alimentato un perverso turismo, la società castale troverebbe una sua conferma transnazionale. Si sono ricordati i rischi non trascurabili per la salute delle donne. Si deve aggiungere che è una mossa anch’essa ipocrita il subordinare la legittimità della vendita all’esistenza di un fine "puramente altruistico", difficile da definire e ancor più da accertare. E diviene soprattutto evidente come una volta di più siano le donne ad essere oggetto di regole obbliganti, ad essere chiuse in un ruolo subordinato, a vedersi imporre una "contribuzione" sociale, ad essere considerate un contenitore dal quale attingere liberamente.
L’adozione di questo modello avrebbe effetti negativi anche perché rappresenterebbe una indicazione in contrasto con le molte, concrete tendenze verso la costruzione di una dimensione libera dalla pervasività della logica del profitto, non soltanto sottratta alle tirannie dell’utilitarismo, ma all’interno della quale si colgono i benefici segni di una auspicata "rivoluzione della gratuità", che favorisca l’aiuto reciproco, la condivisione, la cooperazione, dunque una opportunità continua di donare. Parole come "software libero", "open source", "no copyright" percorrono il mondo e, se pure è eccessivo dire che esse annunciano una "gift economy", una economia del dono, certamente ci indicano una strada seguendo la quale si espandono opportunità di ricerca e di conoscenza non più confinate negli interstizi di una società che elegge il calcolo economico ad unica "legge di natura", ma arricchite dalla solidarietà sociale. Se davvero si vuol dare rilevanza all’intento generoso delle donne, alla loro attitudine a stabilire relazioni con il mondo anche attraverso il loro corpo, è a questa attitudine che bisogna fare riferimento, rendendole libere protagoniste di un nuovo corso sociale, non eterne prigioniere di logiche di scambio.
Le reazioni sono state immediate, così come le difese dell’orientamento annunciato. Si richiamano i benefici per la ricerca, si sottolinea la moralità di un provvedimento che metterebbe fine all’ipocrisia di una situazione in cui la vendita viene praticata sottobanco. Sullo sfondo, ma già percepibile, si coglie l’argomento di chi ricorda come sia proprio il mercato a rendere possibile la migliore allocazione delle risorse, riprendendo le indicazioni che gli studiosi dell’analisi economica del diritto hanno sviluppato ampiamente per sostenere l’ammissibilità della vendita degli organi. Ma la logica economica, e la stessa libertà di ricerca, devono fare i conti con il fatto che qui sono implicati il corpo e la stessa vita. Possiamo accettare il principio che, anche in queste materie, vuole che la guida sia soltanto quella offerta dal mercato? O uno dei grandi interrogativi del nostro tempo non è proprio quello che riguarda ciò che può stare e ciò che non deve stare nel mercato?
Risposte chiare sono già venute da molti documenti internazionali e da leggi nazionali. Nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’articolo 3, si trova un esplicito "divieto di fare del corpo umano e delle sue parti, in quanto tali, una fonte di lucro". Formula, questa, che riprende e conferma quel che già era scritto nella Convenzione sulla biomedicina e nella Dichiarazione universale sul genoma umano, e che viene esplicitamente fatta discendere dalla necessità di rispettare la dignità della persona, dichiarata "inviolabile" dal primo articolo della Carta dei diritti fondamentali.
L’importanza di questi principi si coglie in modo più netto se si considerano le situazioni concrete e le esperienze dei luoghi dove già sono ammesse forme di commercializzazione del corpo. Chi è disposto a vendere? Chi si trova in situazioni di difficoltà economica. Non è certo un caso che, nell’area europea, l’unico paese che consente la commercializzazione degli organi sia il più povero, la Moldavia. Diventa così chiara la conseguenza principale dell’ammissibilità del commercio del corpo, delle sue parti, dei suoi prodotti. La nascita di una nuova forma di società castale, di una nuova stratificazione di produttori e consumatori, dove i più ricchi (singole persone, società farmaceutiche, centri di ricerca) comprano pezzi del corpo dei più poveri. Mai ho dato troppo credito alle narrazioni riguardanti persone trovate morte e private di alcuni organi, reni in particolare. Ma è storia ben provata quella di costose cliniche dove è possibile approvvigionarsi di organi venduti da poveri turchi o pachistani. Ed i cataloghi statunitensi di ragazze pronte a vendere i loro ovuli o a dare il loro "utero in affitto", compilati nel paese più ricco del mondo e rinvenibili anche su Internet, lasciano intravedere storie di difficoltà personali, debolezze culturali. Non a caso, e non a sproposito, si è parlato di una "cannibalizzazione" tecnologica, che attraversa il mondo e che non solo crea nuove forme di dominio dell’uomo sull’uomo, ma determina una radicale riduzione a merce del corpo dei più deboli. E’ una rappresentazione intimidatrice, truculenta? O è piuttosto la fedele descrizione di quel che può accadere in una organizzazione sociale quando il mercato pretende di penetrare in ogni sua piega, di sottomettere alla sua regola ogni momento della vita?
Si obietta. Quei divieti sono l’espressione di un inammissibile paternalismo, addirittura di un autoritarismo che vuole sostituire una regola proibizionista alla libera decisione di ogni persona. Che cosa risponderebbe l’immigrato clandestino al quale si chiedesse se preferisce lavorare in nero e rischiare la vita su ponteggi senza le protezioni necessarie per evitare infortuni mortali o vendere pulitamente un organo, con rischi ridottissimi per la sua integrità fisica, riuscendo così a vivere meglio per un certo periodo, libero dalle immediate angosce economiche? Ma sono proprio queste domande a mostrare che la tutela della libertà e dell’autonomia delle persone non passa attraverso il loro abbandono, obbligandole a "scelte tragiche", in cui il dominio del bisogno è così forte da escludere ogni traccia di consenso libero. Una società davvero rispettosa della dignità e della libertà delle persona deve operare in modo da eliminare gli ostacoli di fatto che impediscono il libero sviluppo della personalità, come vuole la nostra civilissima Costituzione, non rendere i più deboli sempre più prigionieri della loro debolezza. Non liberiamoci dell’ipocrisia dei traffici clandestini con una ipocrisia sociale ancora maggiore.
Non credo che queste siano considerazioni sproporzionate rispetto alla proposta di passare ad un legittimo commercio degli ovuli. Già si è detto che le 250 sterline promesse, non particolarmente allettanti per le donne inglesi, sarebbero invece un incentivo consistente per donne dell’Est europeo: verrebbe così alimentato un perverso turismo, la società castale troverebbe una sua conferma transnazionale. Si sono ricordati i rischi non trascurabili per la salute delle donne. Si deve aggiungere che è una mossa anch’essa ipocrita il subordinare la legittimità della vendita all’esistenza di un fine "puramente altruistico", difficile da definire e ancor più da accertare. E diviene soprattutto evidente come una volta di più siano le donne ad essere oggetto di regole obbliganti, ad essere chiuse in un ruolo subordinato, a vedersi imporre una "contribuzione" sociale, ad essere considerate un contenitore dal quale attingere liberamente.
L’adozione di questo modello avrebbe effetti negativi anche perché rappresenterebbe una indicazione in contrasto con le molte, concrete tendenze verso la costruzione di una dimensione libera dalla pervasività della logica del profitto, non soltanto sottratta alle tirannie dell’utilitarismo, ma all’interno della quale si colgono i benefici segni di una auspicata "rivoluzione della gratuità", che favorisca l’aiuto reciproco, la condivisione, la cooperazione, dunque una opportunità continua di donare. Parole come "software libero", "open source", "no copyright" percorrono il mondo e, se pure è eccessivo dire che esse annunciano una "gift economy", una economia del dono, certamente ci indicano una strada seguendo la quale si espandono opportunità di ricerca e di conoscenza non più confinate negli interstizi di una società che elegge il calcolo economico ad unica "legge di natura", ma arricchite dalla solidarietà sociale. Se davvero si vuol dare rilevanza all’intento generoso delle donne, alla loro attitudine a stabilire relazioni con il mondo anche attraverso il loro corpo, è a questa attitudine che bisogna fare riferimento, rendendole libere protagoniste di un nuovo corso sociale, non eterne prigioniere di logiche di scambio.
Stefano Rodotà
Stefano Rodotà (1933-2017) è stato professore emerito di Diritto civile all’Università di Roma “La Sapienza”. Ha insegnato in molte università straniere ed è stato parlamentare in Italia e in Europa. …