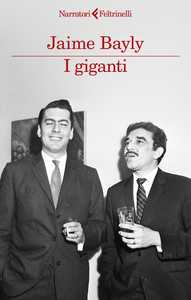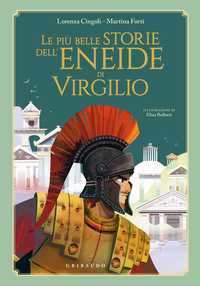Erri De Luca: Sul treno il Novecento in libertà
03 Agosto 2007
Un posto di sinistra? Mi viene in mente il treno. Coincise con la libertà portandomi lontano. Non poteva essere una nave, che aveva imbarcato i nostri emigranti dal molo Beverello del porto di Napoli. Il mondo largo e tondo se li era inghiottiti senza restituzione. A bordo dei bastimenti non viaggiava la libertà, ma i prigionieri della necessità. Andavano a cercare di levarsi lo scorno della fame dall'altra parte di un oceano. La nave non mi metteva pensieri di aria aperta, ma di stiva e di separazioni irreparabili.
Il treno invece, quello sì, prometteva fortuna a ogni stazione, gente nuova saliva, saluti, conversazioni, ci si presentava, e se qualcuno aveva di che masticare, ‟favorite” era l'invito e pure un mezzo comando, altrimenti era offesa rifiutare. Il treno era l'Italia: prima classe impettita e ingrugnita per il troppo modesto privilegio di una sola classe di distanza dall'altra. Per loro ci voleva che dopo la prima la successiva non si chiamasse seconda, così vicina nella graduatoria. Per loro ci voleva che dopo la prima si passasse direttamente all'ultima - biglietti di prima classe e biglietti di ultima: così si suonava meglio la distanza. Per i viaggiatori di seconda la distanza era quella da percorrere in chilometri. Quelli di prima viaggiavano invece per mantenere la distanza. Tutto di loro, dai vestiti ai modi, badava ad aumentarla. L'ho capita sul treno la borghesia. Oggi non si conosce più, oggi nemmeno esiste sugli aerei dove la differenza tra prima classe e l'altra è a stento una sfumatura, una tendina. Oggi non c'è la borghesia, al suo posto c'è invece l'indistinta uguaglianza degli utenti. Chi non lo è, non risulta.
‟Favorite”, e si accettava una fetta di pane inumidita da pomodoro e olio, un pezzo di frittata, un salame tagliato sul tovagliolo steso sulle gambe. E un sorso di vino versato dai bottiglioni verdi da due litri: era la classe, né l'ultima né prima, la classe pura, stile del viaggiare italiano.
‟Voi dove andate, giovinotto?”
‟Io scappo da casa”.
‟Fate male. E per dove?”
‟Dove non ci sta casa”.
‟Sotto i ponti?”
Un altro interveniva: ‟a Napoli non ce ne stanno, manca il fiume”.
‟Ve li andate a cercare dove stanno. Chi la capisce questa gioventù? Il biglietto lo tenete? Se no vi fanno scendere”.
‟Lo tengo, grazie, la partenza è pagata. Il resto si vedrà”.
E subito si passava a un'altra storia. Si stava in otto nello scompartimento, hai voglia a sentire racconti e interventi sopra i racconti.
Me l'ero immaginato diverso. Avevo letto ‟Sulla strada” di Kerouac, i treni saliti al volo nei carri bestiame vuoti, a marcia lenta, sperduti in mezzo all'ovest sconfinato. Erano i carri merci della libertà, portavano spiantati e vagabondi a zonzo tra l'Atlantico e il Pacifico. Sapevo che da noi c'erano quei treni, ma com'erano invece? Da noi erano Italia che si trasferiva sud/nord e poi tornava per Natale, per qualche ricorrenza elettorale. Da noi si votava spesso. I treni erano di sinistra perché congiungevano. Le navi no, separavano, erano l'addio pe' terre assai luntane. I treni erano sempre pronti.
Uno che teneva nostalgia (la nostalgia è una cosa che si tiene e ci vuole il verbo tenere), magari faceva l'operaio a Torino, la domenica andava alla stazione. Vedeva i vagoni appena arrivati dalla sua città, dal paese. Vedeva facce quasi conosciute, sentiva la parlata, dava un'informazione a uno appena sceso e spaesato, gli veniva il pensiero amaro e dispettoso di salire sul treno e farsi riportare.
La stazione di Porta Nuova la domenica era consolazione per sfogare la nostalgia e vedere che si stava in tanti con quel pensiero. Faceva bene sapere quanti e quanti, assomigliati senza poterlo sapere. Nelle officine uno non si accorge, sta al macchinario e sa degli altri solo al varco dei cancelli. A mensa metti gli occhi nel piatto, hai solo mezz'ora.
Poi è venuta la lotta di fabbrica, alla fine degli anni sessanta, è venuto il '69. I cortei di operai nelle officine erano belli perché facevano smettere il chiasso dei macchinari in produzione e lo sostituivano col ritmo della pausa suonata a tamburo sui bidoni vuoti. La lotta era un'interruzione generale, un sollievo da baciarsi i gomiti per l'allegria. Poi dava pure dignità, i capi di officina, i controllori portavano rispetto e tenevano un poco di paura (la paura è una cosa che si tiene e ci vuole il verbo tenere).
Uno si accorgeva che gli era servito andare alla stazione di domenica, perché i cortei dentro le officine somigliavano ai treni. Senza la divisione tra prima e seconda, era una sola classe in marcia e l'altra ferma. La distanza tra loro si accorciava.
I treni erano a somiglianza e immagine della libertà. Perciò i nemici, quelli che preferivano le tirannie e le dittature, da noi se la sono presa coi treni. Li hanno bombardati con la gente dentro, sotto natale e sotto ferragosto per fare più male, pure nella stazione hanno fatto spargimento di sangue. E sono rimasti impuniti, perché stavano in combutta con altri malfattori dentro le forze pubbliche, i servizi. Bei servizi hanno reso, il migliore se lo sono procurato con la impunità delle stragi.
I treni hanno fatto l'unità d'Italia più delle scaramucce di tre piccole guerre d'indipendenza, più di un portone sfondato a Porta Pia. I treni ci hanno fatto conoscere italiani divisi dalla meravigliosa specie di dialetti. Prima di scendere alle stazioni, salutarsi, ci si scambiava l'indirizzo e almeno una cartolina di saluto arrivava a ricordo dell'incontro. L'Italia è stata unita dagli scompartimenti della seconda classe e la parola d'ordine e intesa, dopo i saluti e le presentazioni era una per tutti: ‟favorite”.
Il treno invece, quello sì, prometteva fortuna a ogni stazione, gente nuova saliva, saluti, conversazioni, ci si presentava, e se qualcuno aveva di che masticare, ‟favorite” era l'invito e pure un mezzo comando, altrimenti era offesa rifiutare. Il treno era l'Italia: prima classe impettita e ingrugnita per il troppo modesto privilegio di una sola classe di distanza dall'altra. Per loro ci voleva che dopo la prima la successiva non si chiamasse seconda, così vicina nella graduatoria. Per loro ci voleva che dopo la prima si passasse direttamente all'ultima - biglietti di prima classe e biglietti di ultima: così si suonava meglio la distanza. Per i viaggiatori di seconda la distanza era quella da percorrere in chilometri. Quelli di prima viaggiavano invece per mantenere la distanza. Tutto di loro, dai vestiti ai modi, badava ad aumentarla. L'ho capita sul treno la borghesia. Oggi non si conosce più, oggi nemmeno esiste sugli aerei dove la differenza tra prima classe e l'altra è a stento una sfumatura, una tendina. Oggi non c'è la borghesia, al suo posto c'è invece l'indistinta uguaglianza degli utenti. Chi non lo è, non risulta.
‟Favorite”, e si accettava una fetta di pane inumidita da pomodoro e olio, un pezzo di frittata, un salame tagliato sul tovagliolo steso sulle gambe. E un sorso di vino versato dai bottiglioni verdi da due litri: era la classe, né l'ultima né prima, la classe pura, stile del viaggiare italiano.
‟Voi dove andate, giovinotto?”
‟Io scappo da casa”.
‟Fate male. E per dove?”
‟Dove non ci sta casa”.
‟Sotto i ponti?”
Un altro interveniva: ‟a Napoli non ce ne stanno, manca il fiume”.
‟Ve li andate a cercare dove stanno. Chi la capisce questa gioventù? Il biglietto lo tenete? Se no vi fanno scendere”.
‟Lo tengo, grazie, la partenza è pagata. Il resto si vedrà”.
E subito si passava a un'altra storia. Si stava in otto nello scompartimento, hai voglia a sentire racconti e interventi sopra i racconti.
Me l'ero immaginato diverso. Avevo letto ‟Sulla strada” di Kerouac, i treni saliti al volo nei carri bestiame vuoti, a marcia lenta, sperduti in mezzo all'ovest sconfinato. Erano i carri merci della libertà, portavano spiantati e vagabondi a zonzo tra l'Atlantico e il Pacifico. Sapevo che da noi c'erano quei treni, ma com'erano invece? Da noi erano Italia che si trasferiva sud/nord e poi tornava per Natale, per qualche ricorrenza elettorale. Da noi si votava spesso. I treni erano di sinistra perché congiungevano. Le navi no, separavano, erano l'addio pe' terre assai luntane. I treni erano sempre pronti.
Uno che teneva nostalgia (la nostalgia è una cosa che si tiene e ci vuole il verbo tenere), magari faceva l'operaio a Torino, la domenica andava alla stazione. Vedeva i vagoni appena arrivati dalla sua città, dal paese. Vedeva facce quasi conosciute, sentiva la parlata, dava un'informazione a uno appena sceso e spaesato, gli veniva il pensiero amaro e dispettoso di salire sul treno e farsi riportare.
La stazione di Porta Nuova la domenica era consolazione per sfogare la nostalgia e vedere che si stava in tanti con quel pensiero. Faceva bene sapere quanti e quanti, assomigliati senza poterlo sapere. Nelle officine uno non si accorge, sta al macchinario e sa degli altri solo al varco dei cancelli. A mensa metti gli occhi nel piatto, hai solo mezz'ora.
Poi è venuta la lotta di fabbrica, alla fine degli anni sessanta, è venuto il '69. I cortei di operai nelle officine erano belli perché facevano smettere il chiasso dei macchinari in produzione e lo sostituivano col ritmo della pausa suonata a tamburo sui bidoni vuoti. La lotta era un'interruzione generale, un sollievo da baciarsi i gomiti per l'allegria. Poi dava pure dignità, i capi di officina, i controllori portavano rispetto e tenevano un poco di paura (la paura è una cosa che si tiene e ci vuole il verbo tenere).
Uno si accorgeva che gli era servito andare alla stazione di domenica, perché i cortei dentro le officine somigliavano ai treni. Senza la divisione tra prima e seconda, era una sola classe in marcia e l'altra ferma. La distanza tra loro si accorciava.
I treni erano a somiglianza e immagine della libertà. Perciò i nemici, quelli che preferivano le tirannie e le dittature, da noi se la sono presa coi treni. Li hanno bombardati con la gente dentro, sotto natale e sotto ferragosto per fare più male, pure nella stazione hanno fatto spargimento di sangue. E sono rimasti impuniti, perché stavano in combutta con altri malfattori dentro le forze pubbliche, i servizi. Bei servizi hanno reso, il migliore se lo sono procurato con la impunità delle stragi.
I treni hanno fatto l'unità d'Italia più delle scaramucce di tre piccole guerre d'indipendenza, più di un portone sfondato a Porta Pia. I treni ci hanno fatto conoscere italiani divisi dalla meravigliosa specie di dialetti. Prima di scendere alle stazioni, salutarsi, ci si scambiava l'indirizzo e almeno una cartolina di saluto arrivava a ricordo dell'incontro. L'Italia è stata unita dagli scompartimenti della seconda classe e la parola d'ordine e intesa, dopo i saluti e le presentazioni era una per tutti: ‟favorite”.
Erri De Luca
Erri De Luca è nato a Napoli nel 1950. Ha pubblicato con Feltrinelli: Non ora, non qui (1989), Una nuvola come tappeto (1991), Aceto, arcobaleno (1992), In alto a sinistra (1994), Alzaia (1997, …