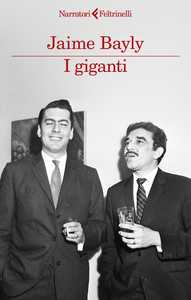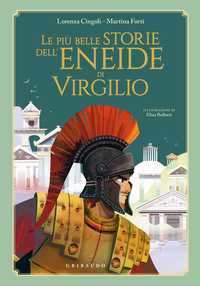Umberto Galimberti: Lanima. Se la chiesa impone la sua verità
02 Ottobre 2007
Un giorno, incontrando a Firenze Padre Ernesto Balducci, di cui avevo letto due suoi splendidi libri: La terra del tramonto e L’uomo planetario (Edizioni Cultura della Pace), ebbi a dirgli: «Se il Cristianesimo fosse come lei lo interpreta, forse sarei un cristiano anch’io». La sua risposta fu lapidaria: «Non stia a credere professore, noi preti, per quanto diverse siano le nostre interpretazioni, siamo tutti sportelli della stessa banca». Ne ho avuto conferma leggendo in questi giorni il bellissimo libro del teologo Vito Mancuso che ha per titolo L’anima e il suo destino (Raffaello Cortina, pagg. 324, euro 19,80). Dico "bellissimo" perché è scritto molto bene e argomentato con logica e rigore; perché non teme di denunciare gli errori, quando non le crudeltà, compiute dalla Chiesa nel corso della sua storia a partire dalla lotta condotta contro la libertà di coscienza in materia religiosa; perché si rivolge ai laici che, quando sono alla ricerca della verità, dice di apprezzare più dei credenti quando sono tali solo per un bisogno di appartenenza; perché mette in questione dogmi fondamentali della Chiesa cattolica come la creazione dell’anima da parte di Dio, il peccato originale, la resurrezione della carne, la dannazione eterna dell’inferno, anche se poi alla fine conclude come papa Ratzinger vuole, quando rivendica la perfetta conciliabilità tra fede cristiana e ragione, e quando afferma che solo nella religione cattolica si esprime la verità. Ma incominciamo dall’anima e dal suo destino immortale che, come ci ricorda Nietzsche, è stato «il colpo di genio del Cristianesimo» perché ha tolto agli uomini il terrore della morte. Io non sono un teologo, ma un filosofo della Storia che segue il metodo "genealogico" di Nietzsche, il quale, a differenza di Platone, non si chiede, ad esempio, «che cos’è l’anima», ma: «Come è venuto al mondo questo concetto, che storia ha avuto, che significati ha assunto, che effetti di realtà ha prodotto?», persuaso come sono che l’essenza di una cosa, il suo senso è nella sua storia. Ebbene, per gli antichi greci che chiamavano l’uomo il "mortale" e le ipotesi di sopravvivenza ultraterrena "cieche speranze (typhlas elpidas)" non c’era un’anima dentro il corpo. Per Omero l’anima è l’occhio che vede, l’orecchio che sente, il cuore che batte, il corpo vivente insomma, che è diverso dal cadavere perché è espressivo e non rappresentativo di un teatro che si svolge alle sue spalle, nell’anima appunto, come noi oggi crediamo. Poi venne Platone che, inaugurando la filosofia, ritenne che non ci si poteva fidare della conoscenza sensibile, quella fornita dai sensi del corpo, perché i corpi sono uno diverso dall’altro, invecchiano, si ammalano, sono soggetti a passioni, si alterano, per cui le informazioni che essi forniscono non sono affidabili per costruire un sapere oggettivo. Fu così che Platone introdusse la parola "anima", in greco psyche, capace di costruire un sapere oggettivo con i soli costrutti matematici e ideali che prescindono dall’approssimazione della materia. Si tratta quindi di un’anima che designa la nostra capacità di astrarre dal sensibile, cosa che i bambini non sono capaci di fare, ma poi col tempo e con lo sviluppo delle capacità cerebrali imparano. L’anima di Platone è dunque un espediente metodologico per inaugurare un tipo di conoscenza costruita con numeri e idee, e non con sensazioni e impressioni, in modo che sia valida per tutti e da tutti riconoscibile, come anche la scienza moderna oggi prevede. Un’anima iscritta nel registro della conoscenza e della ricerca della "verità" e non della "salvezza", come invece poi faranno i cristiani dopo aver prelevato la parola "anima" dalla filosofia di Platone. Eh sì. Perché anche la tradizione giudaico-cristiana non dispone del concetto di anima. La parola ebraica nefes poi tradotta in greco con psyche e in latino con anima significa semplicemente la vita del corpo. Non si spiegherebbero altrimenti espressioni quali: «Il sangue, questo è la nefes» (Deut. 12, 23), oppure «occhio per occhio, dente per dente, nefes per nefes» (Es. 21, 23). Non si capirebbe cosa intende Sansone quando, sul punto di demolire le colonne del tempio, dice: «Muoia la mia nefes con tutti i Filistei» (Giud. 13, 30) o la proibizione al nazireo di toccare per tutto il tempo della sua consacrazione la nefes met degli animali, che evidentemente non è l’anima morta, ma il cadavere. E qui gli esempi possono continuare numerosi. Valga per tutti l’atto di fede dei cristiani che, quando recitano il Credo, non dicono di credere nell’immortalità dell’anima, ma nella resurrezione dei corpi. Lo stesso Paolo di Tarso non riconosceva alcuna possibilità alla morte, debellata da Cristo una volta per tutte, ma attendeva con fiducia per i cristiani la diretta assunzione in cielo. Di fronte poi all’imprevista morte di alcuni cristiani, l’apostolo è costretto a mutare opinione e a prospettare per i morti la resurrezione e per i sopravvissuti, tra cui annovera anche se stesso, il rapimento in cielo (1 Tes. 4, 15-17). Alla domanda: «Come resusciteranno i morti?» Paolo risponde «con un corpo spirituale (soma pneumaticos) (1 Cor. 15, 43-44). Quando nell’Areopago di Atene Paolo annunciò la resurrezione dei morti, gli Atti degli Apostoli (17, 31-32) ci riferiscono che gli ateniesi gli dissero: «Questa storia ce la vieni a raccontare un’altra volta». Fu Agostino, educato dalla filosofia platonica e neoplatonica, a tradurre il "corpo spirituale" di Paolo in "anima", dopo aver prelevato la parola da Platone, e a fare dell’anima il principio dell’identità personale e il luogo della manifestazione di Dio (In interioritate animae habitat Deus). Da allora, e per tutto il corso della cultura occidentale, valse la persuasione che l’uomo è composto di anima e corpo. L’anima incorruttibile è quindi immortale, e il corpo corruttibile è quindi mortale. «Il colpo di genio del Cristianesimo», che esorcizza la morte garantendo a ogni uomo l’immortalità, è diventato persuasione comune che neppure la scienza è riuscita a scalfire, anzi in un certo senso ha concorso a radicare definitivamente questa convinzione. Infatti nel 1600, con la nascita della scienza moderna, per esigenze metodologiche il corpo fu ridotto a organismo, a pura quantità, a semplice sommatoria di organi, perché solo così poteva essere trattato come tutti gli oggetti da laboratorio su cui ha potere la scienza. Nacque la medicina moderna che, come tutti i malati sanno, non conosce l’uomo che ha di fronte, ma solo il suo organismo. Un secolo dopo, per le malattie di cui non si reperiva traccia nell’organismo, nacque una nuova scienza: la psichiatria, non per lo studio della psiche, ma per dare una collocazione scientifica a quel "morbus sine materia" che era poi la malattia in seguito detta "mentale", perché, nel corpo ridotto a organismo, non si reperiva la traccia somatica. Ecco come si è rafforzato il concetto di "anima" e di quei suoi derivati che presero il nome di "psiche" o "coscienza". Queste parole, poi credute realtà, sono nate per sopperire a un deficit metodologico, per spiegare cioè tutto quello che non si riusciva a spiegare dopo aver ridotto, per le esigenze della scienza, il corpo a pura quantità, a semplice sommatoria di organi. Ora che le parole anima, coscienza, mente sono entrate nel nostro linguaggio e si sono radicate nelle nostre abitudini linguistiche, usiamole pure, ma, ricordandone la loro genesi, evitiamo di pensarle come entità o come sostanze che sopravvivono alla morte del nostro corpo. Perché se proprio vogliamo alla parola anima un significato, l’unico possibile è quello che nomina il rapporto che il nostro corpo (e non il nostro organismo) ha con il mondo, essendo il nostro un corpo impegnato in un mondo dove veicola le sue intenzioni e da cui riceve risposte che poi rielabora per ulteriori azioni, finché è corpo vivente. Estinta la relazione col mondo, il corpo diventa cadavere, e l’anima, questa parola che nomina la nostra relazione con il mondo, si estingue con lui. L’altra questione che percorre le pagine seducenti del libro di Mancuso è la riproposizione della tesi tomista della stretta relazione che esiste tra ragione e fede cristiana, che anche Benedetto XVI non cessa di ribadire senza omettere di precisare che, in caso di conflitto, ad aver torto è naturalmente la ragione in base all’assunto che la fede cristiana coincide con la verità. A questo proposito voglio ricordare che Tommaso d’Aquino, commentando Paolo di Tarso, dice che la fede, a differenza della scienza espressa dalla ragione umana conduce in captivitatem omnem intellectum, cioè rende l’intelletto prigioniero di un contenuto che non è evidente, e che quindi gli è estraneo (alienus), sicché l’intelletto è inquieto (nondum est quietatus) di fronte alla scienza, nei cui confronti si sente «in infirmitate et timore et tremore multo». Dov’è finita questa prudenza tomista che non concede di identificare immediatamente la fede con la verità? E se i cattolici sono già in possesso della verità che senso ha per loro studiare e insegnare filosofia se la verità che la filosofia si propone di cercare già la possiedono? Cosa rispondono ad Heidegger là dove scrive che quando la filosofia è accompagnata da un aggettivo, come è il caso di una "filosofia cristiana" ci si trova di fronte a un circolo quadrato o, come vuole l’espressione di Heidegger a un "ferro ligneo"? E infine che tipo di dialogo è possibile con un cristiano, se questi è già convinto di possedere la verità? A questo punto l’invito di Mancuso, più volte ribadito nel suo libro, di voler aprire un dialogo con i laici riformulando la dogmatica cristiana in una forma compatibile alla razionalità laica è uno stratagemma seducente ma inefficace, o, se proprio vogliamo, una forma di buona educazione che non scalfisce quella che Jaspers chiamava la "minacciosa sicurezza (bedrohende Sicherheit)" con cui i teologi difendono le loro posizioni anche quando si aprono al dialogo che, a questo punto, risulta una pratica inutile. Dopo aver dichiarato di «appartenere alla Chiesa cattolica e insieme di prendere le distanze pubblicamente da alcune parti della dottrina cattolica con tesi solo formalmente eterodosse», Vito Mancuso, con il suo libro, contribuirà senz’altro - e qui gli va dato merito - alla riformulazione della dogmatica cattolica per adeguarla allo spirito del tempo. E così facendo avrà come suoi interlocutori altri teologi, ma mai e poi mai i laici, ai quali non verrà mai voglia di parlare con chi non è disposto a mettere in gioco le proprie convinzioni religiose perché, già prima dell’apertura del dialogo, le assume come indiscutibili verità.
Umberto Galimberti
Umberto Galimberti, nato a Monza nel 1942, è stato dal 1976 professore incaricato di Antropologia Culturale e dal 1983 professore associato di Filosofia della Storia. Dal 1999 è professore ordinario …