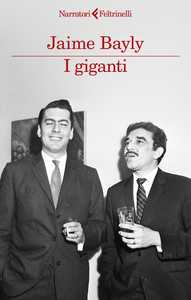Salvatore Natoli: Povere parole senza peso nel tempo della chiacchiera
16 Maggio 2006
Da tempo, in filosofia non si vedono più grandi sistemi. Non solo in filosofia. E ciò non tanto perché quelli che nel succedersi delle epoche sono stati elaborati si siano rivelati erronei o inefficaci - che anzi si sono costituiti come grandi scenari di senso, talmente convincenti da apparire perfino necessari, sono stati schemi di orientamento - ma perché la complessità del mondo si è talmente dilatata che nessun sistema si rivela più capace di contenerla ed è destinato inevitabilmente a fallire. O a forzare e impoverire il reale, che è ancora peggio. Né, allo stato delle cose, hanno ottenuto sorte migliore il rizomatismo, il bricolage in vario modo praticato, la retorica del frammento. Sicché, nell’impossibilità di fare sistema, siamo inevitabilmente condannati alla citazione della citazione, al commento, alla parodia, alla contaminazione, che spesso viene praticata come alibi, come strategia d’aggiramento innanzi a problemi di difficile soluzione. Siamo divenuti ormai tutti alessandrini? Non credo. Ritengo, invece, che nell’inabissarsi delle grandi narrazioni, della filosofia siano rimaste superstiti le parole, affioranti come isole nella corrente. Le parole sopravvivono ai sistemi perché vivono di loro stesse: sono fuochi di memoria, segnali di trasmissione, transiti tra passato e presente, ancoraggi per evitare derive, non certo approdi definitivi, ma porti sicuri nel mare aperto della verità. Le parole, come è noto, sono sapienti di per sé e per questo, ogni volta, prima ancora di pronunciarle bisognerebbe ascoltarle: come all’inizio. Infatti, non sono nostre, ma ci sono state donate, le abbiamo apprese. Perché non suonino vane è necessario che non se ne perda l’eco profonda, che nel dirle si sia ancora capaci di risentirle - quasi a trattenerle - per evitare che con il suono ne svanisca anche il senso. La sapienza delle parole ha preceduto la filosofia e per molti versi l’ha preparata: in essa, poi, le parole sono maturate come frutti, si sono fissate in idee, si sono trasformate in concetti. Variamente definite, hanno acquisito spessore e pur rimanendo le stesse nel corso del tempo sono divenute polisemiche, in taluni casi anche equivoche. Una stratificazione di significati tutta da indagare. Le parole della filosofia, come del resto tutte le parole, sono poi vincolate dalla logica del contesto, ma, ora, nell’attenuarsi dei vincoli di tradizione hanno acquistato una loro singolare libertà perché nessuno ha più l’autorità di sottoporle a una previa restrizione. Non si sono affatto sgravate del passato, ma sono più che mai feconde in forza di quel passato: eccedono se stesse per un sovraccarico di storia che mettono a disposizione senza ipoteche per la più ampia e libera interpretazione. Per fare una buona filosofia basta, quindi, meditare sulle sue parole, seguirle nelle loro peripezie, procedere a una loro dilucidatio, vincolarle di nuovo a più alti e differenziati livelli di definizione. Consapevoli, nel far questo, di prendere decisioni su di esse, di fare, appunto, teoria.
Le parole, poi, sono tradizione e perciò garanzia di continuità pur nella variazione dei significati, sono depositi di sapienza, di filosofia. Ma fare filosofia rielaborando le sue grandi parole ci predispone a qualcosa d’altro e di più decisivo: ci abitua a pensare filosoficamente tutte le parole, a ponderarle. Oggi non esiste più alcun divieto di parola, tutti parlano, anche se spesso finiscono per dire le medesime cose. Ma quanti danno peso a quel che dicono? Eppure le parole, per contare, dovrebbero avere peso. Ma come, quando, quanto pesano? E perchè? Non si può rispondere a queste domande se non ci si mette nelle condizioni di ponderare le parole, di accertare quali significati intenzionano, come si formano i giudizi. Il linguaggio si ammala - Wittgenstein lo aveva perfettamente compreso -; la filosofia dovrebbe esserne la terapia. Analizzare l’impiantarsi delle categorie, considerarne gli spostamenti, le mutazioni semantiche, seguire le parole nelle loro distorsioni e nei loro adattamenti è già rimedio, e conoscenza. Nel tempo della chiacchiera, in un tempo mai come questo lontano dal silenzio, il lavoro sulle parole è esercizio teoretico, ma anche azione morale: lavorare su di esse significa sottrarle all’equivoco, e questo lo si può fare se se ne mostrano, appunto, gli usi equivoci, impropri. E tuttavia può capitare di imbattersi nella distorsione dei «modi propri», nella scomposizione dei canoni ordinari della comunicazione: tutto ciò merita una particolare attenzione perché non è affatto detto che si tratti di patologie del linguaggio, di un uso alterato del termini, di un’improprietà dei concetti, ma, al contrario tutto ciò può essere spia dell’impiantarsi di nuove funzioni semantiche, dell’emergere di riferimenti nuovi, può denotare il prodursi di inedite dimensioni di senso. Capita che le parole non affermino più la realtà, che esauriscano il loro compito, che si logorino, e questo accade in modo particolare quando i sistemi, entro cui esse sono abitualmente definite, custodite, protette, si disfano. E tuttavia proprio in queste emergenze le parole non periscono, piuttosto migrano. Parole migranti, ma cariche di tutta la loro storia e perciò esplosive, riserva illimitata di significati: antiche per concetti nuovi, nuove per riproporre temi antichi, parole, infine, per tenere la rotta, zattere per transitare. Ripensare le parole, infine, vuol dire nutrire una singolare fedeltà al passato, ma tutt’altro che antiquaria: al contrario, è un modo d’equipaggiarsi per non sporgersi sul futuro disarmati.
Le parole, poi, sono tradizione e perciò garanzia di continuità pur nella variazione dei significati, sono depositi di sapienza, di filosofia. Ma fare filosofia rielaborando le sue grandi parole ci predispone a qualcosa d’altro e di più decisivo: ci abitua a pensare filosoficamente tutte le parole, a ponderarle. Oggi non esiste più alcun divieto di parola, tutti parlano, anche se spesso finiscono per dire le medesime cose. Ma quanti danno peso a quel che dicono? Eppure le parole, per contare, dovrebbero avere peso. Ma come, quando, quanto pesano? E perchè? Non si può rispondere a queste domande se non ci si mette nelle condizioni di ponderare le parole, di accertare quali significati intenzionano, come si formano i giudizi. Il linguaggio si ammala - Wittgenstein lo aveva perfettamente compreso -; la filosofia dovrebbe esserne la terapia. Analizzare l’impiantarsi delle categorie, considerarne gli spostamenti, le mutazioni semantiche, seguire le parole nelle loro distorsioni e nei loro adattamenti è già rimedio, e conoscenza. Nel tempo della chiacchiera, in un tempo mai come questo lontano dal silenzio, il lavoro sulle parole è esercizio teoretico, ma anche azione morale: lavorare su di esse significa sottrarle all’equivoco, e questo lo si può fare se se ne mostrano, appunto, gli usi equivoci, impropri. E tuttavia può capitare di imbattersi nella distorsione dei «modi propri», nella scomposizione dei canoni ordinari della comunicazione: tutto ciò merita una particolare attenzione perché non è affatto detto che si tratti di patologie del linguaggio, di un uso alterato del termini, di un’improprietà dei concetti, ma, al contrario tutto ciò può essere spia dell’impiantarsi di nuove funzioni semantiche, dell’emergere di riferimenti nuovi, può denotare il prodursi di inedite dimensioni di senso. Capita che le parole non affermino più la realtà, che esauriscano il loro compito, che si logorino, e questo accade in modo particolare quando i sistemi, entro cui esse sono abitualmente definite, custodite, protette, si disfano. E tuttavia proprio in queste emergenze le parole non periscono, piuttosto migrano. Parole migranti, ma cariche di tutta la loro storia e perciò esplosive, riserva illimitata di significati: antiche per concetti nuovi, nuove per riproporre temi antichi, parole, infine, per tenere la rotta, zattere per transitare. Ripensare le parole, infine, vuol dire nutrire una singolare fedeltà al passato, ma tutt’altro che antiquaria: al contrario, è un modo d’equipaggiarsi per non sporgersi sul futuro disarmati.
Salvatore Natoli
Salvatore Natoli è professore di Filosofia teoretica. Tra le sue opere ricordiamo: Ermeneutica e genealogia. Filosofia e metodo in Nietzsche, Heidegger, Foucault (Feltrinelli, 1980), L’esperienza del dolore. Le forme del …